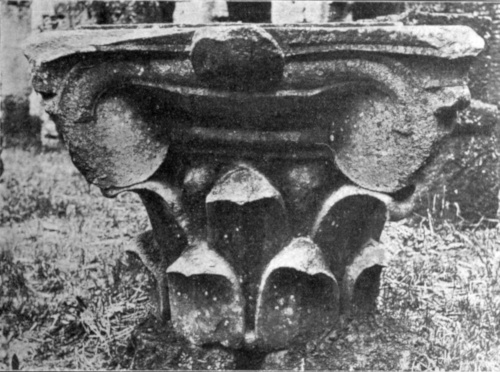
Fig. 1ª.
Title: L'anfiteatro Flavio nei suoi venti secoli di storia
Author: Mariano Colagrossi
Release date: August 1, 2022 [eBook #68663]
Language: Italian
Original publication: Italy: Libreria Editrice Fiorentina
Credits: Barbara Magni and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images made available by The Internet Archive)
Questo ebook è stato creato per celebrare il ventesimo anniversario di Distributed Proofreaders.
P. COLAGROSSI
L’ANFITEATRO FLAVIO
NEI SUOI VENTI SECOLI DI STORIA
(CON 16 ILLUSTRAZIONI E 6 TAVOLE)
FIRENZE
Libreria Editrice Fiorentina
ROMA
Libreria «Propaganda» Quirico Castello
1913
PROPRIETÀ LETTERARIA
Stabilimento Tipografico S. Giuseppe — Via Pandolfini 26, Firenze.
AL R.mo P. PACIFICO MONZA
MINISTRO GENERALE DEI FRATI MINORI
QUEST’UMILE LAVORO
INTORNO AL GRANDE ANFITEATRO
IN CUI L’ILLUSTRE APOSTOLO MINORITA
LEONARDO DA PORTO MAURIZIO
MEDITÒ SOVENTE
ED INSEGNÒ A MEDITARE
LA PASSIONE DI CRISTO
| Prefazione | Pag. 1 |
| Introduzione — Storia generale degli anfiteatri | 3 |
| Parte I. Dalle origini al secolo VI dell’era volgare. | |
| Capitolo Primo. — Edificazione — Dedicazione — Feste inaugurali — Medaglie commemorative — Spese approssimative — Epigrafi | 31 |
| Capitolo Secondo. — Descrizione della parte esterna dell’Anfiteatro Flavio — Dimensioni — Architettura — Materiali usati nella costruzione — Statue — Clipei — Perni e spranghe — Sezione | 41 |
| Capitolo Terzo. — Descrizione dell’interno dell’Anfiteatro Flavio — Arena — Ipogei — Portici sotterranei — Cavea — Velario — Anemoscopio — Architetto | 53 |
| Capitolo Quarto. — Spettacoli celebrati nell’Anfiteatro Flavio dall’inaugurazione al secolo VI, ed abolizione dei medesimi | 103 |
| Capitolo Quinto. — L’anfiteatro Flavio danneggiato e restaurato | 125 |
| Parte II. Dal Secolo VI al Medio Evo. | |
| Capitolo Primo. — Il Colosseo — Origine di questa voce | 135 |
| Capitolo Secondo. — Il Colosseo nel suo abbandono e poscia convertito in fortezza feudale | 147 |
| Capitolo Terzo. — Il Colosseo nelle mani del Senato Romano — Giostre in esso celebrate | 158 |
| Capitolo Quarto. — Il Colosseo danneggiato dal terremoto (a. 1349) — L’arciconfraternita di «S. Sanctorum nel Colosseo | 163 |
| Parte III. Dal secolo XV ai tempi presenti. | |
| Capitolo Primo. — Varie vicende del Colosseo nei secoli XV e XVI — Travertini asportati — I Papi e il Colosseo — Drammi sacri — Chiesa della Pietà — Chiesa di S. Giacomo — Ospedale — Altre Chiese ed oratorî che circondarono il Colosseo — Sisto V | 171 |
| Capitolo Secondo. — Il Colosseo nel secolo XVII | 213 |
| Capitolo Terzo. — Il Colosseo nel secolo XVIII | 217 |
| Capitolo Quarto (secolo XIX). — Il Colosseo restaurato e fatti contemporanei ivi avvenuti | 223 |
| Capitolo Quinto. — Scavi eseguiti nell’Anfiteatro Flavio dal 1810 sino ai nostri tempi | 231 |
| Parte IV. Controversie sull’Anfiteatro Flavio. | |
| Capitolo Primo. Quest. 1ª. — Nella dedicazione dell’Anfiteatro Flavio, ove si celebrarono le naumachie? | 245 |
| Capitolo Secondo. Quest. 2ª. — Quali soggetti erano rappresentati nei clipei? — Come erano questi disposti? — Quanti erano? | 257 |
| Capitolo Terzo. Quest. 3ª. — L’Anfiteatro Flavio e i Martiri | 265 |
| Capitolo Quarto. Quest. 4ª. — L’iscrizione «Sic premia servas è genuina o falsa? | 285 |
| Appendici. | |
| I. — La flora del Colosseo | 337 |
| II. — Iscrizioni e frammenti epigrafici | 347 |
[1]
La grandezza e magnificenza dell’antica Città dei Cesari risplendono tuttora nei suoi maestosi ruderi; e gli avanzi del maraviglioso ANFITEATRO FLAVIO, di cui m’accingo a trattare, ce ne sono una fulgida prova.
Gli incendî, i terremoti, i saccheggi, le fazioni medioevali, le prepotenze dei baroni, la lontananza del Papa dalla sua sede, gli sconvolgimenti politici, fecero disgraziatamente sparire un gran numero di monumenti romani; ma la venerabile mole dei Flavî resistè, almeno in parte, alle ingiurie dei tempi e degli uomini; e come in altre epoche il Colosseo fu l’oggetto nobile di profondi studî, così stimo debba esserlo ai giorni nostri in cui si nota tanto risveglio per le cose antiche.
La prima lezione di archeologia pratica, io la ricevei nell’ANFITEATRO FLAVIO, e, a dire il vero, rimasi tanto ammirato della sua storia e grandiosità, che fin da quel momento sorse in me il desiderio di farlo oggetto di un mio studio speciale, e di rendere un contributo a quella mondiale maraviglia. E quel desiderio vago, concepito anni or sono, è divenuto oggi una realtà.
Onde evitare frequenti e forse inutili annotazioni nel corso dell’opera (specialmente quando si tratterà delle varie parti che costituiscono l’Anfiteatro Flavio e dei ludi ivi dati dagli Imperatori), m’è sembrato conveniente far precedere allo studio sul Colosseo una storia sommaria degli anfiteatri in genere e dei giuochi venatorî e gladiatorî in ispecie.
[2]
Relativamente alle memorie cristiane che sono connesse col nostro monumento, io le tratterò con franchezza e lealtà; ed esporrò le mie opinioni senza curarmi nè della congiura «del silenzio» nè della taccia «d’ignorante ed ostinato», perchè tanto l’una che l’altra sono armi ormai notissime di coloro i quali «tanto più dan vanto di sapiente» ad uno scrittore, «quanto più (questi) si mostra audace nel distruggere l’antico, nel rigettare la tradizione, ecc.»[1].
Onde poi la discussione delle principali controversie sórte in più epoche sull’Anfiteatro Flavio, non interrompa il filo della narrazione, e non distragga soverchiamente il lettore, ho creduto cosa utile trattarle separatamente nella IV parte di questo studio.
Le numerose piante, finalmente, o la famosa flora del Colosseo; nonchè i frammenti epigrafici rinvenuti nel nostro Anfiteatro, formeranno il soggetto di due rispettive appendici.
[3]
«Il mondo vinto, scrisse Giovenale, si è vendicato dando a Roma tutti i vizî».
Triste ma incontestabile verità! Prima infatti che la romana Repubblica soggiogasse l’Oriente, i costumi del suo popolo erano semplicissimi; la guerra e l’agricoltura formavano la sua precipua occupazione, e spesse volte gli stessi magistrati, i consoli, i dittatori, ecc., spirato il tempo della loro carica, deponevano la toga e tornavano a coltivare i loro poderetti. Ma eccoci alle guerre Puniche! Eccoci alle guerre Macedoniche! Roma conquista progressivamente le province orientali; e, a misura che essa s’avanza nelle conquiste, di pari passo degenera la semplicità dei costumi del suo popolo. Colle nuove genti vengono in Roma le ricchezze; colle ricchezze i vizî.
Ma l’oro ed il lusso erano un privilegio dei soli nobili: di quei nobili, che, inviati a governare le conquistate regioni, tornavano in patria carichi di ricchezze e sfoggiando un eccessivo lusso orientale. Il basso popolo, immiserito, cencioso, ozioso, a causa dei grandi latifondi, addivenne la piaga di quel tempo. Alle oneste occupazioni preferì tosto i divertimenti ed i passatempi; all’agricoltura la sphaeromachia[2], la mora[3], gli scacchi[4], ecc.; e principiò [4] a maggiormente bramare gli spettacoli pubblici, ed a reclamarli con esigenza, ritenendoli come istituzione sacra e di somma importanza. I governanti accondiscesero alla brama popolare, ed i nobili ambiziosi approfittarono, molto bene ed a loro pro, di questa congiuntura: i primi si servirono degli spettacoli come macchina della lor politica, ed i secondi per cattivarsi il favor popolare, carpire magistrature, ricche province ed autorità sul popolo.
Turbe immense accorrevano entusiaste agli spettacoli circensi, pei quali nutrivano special predilezione; e gli stessi giovanetti prossimi alla pubertà[5] abbandonavano volentieri il loro turbo (trottola) ed il trochus, o smettevano di gettare in aria la moneta sulla quale eravi effigiata, per lo più, la testa di Giano in un lato, ed una nave nell’altro[6], per recarsi al circo ad aprire la pompa.
Giovenale ci descrive i costumi dei suoi tempi: nota in peculiar modo questo sfrenato gusto del popolo romano, e dice che quelle stesse masse le quali un dì affidavano il comando, i fasci, le legioni, restrinsero poi i loro desideri al pane ed agli spettacoli circensi[7].
Ma se i romani trovarono nel circo il loro preferito diletto, non trascurarono però le gare atletiche, il teatro, gli spettacoli gladiatorî, nè, molto meno, le venationes, le quali, come in breve vedremo, diedero origine agli anfiteatri. Di questi il più famoso è il FLAVIO (oggetto, come dicemmo nella prefazione, di questo lavoro), le cui memorie storiche e monumentali, dalle origini ai tempi presenti, prenderemo ad esporre, dopo aver data una nozione storica e sommaria sugli anfiteatri in genere, sullo scopo della loro invenzione e sui pubblici spettacoli che in essi si solevano dare.
***
Fra gli edifizî destinati ai pubblici spettacoli, l’anfiteatro fu, per ragione di tempo, l’ultimo. La voce anfiteatro è di origine greca, sebbene non i Greci ma i Romani ne siano stati gl’inventori. Gli antichi si servirono dell’anfiteatro [5] per i giuochi gladiatorî e per le venationes; ma queste e non quelli furono la causa della sua invenzione. Prima che gli anfiteatri esistessero, i gladiatori davano già i loro spettacoli; e la costruzione del più celebre degli ANFITEATRI fu intrapresa da un imperatore che non amava i gladiatori[8]. Niuno pensò a Roma a tal sorta di edifizî, fino a che la conquista di remoti paesi, la potenza e le ricchezze non eccitarono nell’animo dei Romani il desiderio di possedere incognite belve e di vederle ferocemente combattere.
L’anno 502 d. R., L. Cecilio Metello, Proconsole e Pontefice, riportava una clamorosa vittoria sui Cartaginesi. Palermo fu il teatro della battaglia; e, nella disfatta, il vincitore s’impadronì di 142 elefanti, i quali furono condotti in Roma ed introdotti nel Circo Massimo, a quei tempi unico edifizio, tra i destinati agli spettacoli, men disadatto degli altri per quella pericolosa e gigantesca rappresentazione. Gli elefanti furono uccisi a colpi di strale; e se il fatto potè attrarre l’attenzione pubblica, altro non fu, a mio parere, che per la novità della cosa. Quello spettacolo, infatti, non fu una caccia, venatio, ma un macello. I Romani, d’altra parte, volevano sbarazzarsi di tanto peso: il nutrimento e la custodia di quelle bestie colossali gravavano non lievemente l’erario pubblico; e vollero, inoltre, abituare la plebe a vedere quelle moli, che sovente doveano combattere a campo aperto. Questa circostanza fu nondimeno capace di muovere nell’animo del popolo il trasporto per le venationes; e più tardi, nell’edilità di Claudio Pulcher, secondo Plinio[9], o ai tempi di Pompeo, secondo Seneca[10] ed Asconio[11], principiarono le cacce elefantine.
La caccia di altre bestie fu introdotta dopo la seconda guerra Punica[12]. Tito Livio[13] ci dice che lo spettacolo degli atleti e la caccia dei leoni e delle pantere si videro in Roma, per la prima volta, nell’anno 568; nei giuochi, cioè, dati da M. Fulvio Nobiliore per un voto da questo fatto nella guerra contro gli Etoli. Da allora in poi s’importarono dall’Africa innumerevoli belve le quali, senza distinzione di specie, si dissero africanae[14]. Lo stesso storico[15] ci narra le solenni feste celebrate nel 586 d. R. dagli edili curuli Nasica e Lentulo.
[6]
Frattanto erasi introdotto presso i Romani l’uso cartaginese di esporre alle belve i disertori stranieri. Scipione Africano minore, imitando Emilio Paolo, suo padre, diè giuochi, nei quali espose alle belve disertori e fuggiaschi[16]; e questo fatto ci viene confermato da Valerio Massimo[17]. Questa pena fu poscia estesa, nelle province, anche ai cittadini romani[18].
La magnificenza delle venationes andò progressivamente crescendo. Quegli che dava uno spettacolo, ambiva sorpassare nella sontuosità chi avealo dato precedentemente. Scevola, nella sua edilità, celebrò per primo la caccia di molti leoni[19], i quali furono esposti nel circo, legati; perchè, essendo questo per sua natura indifeso, la ferocia di quelle belve poteva produrre funesti accidenti. Il primo che diè mostra di leoni sciolti fu Silla nell’anno 660 d. R.[20]. È da credersi nondimeno che a tutela degli spettatori si costruissero provvisori ripari, dacchè sappiamo che quando Pompeo, per festeggiare la dedicazione del suo teatro, diè un combattimento con elefanti, questi furono esposti nel circo racchiusi entro cancelli di ferro: e guai se così non si fosse fatto! Gli elefanti inaspriti per l’uccisione di uno di loro, tentarono di erompere in massa con grande sgomento e spavento di tutto il popolo[21]. Talchè Cesare, dieci anni dopo, nell’inaugurazione del suo Foro, volendo dare venationes ed un combattimento cogli elefanti, a maggior difesa degli spettatori fece scavare attorno al circo un euripo[22].
Nel 695 d. R. Scauro mostrò per la prima volta un ippopotamo e cinque coccodrilli, pei quali fece scavare un canale a bella posta[23]. Nel 698 il suddetto Pompeo, a fine di festeggiare la dedicazione del suo teatro, espose 500 leoni, i quali tutti rimasero uccisi.
Essendo giunta tant’oltre la magnificenza di questi spettacoli, e divenendo ogni dì più comuni; poichè gli edifici destinati ai giuochi, come i circhi ed i teatri, non presentavano per le cacce l’opportuna comodità, e d’altronde non offrivano la sicurezza necessaria agli spettatori[24]; fu d’uopo immaginare un [7] nuovo edifizio che unisse la sicurezza e la comodità del teatro per gli spettatori all’ampiezza ed alla vastità del circo per gli spettacoli; vastità che doveasi anch’essa ridurre in modo che più circoscritta ne fosse l’arena. Fu allora che Cesare, ispiratosi alla novità di Curione, assai per fermo adatta allo scopo, uno ne costrusse di legno[25], l’anno 708 d. R. allorchè fè celebrare varî giuochi onde solennizzare la dedicazione del suo Foro e del tempio di Venere genitrice[26].
Volendo Curione[27] sorpassare Scauro nell’artifizio, giacchè non poteva sorpassarlo nella sontuosità dei giuochi di recente celebrati[28], costrusse due grandi teatri lignei, l’uno vicino all’altro[29]. Terminate le rappresentazioni drammatiche e mimiche, e tolte le scene, questi due teatri si facevano girare con tutti gli spettatori, sopra i rispettivi cardini[30]: chiudevansi insieme, ed unendosi ambedue gli emicicli, formavano un teatro circolare, la cui arena presentava un vasto campo, attissimo a celebrarvi gli spettacoli gladiatorî. Meccanismo maraviglioso! Plinio[31], non lontano da quell’epoca, oltremodo meravigliato ed attonito, confessa di non sapere se meritasse più ammirazione il genio dell’inventore o il ritrovato; l’artista o chi lo eseguì; il coraggio di chi l’ordinò o l’imperturbabilità del popolo Romano, il quale si sottomise ad un tanto azzardato esperimento[32]. È inutile ricordare che questa macchina agì per soli due giorni: il terzo dì non si osò farla di nuovo girare; e, lasciati i due emicicli congiunti, si costruirono in mezzo ad essi le scene [8] temporanee, le quali poi si disfecero, restando fermi gli spettatori. Questa novità di Curione, cui s’ispirò Cesare, questo ligneo edificio diè l’idea primiera del Teatro venatorio[33] o Romano ANFITEATRO.
***
Il nome e la cosa ebbero origine ad un tempo. Calpurnio lo disse ovum[34]; Strabone e Dionisio, ambedue dell’epoca augustea, lo chiamarono anfiteatro; e di questa stessa voce si servì Vitruvio[35]. Ovidio[36] scrisse:
.... structoque utrimque theatro
Ut matutina cervus periturus arena.
Dione: Theatrum venatorium quod et Amphitheatrum dictum est ex eo quod sedes undique in orbem habeat sine ulla scena[37]. E Cassiodoro: Cum theatrum quod est hemisphaerium, grecae dicatur Amphitheatrum, quasi in unum juncta duo visoria, recte constat esse nominatum. Ed altrove: Ovi speciem eius arena concludens....
All’anfiteatro ligneo eretto da Cesare, ne seguì uno di pietra edificato da T. Statilio Tauro[38] nel Campo Marzio; e successivamente ne vennero edificati altri in Roma, nei municipî, nelle colonie italiche ed in altre città dell’Impero[39]. Statilio Tauro eresse il suo anfiteatro per suggerimento di Augusto, il quale avea progettato l’edificazione di uno che fosse degno della metropoli del mondo, e pensato di erigerlo media urbe[40]: progetto più tardi effettuato da Fl. Vespasiano. In Roma, per molto tempo, vi fu il solo anfiteatro di Statilio Tauro[41]. Caligola principiò a costruirne un altro, ma non lo portò a compimento[42]. Nerone ne edificò uno di legno[43].
[9]
L’anfiteatro fu adunque un’invenzione del tutto romana[44]; e lo scopo principale e primario di questo edificio fu la venatio; il secondario, gli spettacoli gladiatorî[45].
Ed ora, prima di dare un cenno sommario di questi spettacoli, crediamo opportuno presentare ai lettori un quadro generale delle parti costituenti un anfiteatro, riservandoci di parlarne più minutamente allorquando tratteremo dell’ANFITEATRO FLAVIO.
***
Le parti esterne di un anfiteatro consistevano nelle arcuazioni che formavano i portici; questi poi servivano per la comoda comunicazione tra le gradinate dei diversi piani, e per riparo agli spettatori in caso di pioggia. I portici constavano: 1º di corridoi, ambulacra; 2º di accessi in piano alle scale, itinera; 3º di scale, scalae.
Le principali parti interne erano: l’arena e la cavea. La prima avea forma ovale, ed alle estremità dell’asse maggiore s’aprivano grandi porte per l’introduzione delle fiere nella mostra precedente il periodo dei giuochi, pel solenne ingresso della pompa gladiatoria e per l’estrazione dei caduti nella lotta.
L’arena degli anfiteatri era generalmente pensile, e nei sotterranei, hypogaea, v’erano le celle per le belve, e vi si facevano manovrare le macchine, pegmata, per gli improvvisi spettacoli[46].
[10]
La cavea era la parte ove sedevano gli spettatori. La sua forma era concava o ad imbuto[47]. Nei maggiori anfiteatri la cavea dividevasi in podium, gradatio[48] e porticus: in questi la gradatio era divisa in più ordini dalle praecinctiones, secondo l’altezza dell’edificio; nei minori, in podium e gradatio indivisa.
Il podium era il terrazzo che circoscriveva immediatamente l’arena; ed essendo la parte più prossima allo spettacolo, era altresì la parte più distinta. Elevavasi dall’arena tra i 7 e i 12 piedi; era fornito di parapetto, e difeso dagli assalti delle fiere per mezzo di reti metalliche e di altri artificiosi ordigni.
L’Imperatore, la famiglia imperiale, i principali magistrati, le vergini Vestali, il pretore e l’editore dei giuochi prendevan posto nel podium (spectabant ad podium), il quale era elegantemente ornato.
[11]
Le praecinctiones, zone verticali, a piè delle quali girava un viottolo, iter[49], dividevano la gradatio in ordini diversi, i quali a misura che s’allontanavano dal podium divenivano meno distinti, ed erano occupati con un certo ordine gerarchico.
Prima della legge Roscia tutti gli spettatori sedevano alla rinfusa[50]. Plutarco dice che ai tempi di Silla anche le donne sedettero miste cogli uomini, ma che poi Ottaviano le separò, e volle che sedessero nel luogo più elevato[51], e quindi più appartato dall’arena.
Vomitoria erano le aperture o porte per le quali il popolo sboccava su i gradus o sedili.
Scalaria venivano detti i piccoli gradini corrispondenti ai vomitoria, pei quali gli spettatori poteano comodamente salire o scendere, onde collocarsi sui rispettivi sedili: e poichè i vomitoria erano disposti a scacco, e lo spazio fra tre scalaria costituiva un cuneus, perciò si designò col nome di cuneus ciascuna delle grandi sezioni della cavea.
I posti si distinguevano fra loro per una linea che trovavasi nei sedili stessi, ed il luogo assegnato dicevasi locus. Per evitare ogni possibile confusione, ciascuno spettatore dovea premunirsi di una tessera d’ingresso, la quale presentavasi ai designatores: a quegli ufficiali, cioè, che si trovavano in ciascun vomitorium. Nella tessera indicavasi il cuneus, il gradus, ed il posto o i posti da occuparsi; così, p. e., CVN. III. GRAD. IV. LOC. I.
I falliti e coloro che aveano disperse le loro facoltà, venivano confinati in luogo separato[52].
I sedili spettavano a coloro i quali li occupavano, purchè appartenessero al rispettivo ordine gerarchico; ma lasciati, anche per breve tempo, perdevansi. Ciò si deduce chiaramente dalle parole che Augusto diresse ad un cavaliere romano. Io, disse questo Imperatore, quando voglio desinare, me ne vado a casa. Il cavaliere rispose: Tu puoi farlo, perchè non temi ti venga da altri occupato il posto[53].
Era severamente proibito ai graduati assistere agli spettacoli senza indossare l’abito che noi diremmo di etichetta[54]. I semplici cittadini doveano indossare la toga. Si riteneva per cosa indecente il bere mentre celebravansi [12] spettacoli anfiteatrali[55]; e Lampridio dice di Commodo esser questo stato uno spudorato, precisamente perchè soleva bere nell’anfiteatro.
Gli spettatori sedevano su appositi assi lignei, stesi sui gradi di pietra. Ai tempi di Caligola i Senatori usarono cuscini, onde non sedere sulla nuda tavola[56]. Più tardi i Senatori sederono sulle seggiole, e i loro cuscini passarono agli Equites. Augusto sedè su di una sedia curule[57]: Tiberio e Seiano usarono sedie dorate[58].
La forma di queste sellae si vede in molte medaglie; la materia ce l’indica Orazio[59], il quale le dice «curule ebur», d’avorio; esse competevano a varie dignità[60].
Seneca[61] rammenta che dal fondo dell’anfiteatro si facevano salire fino alla cima liquidi odorosi, i quali schizzando in aria, spargevansi a guisa di minutissima pioggia. Queste effusioni si dissero sparsiones, o, come leggesi presso l’altro Seneca[62], pioggia profumata.
Gli spettatori venivano riparati dai raggi del sole da tende, vela; e queste costituirono poi il famoso velarium, di cui ben presto parleremo.
***
Gli spettacoli che si celebravano nell’anfiteatro facevano parte, come tutti gli spettacoli, della religione pagana; ed erano sacri: la caccia a Diana[63], [13] i combattimenti gladiatorî a Marte[64]. Prudenzio chiama i ludi gladiatorî triste sacrum.
Negli spettacoli venatorî i combattenti dicevansi venatores e bestiarii, e quegli che dava i giuochi appellavasi editor o munerarius o munerator. I questori, i pretori, e specialmente gli edili, nell’epoca della Repubblica, onde cattivarsi, come dicemmo, la benevolenza del popolo e quindi poter ascendere più agevolmente a più alte cariche, furono coloro che più particolarmente davano tali spettacoli. Durante l’Impero furono celebrati dagli Imperatori e da quei che venivano promossi al consolato. I magistrati tanto al tempo della Repubblica che dell’Impero imponevano tasse alle province per affrontare le spese dei giuochi che si celebravano in Roma. Cicerone esimè [14] l’Asia da questa tassa[65]. Non di rado i ricchi lasciarono in testamento legati per la celebrazione di cotesti spettacoli; e questi legati entravano nella categoria di quelli che dicevansi ad honorem civitatis[66].
Tra le occasioni in cui davansi questi giuochi, alcune erano ordinarie o di data certa; straordinarie o di data incerta altre. Le prime erano: il natale dei Cesari[67] e l’anniversario di qualsiasi fausto avvenimento[68]. Le seconde: l’assunzione all’Impero od al Consolato; la dedicazione di un pubblico edifizio[69]; pro salute Caesaris[70]; le nozze di questo[71]; la partenza dell’Imperatore per la guerra; la vittoria, il trionfo, i funerali di un personaggio ragguardevole, ecc. Opportuni AVVISI o EDITTI, notificavano al popolo l’ordine dei giuochi, il motivo ed il giorno della loro celebrazione[72].
[15]
Le belve per gli anfiteatrali spettacoli romani provenivano dalle province dell’Impero, ed anche da paesi stranieri. Gli orsi si traevano dai boschi della Caledonia e della Pannonia; i leoni e le pantere dall’Africa[73], e specialmente dalla Numidia: la quale regione, al dire di Plinio, non rendeva altra cosa di qualche importanza che il marmo numidico e le belve[74]. Le tigri provenivano dalla Persia; i crocota (Κροκωτά) ed il rinoceronte dall’India; e dall’Egitto i coccodrilli e gli ippopotami.
La caccia delle belve facevala quei che aveva in animo di dare gli spettacoli; ma poichè erano gli Imperatori coloro che soventemente celebravano le venationes, questi stipendiavano a tal uopo un gran numero di venatores, i quali dovevano curare di prendere le belve senza danneggiarle. Prese che fossero, venivan consegnate ai mansuetarii, i quali le conducevano in Roma, le domavano, le custodivano ed ammaestravano. Una classica testimonianza di questi ammaestramenti l’abbiamo in Marziale[75]:
Picto quod iuga delicata collo
Pardus sustinet, improbaeque tigres
Indulgent patientiam flagello:
Mordent aurea, quod lupata cervi,
Quod frenis libyci domantur ursi
Et quantum Calydon tulisse fertur
Turpes esseda, quod trahunt bisontes,
Et molles dare iussa, quod choreas
Nigro bellua nil negat magistro:
Quis spectacula non putet deorum?
Haec transit tamen, ut minora quisquis
Venatus humiles videt leonum,
Quos velox leporum timor fatigat,
Dimittunt, repetunt, amantque captos
Et securior est in ora praeda;
Laxos cui dare perviosque rictus
Gaudent et timidos tenere dentes;
Mollem frangere dum pudet rapinam:
Stratis cum modo venerint iuvencis.
Haec clementia non paratur arte,
Sed norunt, cui serviant leones.
Da questi versi vediamo chiaramente quale accurata diligenza si ponesse ai tempi di Domiziano nella celebrazione dei giuochi anfiteatrali; ed inoltre [16] vediamo (il che si legge in altri epigrammi di Marziale) che non sempre, negli anfiteatri, si rappresentarono scene sanguinose. È certo però che i custodi, mansuetarii, sapevano, con altri modi e quando faceva d’uopo, far montare le fiere in furore[76].
Le belve si facevano pervenire in Roma in carri ed in barche, legate o racchiuse in gabbie, secondo la loro fierezza[77]; e per pedaggio v’era un dazio del 40%[78].
I Senatori erano esenti da questo dazio; e Simmaco[79] reclama e dice che il dazio dovrebbe gravare i soli negozianti e speculatori.
Nei graffiti scoperti il 1874 nell’Anfiteatro Flavio, come pure nel bassorilievo Torlonia[80] ed in un musaico del Museo Gregoriano e negli stucchi del sepolcro Pompeiano di Scauro, nonchè in diversi altri monumenti, le belve sono rappresentate avvinte da una lunga e forte corda, od attaccate ad un anello fissato in terra, o strette da una duplice fascia, che cinge alle medesime il petto e la parte anteriore del ventre.
Il trasporto delle fiere si faceva in carri pubblici; e, se questi non erano sufficienti, s’usavano pur anche carri privati[81].
Il già citato Claudiano ci riferisce la difficoltà che incontravasi nell’imbarcare le fiere; difficoltà, però, chè abilmente superavasi dagli agili mansuetarii.
[17]
Gli elefanti ed i leoni si spaventavano con le fiaccole: anzi i primi rimanevano atterriti udendo il grugnito del porco, ed i secondi riconducevansi nella cavea facendo velocemente voltar direzione alle ruote di un curricolo[82].
Giunte le fiere alla loro destinazione, l’editor era in dovere di depositarle in luogo sicuro, od anche in casa sua[83]. In Roma s’era costruito un recinto a questo scopo, e si disse vivarium[84], perchè conteneva o racchiudeva belve vive. Il vivarium era un ampio recinto, con celle per le bestie feroci, e con campi e selve per il nutrimento (pascolo) dei cervi, delle damme, delle lepri ecc.[85], che doveano esibirsi nei giuochi. Il famoso e grande vivarium romano era presso la porta Prenestina[86], ed era custodito dai militi delle coorti pretorie ed urbane. Ciò lo rileviamo da un’epigrafe scoperta in Roma l’anno 1710, che porta la data consolare dell’anno 241 dell’età nostra[87].
Le belve si trasportavano dal vivarium all’anfiteatro racchiuse in gabbie: il dì antecedente allo spettacolo si esponevano alla pubblica vista, perchè il popolo traesse idea della fierezza, rarità e numero di esse; e, al principiare dei giuochi, venivano introdotte colle stesse gabbie nei sotterranei.
Gli spettacoli venatorî rappresentavano punti molto variati: voli, scene mitologiche, Orfeo attraente le belve, Prometeo al Caucaso, ecc.; e talvolta l’arena cangiavasi repentinamente in selva o sprofondavasi in una voragine, donde uscivano fiere. Strabone parla di un ladro siciliano, il quale, essendosi fatto chiamare figlio dell’Etna, fu posto su di un’alta macchina raffigurante il monte Etna. Caduta ad un tratto la macchina (pegma), il reo precipitò fra le gabbie delle fiere, le quali pareva covassero in quel monte, e ne fu lacerato.
[18]
Le venationes non sempre, come già si disse, erano cruente. Spesso bestie innocue, come lepri, cervi, damme ecc., lottavano tra di loro; talvolta mettevansi insieme bestie di questa natura con quelle di un istinto più fiero, come: leoni, tori, ecc.[88]; ma così ammaestrati a non nuocere, che recava vera maraviglia agli spettatori. Marziale[89] più volte ricorda il giuoco di una lepre che, inseguita da cani, rifugiavasi nell’aperta gola di un leone, senza che questo le recasse danno (?). I leoni s’avvezzavano a sostenere delicati gioghi sul collo; le feroci tigri, i cervi e gli orsi della Libia s’assuefacevano al freno ed al flagello, quasi fossero cavalli; i cignali della Caledonia si lasciavano legare al collo ed alla bocca; i bisonti traevan carri, e l’elefante ballava ai cenni del suo nero maestro[90]. Nerone, nei giuochi che diede in onore di sua madre, fece venire un elefante funambolo, che s’innalzò fino al portico superiore del suo ligneo anfiteatro; cioè a 25 tese, camminando in cadenza sulla corda, e recando un uomo sulle spalle[91].
Ma se questi spettacoli erano alle volte incruenti, non di rado divenivano pur anche sanguinosi. Spesso, mentre le belve lottavano fra loro, si facevano attaccare dagli uomini. In questo caso, i venatores, ben armati ed istruiti dal loro magister, a piedi od a cavallo, vestiti di sola tunica[92], col braccio sinistro difeso da un panno che l’avvolgeva, inseguivano la belva; e con aste o spade, o scoccando strali, davan mostra della loro arte e del loro coraggio[93].
[19]
La venatio era ordinariamente un’intrapesa libera e volontaria; ma spesso i padroni punivano i servi colpevoli, e la pubblica autorità i delinquenti, facendoli discendere sull’arena e pugnare colle fiere; e se essi erano rei di delitti gravissimi e capitali, venivano esposti alle stesse fiere legati ed inermi. Così uno di essi fu, sotto le sembianze di Laureolo, esposto ad essere sbranato da un orso; ed un altro sotto quelle di Prometeo, fu esposto alla rapacità di un avvoltoio.
La caccia delle belve precedeva in ordine tutti gli altri spettacoli anfiteatrali: quindi davasi ordinariamente il mattino[94]. Durante la pugna, teneri garzoncelli rimovevano l’insanguinata sabbia sparsa sull’arena: e Marziale[95] racconta che un giorno due di questi fanciulli vennero divorati da un leone, dimentico degli ammaestramenti ricevuti!
Nam duo de tenera puerilia corpora turba,
Sanguineam rastris, quae renovabat humum,
Saevus et infelix furiali dente peremit:
Martia non vidit maius arena nefas!
I cadaveri dei venatores e dei gladiatori venivano condotti allo spoliarum, facendoli uscire dalla porta libitinaria. Così si celebravano le venationes fino all’epoca costantiniana; dopo quel tempo si moderarono in guisa da bandire quanto sapesse di crudeltà: gli spettacoli si ridussero a semplici apparenze e ad una caccia sicura, e seguitarono a celebrarsi in questo modo fino al secolo VI[96].
***
Abbiamo detto che i Romani si servirono degli anfiteatri per celebrarvi pur anche gli spettacoli gladiatorî. Diamo adunque pur di questi un cenno sommario e generale.
L’uso dei sanguinosi e barbari combattimenti gladiatorî venne in Italia dalla Lidia (Asia Minore). Ebbero origine dal crudele costume di scannare i prigionieri sulle tombe dei defunti eroi. Nei funerali di Patroclo furono uccisi dodici adolescenti troiani[97]; ed a placare le anime degli Etruschi, quei di Tarquinia immolarono 307 soldati romani caduti prigionieri[98].
[20]
Per temperare l’orrenda inumanità di quest’atto, si permise poscia che i prigionieri combattessero fra loro presso la suddetta tomba fino ad esalare su di essa il loro spirito. Ritenevasi ciò per un dovere dei vivi verso i morti; perciò questa lotta si disse munus, e l’editore munerarius: munus dictum est ab officio . . . . officium autem mortuis hoc spectaculo facere se veteres arbitrabantur[99]. L’asserzione di Tertulliano vien confermata da Servio[100]; ed è perciò indiscutibile che presso i popoli s’immolassero gli uomini, non soltanto agli dei, ma eziandio ai defunti.
Nel 496 d. R. i due fratelli Bruti, per onorare la memoria del loro padre, diedero, nei funerali di questo, siffatti spettacoli[101]. Seguendo l’esempio dei Bruti, simili ludi cruenti si celebrarono poscia per onorare la memoria di altri illustri personaggi, e man mano si estesero anche ai funerali di persone private; e vi fu chi giunse a tal estremo da lasciar per testamento agli eredi l’obbligo di dare questi ludi.
I giuochi gladiatorî si celebrarono anche per rappresentare l’uso dell’armeggiare e di pugnare di altre nazioni o di un corpo militare; ma finalmente si ridussero anch’essi a spettacoli di semplice divertimento. La loro celebrazione fu allora affidata ai magistrati, cioè: ai Pretori, agli Edili, e, all’epoca dell’Impero, ai Questori. Anche i privati davanli sovente a proprie spese[102].
Anche i gladiatori come i venatores, spesso si dedicavano volontariamente a tal mestiere[103], mediante patti particolari concernenti il tempo del servizio e la retribuzione; e chi gl’ingaggiava era in dovere di alimentarli con cibo abbondante, onde potessero acquistare le forze necessarie all’arte loro, dabantur in saginam[104]. Appositi maestri insegnavano ad essi i diversi generi di [21] combattimenti, habebant doctores et magistros, i quali erano per lo più gladiatori emeriti, e venivan detti lanistae[105]: i discepoli dicevansi bustuarii[106]. Oltre al lanista, in ogni collegio, ludus[107], v’era il procurator ed il medicus.
Fra i gladiatori s’iscrissero eziandio persone libere e primarî cittadini, i quali, o per aver dilapidato il loro patrimonio, o per fare cosa grata ai principi, abbracciavano quella barbara professione. Ricevevano essi un determinato salario, detto auctoramentum, laonde furono soprannominati auctorati.
Ma non tutti i gladiatori, ripeto, erano volontarî. Talvolta erano disgraziati prigionieri, vilmente venduti a maestri di scherma; oppure dati agli Imperatori allo scopo di esibirli in siffatti spettacoli; o, finalmente, servi condannati alla pena di morte.
I collegi (ludi) ove dimoravano i gladiatori erano edificî rettangolari, con camere o celle separate e coll’ingresso verso l’interno. Un peristilio della stessa forma avea nel mezzo descritta un’area ovale circondata da sedili. Erano insomma edificati a foggia di piccoli anfiteatri, i quali servivano evidentemente per gli esercizi dei bustuarii.
Negli ultimi tempi della Repubblica i ludi erano così vasti, che Cicerone[108] scrisse ad Attico «Cesare a Capua avere raccolto in un sol ludo 5000 di quella classe di gladiatori appellati secutores». Donde appare quali ingenti spese incontrassero i potenti per stipendiare e mantenere una turba sì enorme; e qual pericolo corresse la Repubblica, allorchè Spartaco, insieme con Crisso, Enomao ed altri trenta; rotto il ludo gladiatorio di Lentulo, in Capua, ed ingrossando man mano la turba di altri gladiatori, schiavi fuggiaschi e scellerati di ogni sorta, pose a soqquadro l’Italia, scorrendola da Capua a Modena, da Modena a Reggio, e minacciando seriamente Roma colla disfatta subita dagli eserciti pretori e consolari.
Allorquando i gladiatori erano per esibirsi in un pubblico combattimento, scrivevan essi il loro nome su tavolette, le quali venivano poscia esposte alla pubblica vista[109]. Nel primo giorno della pugna l’editore dello spettacolo gladiatorio formava le coppie[110]: destinava, cioè, a ciascun gladiatore il suo rivale [22] o particolare avversario. Ciò fatto, prima che i gladiatori venissero alla vera pugna, eseguivano la così detta praelusio[111], vale a dire, schermivano nell’arena con spade lignee, rudibus batuebant[112]. Ad un segno determinato i gladiatori impugnavano l’arma vera, remotis lusoriis armis, e ad decretoria veniebant; prendeva ciascuno la propria posizione, ed avendo lo sguardo fisso alle mosse dell’avversario, s’assalivano a vicenda, alter alterum petens, cercando di scansare possibilmente il colpo vibrato, apta corporis declinatione ictus exibat. Lottando più coppie insieme[113], non di rado accadeva che uno ferisse l’avversario attraverso il fianco di un altro. Allora gridava: habet! oppure hoc habet! è ferito! A questo punto il vinto deponeva le armi, ed alzava le dita della mano destra chiedendo così al principe ed al popolo la missio, ossia il favore di tornare a combattere dopo un giorno di riposo. Per lo più avveniva che il ferito, abbassando le armi, portavasi all’estremità dell’arena e scongiurava il popolo a volergli concedere la vita. Se questo lo voleva salvo, premebat pollicem; al contrario, alzava il pollice se volealo morto. Dietro una crudele negativa del popolo o del Principe, il disgraziato gladiatore ferito, dovea, ad ogni costo, riprendere le armi e proseguire intrepidamente la lotta. Combattendo in tal guisa i due gladiatori Prisco e Vero, con sorte eguale, il popolo, a grandi clamori, chiese per essi la missio. Ma l’Imperatore non volle infrangere la legge: inviò agli spettatori varî doni, onde attendessero con pazienza l’esito del certame; e questo procedè e finì con ugual sorte; giacchè i due gladiatori pugnarono pari, e pari soccombettero: caddero, cioè, ambedue gravemente feriti. Cesare mandò loro le palme e le rudi, premio che, come in breve vedremo, solevasi dare ai gladiatori emeriti[114].
I combattenti distinguevansi fra loro dalle armi e dalla maniera di lottare. I secutores avean per armi la galea (elmetto), il clypeus (scudo) ed una spada (gladius)[115]. Il secutor veniva accoppiato al reziario[116], sicchè ciascun secutore battevasi con un reziario[117]. Questi portava in testa il galerum; e [23] le sue armi erano: una lancia a tre denti (tridens o fuscina) ed una rete[118]. Se gli riusciva di avviluppare nella rete il suo avversario, correva tosto a trafiggerlo col tridente[119], mentre l’infelice secutor, così miseramente avviluppato, procurava liberarsi e difendersi.
I Myrmillones aveano in capo un elmetto gallico, e, per cimiere, l’effigie di un pesce. Per armi usavano uno scudo ed una spada gallica, cioè, senza punta. I loro rivali erano i Thraeces, Trhexes o Traces[120]. Ebbero questo nome perchè usavano le stesse armi ed arnesi dei nativi della Tracia, cioè, la sica e la parma. La sica era un coltello a lama un po’ curva ed a punta acuta; la parma era il piccolo scudo tracio, quadrato nel contorno ma convesso nella superficie[121]. Talvolta il Mirmillone era contrapposto al reziario[122], il quale, durante la pugna, non cessava di ripetere cantando: «Non te peto, piscem peto; cur me fugis, Galle?».
I Samnites[123] aveano per avversarî i Provocatores, detti anche Velites. I primi si dissero eziandio Hoplomachi[124], forse perchè, giusta l’uso dei soldati sanniti, aveano il petto difeso da una spugna[125]; ed erano intieramente [24] armati quasi come legionarî di Roma. Avean per armi: uno scudo d’argento intagliato, ed una spada. Nel braccio destro, che trovavasi indifeso, avevano un bracciale (manica)[126]. Un gambale (ocrea) custodiva e difendeva loro la gamba sinistra[127]: oltre a ciò usavano un cimiero ornato di pennacchi, od un elmo chiuso, con ale (pinnae) ai lati[128], per cui il loro avversario dicevasi Pinnirapus[129].
I gladiatori che, a guisa dei Brettoni, combattevano sui cocchî, ex essedis[130], si dissero essedarii; quelli che cavalcavano bianchi cavalli, ed avevano [25] gli occhi bendati, andabatae[131]; se armati di due spade, si dicevano dymachaeri[132]; quelli finalmente che con un laccio accalappiavano, rovesciavano ed uccidevano l’avversario, chiamavansi laquearii.
I gladiatori mantenuti dagli Imperatori si dissero fiscales[133]; coloro che rimpiazzavano gli stanchi od i vinti, supposititii; i meridiani erano i gladiatori e i venatores superstiti dopo un combattimento, i quali, sull’ora del mezzodì, senza usare arte o difesa, doveano trucidarsi a vicenda[134]; ed i cubicularii eran quelli che lottavano durante i banchetti[135].
I cadaveri dei gladiatori si trasportavano allo spoliarum, trascinandoli agganciati con adunchi uncini. Ivi stesso erano condotti i feriti omai incapaci di battersi; i quali, se si vedeva che non avrebbero potuto sopravvivere alle mortali ferite, venivano irremissibilmente uccisi.
I premî dei vincitori consistevano, per lo più, in palme, od in corone di palma con nastri multicolori, palma lemniscata; alle volte poi erano premiati con danaro od anche con una bacchetta di legno, rudis.
[26]
I monumenti che ci mostrano i gladiatori, quali sono gli stucchi pompeiani, i mosaici delle ville Albani e Borghese (oggi Umberto I), i bassorilievi vaticani, quelli della villa Pamphili, ecc.; mentre ci fanno conoscere la varietà delle armature e la ricchezza dei costumi, ci addimostrano altresì la splendidezza di simili spettacoli, e, per un momento almeno, ci distraggono dalla crudeltà e barbarie delle descritte istituzioni.
Questi cruenti spettacoli continuarono a celebrarsi legalmente fino all’anno 325 dell’èra volgare, allorchè Costantino, da Beirout (Berito), diresse a Massimo, prefetto del Pretorio, una legge con data del 1º Ottobre, per la quale proibiva i giuochi gladiatorî; ed ai delinquenti commutava la pena della pugna con quella delle miniere[136].
Ma questa legge fu ben tosto violata; anzi nelle province orientali forse non fu mai osservata: giacchè la legge seconda, dello stesso titolo, diretta da Costanzo e Giuliano ad Orfito, prefetto di Roma, in data del 16 Ottobre, mostra che nel 357 quei giuochi erano ancora in vigore; e la terza legge sullo stesso oggetto, emanata da Arcadio ad Onorio nel 397, non solo ci rende certi che gli spettacoli gladiatorî continuavano, ma ci addimostra ben anche l’esistenza dei ludi. Ciò stesso l’apprendiamo da S. Agostino[137] e da Prudenzio[138]:
Respice terrifici scelerata sacraria Ditis:
Cui cadit infausta fusus gladiator arena.
Heu, male lustratae phlegetontia victima Romae!
Nam quid vesani sibi vult ars impia ludi?
Quid mortes iuvenum, quid sanguine pasta voluptas?
Quid pulvis caveae semper funebris et illa
Amphitheatralis spectacula tristia pompae?
E sul finire dei poema, Prudenzio esorta Onorio a por fine a quei cruenti spettacoli con queste parole:
Tu mortes miserorum hominum prohibeto litari,
Nullus in urbe cadat cuius sit poena voluptas:
Nec sua virginitas oblectet caedibus ora,
Iam solis contenta feris infamis arena,
Nulla cruentatis homicidia ludat in armis.
E non tardò più guari una propizia occasione per abolire onninamente quei giuochi. Narra Teodoreto[139], che regnando Onorio[140] un monaco di nome [27] Telemaco partì dall’Oriente alla volta d’Italia, col fine di far cessare gli spettacoli gladiatorî. Giunto in Roma, discese nell’arena e tentò di far deporre le armi ai gladiatori. Ma gli spettatori, che erano pagani e che tanto diletto ritraevano da simili combattimenti, insorsero contro di lui, e l’uccisero[141].
Allora Onorio abolì per sempre gli spettacoli gladiatorî.
[29]
L’ANFITEATRO FLAVIO NEI SUOI VENTI SECOLI DI STORIA.
[31]
Due furono gli anfiteatri stabili in Roma: quello di Statilio Tauro ed il FLAVIO[142]. L’anfiteatro Taurense fu di piccole dimensioni[143], e, fin dai primi tempi della sua costruzione, di pochissimo uso[144]; la sua durata poi fu breve, giacché sotto l’Impero di Nerone, s’incendiò[145].
«Gli avanzi di esso e il nome a questi rimasto, dice il Maffei[146], ne avranno fatta far menzione a Vittore, non dovendosi già credere che gli edifizî e le cose da lui nominate fossero a suo tempo ancora tutte in essere e in uso».
Augusto ideò di edificare un anfiteatro nel centro di Roma[147], e precisamente fra i monti Palatino, Celio ed Esquilino; ma il suo progetto non fu effettuato. L’attuazione di quell’idea era riservata a Fl. Vespasiano il quale, nell’anno ottavo del suo consolato[148], essendo già terminata la guerra giudaica[149], pose mano alla grandiosa opera. Scelse allo scopo il sito prescelto [32] da Augusto, urbe media[150], sito detto Ceriolense[151], che Nerone avea ridotto a foggia di lago o golfo, circondato da grandi edifizî[152], e che perciò dicevasi stagnum Neronis.
Marziale[153] ne conservò la memoria in quel distico:
Hic ubi conspicui venerabilis Amphitheatri
Erigitur moles STAGNA NERONIS erant.[154]
Pietro Rossino[155] scrisse che il Colosseo fu compiuto in quattro mesi (!!), e che vi lavorarono 12,000 Ebrei condotti schiavi da Tito. Nessuno storico ci ha tramandato quanto Rossino afferma. Anzi Giuseppe Flavio (il quale trattandosi di un tanto lavoro eseguito dai suoi connazionali, non avrebbe mancato di segnalarlo nelle sue opere) non ne fa motto. Soltanto ci dice[156] che Tito trasportò in Italia, pel suo trionfo in Roma, oltre i capi Simone e Giovanni, 700 uomini e non più. Narra altresì[157] che le altre migliaia di Ebrei prigionieri erano stati o venduti, o fatti morir d’inedia o trucidati o condannati alle miniere d’Egitto o distribuiti nelle province, per esser consumati dal ferro e dalle bestie[158].
Dopo due anni[159] l’edifizio era giunto al terzo gradus; ma Vespasiano non ebbe la sorte di vederlo compiuto, perchè la morte lo sorprese. Suo figlio Tito gli successe e nell’Impero e nel proseguimento del lavoro del colossale Anfiteatro. Questi aggiunse altri due gradus ai tre già costruiti da suo padre[160]; e, nell’anno 80 dell’èra nostra, ne fece la solenne dedicazione.
Eutropio e i cronologi Eusebio, Di S. Prospero e Cassiodoro, attribuirono a Tito la maggior parte dell’opera del Flavio Anfiteatro[161].
[33]
Neppur Tito compì del tutto l’opera: fu Domiziano, fratello e successore di lui, quegli che, come ci dice il cronografo dell’anno 334[162], condusse l’opera dell’Anfiteatro usque ad clypea. Che cosa si debba qui intendere per clypea, lo vedremo nel prossimo capitolo. «Gli atti arvalici, dice il ch. Professor R. Lanciani[163] sono un documento insigne per riconoscere a quale punto di perfezione fosse stata condotta la fabbrica dell’Anfiteatro circa la metà dell’anno 80. Questi atti parlano di tre meniani, che sono: il MAENIANVM PRIMUM con un minimo di otto gradini marmorei, diviso in cunei; MAENIANUM SECUNDUM anch’esso diviso in cunei, nella parte più alta del quale (M. II. SVMMVM) gli Arvali, cioè i ministri inferiori del Collegio, avevano ottenuto posto in quattro gradini marmorei: il MAENIANVM SVMMVM IN LIGNEIS, diviso in tante tabulazioni, quanti erano gli intercolunnî del portico (e gli archi da basso) con un minimo di undici sedili di tavole. Siccome a queste tre zone principali di sedili marmorei o lignei dobbiamo aggiungere per altre ragioni il podio dei senatori (per non parlare dell’arena, del pulvinare imperiale, ecc.), e siccome la divisione del terzo meniano in tabulazioni suppone la esistenza del portico; se ne deduce la conseguenza che, nell’anno 80, quando fu solennemente dedicata la fabbrica, essa era stata recata a compimento, salvo forse nei particolari dell’ornamentazione, i quali saranno stati perfezionati da Domiziano».
Giustissima deduzione, che a me sembra confermata dai fatti. L’ordine Composito, combinazione dell’Ionico col Corintio, fu invenzione dei Romani. Esso fu usato, benchè vagamente, fin dagli ultimi tempi della Repubblica[164]; [34] ma dall’esempio più antico che possediamo[165], si può fondatamente dedurre che questa combinazione fu ridotta ad ordine architettonico ai tempi dei Flavî, e precisamente sotto il regno di Domiziano, allorquando il Senato eresse in onore del Divo Tito, l’arco trionfale.
Ora se Domiziano avesse aggiunto all’Anfiteatro Flavio l’ultimo piano, forse noi non vi vedremmo ripetuto l’ordine Corintio, ma vi troveremmo adoperato il Composito; ordine, direi quasi, Domizianeo. Anzi io congetturo che la costituzione del nuovo ordine architettonico sia nata appunto dalla ripetizione del Corintio fatta negli ultimi due piani dell’Anfiteatro regnando Tito; e che questa ripetizione abbia fatto pensare a Domiziano, o meglio ai suoi architetti, ad un quarto ordine propriamente detto, da adoperarsi in avvenire ed in casi analoghi.
Nè sembra far ostacolo a questo ragionamento l’ordine Composito adoperato nel colonnato del portico del sommo meniano in ligneis: giacchè convien riflettere che, se dall’iscrizione degli Arvali dobbiamo necessariamente dedurre l’esistenza dell’ultimo piano dell’Anfiteatro e del colonnato del meniano sommo; non possiamo però da quella parimenti dedurre di qual materia fossero le colonne di quel porticale al momento dell’inaugurazione dell’Anfiteatro. Pare quindi potersi ragionevolmente opinare, che, portata sostanzialmente a compimento la gigantesca mole colla costruzione del muraglione esterno dell’ultimo piano, Tito, onde non protrarre più oltre la bramata solennità, abbia fatto costruire provvisoriamente in legno quel colonnato. E quest’ipotesi vien confermata dalla stessa lapide dei Fratelli Arvali, nella quale, come dicemmo, si legge che i gradi del meniano sommo erano di legno e divisi in cunei da lignei tavolati. Morto Tito, Domiziano avrebbe compito l’opera del fratello sostituendo alle colonne lignee, forse di ordine Corintio, le colonne di marmo di ordine Composito[166], e perfezionandone l’ornamentazione. Se così fosse, la mia supposizione metterebbe in concordanza il cronografo del 334 coll’iscrizione degli Arvali[167].
[35]
Nella dedicazione dell’Anfiteatro Flavio[168], vero portento della romana grandezza, e del quale Marziale[169] dice enfaticamente:
Omnis caesareo cedat labor amphitheatro
Unum prae cunctis fama loquatur opus.
[36] Tito fe’ celebrare straordinarie e sontuosissime feste; alle quali, se vogliamo prestar fede alle parole dello stesso poeta, concorse gente da ogni parte della terra[170]. Suetonio, nella vita di Tito, ci dice che in quella solenne circostanza, oltre agli sceltissimi e ricchi spettacoli gladiatorî e alle venationes, ebbero luogo pur anche i combattimenti navali[171] in veteri naumachia. Il passo di Suetonio, che noi riportiamo in nota, come si legge è un po’ oscuro; e non è facile comprendere ciò che quegli voglia intendere per quell’«in veteri naumachia»[172], e con quell’«uno die quinque millia ferarum». Cassiodoro[173] conviene con Suetonio relativamente al numero delle fiere, e a G. B. Nolli non parve improbabile il racconto di Suetonio[174].
Più chiara e particolareggiata è la descrizione che di quelle sontuose feste inaugurali ci fa Dione. «Le gru, Egli dice[175], tra di loro pugnarono[176], e quattro elefanti e novemila tra fiere e pecore, furono uccise; le quali anche le donne, non però nobili, insieme cogli uomini si diedero a ferire. Molti uomini pugnarono altresì alla foggia dei gladiatori; molti ancora riuniti pedestri e navali combattimenti eseguirono. Perciocchè riempiuto d’acqua di repente lo anfiteatro, in esso introdotti furono cavalli e tori ed altri animali mansueti, che addestrati erano a fare tutto quello che usi erano a fare in terra. Uomini ancora introdusse Tito nelle navi, i quali divisi in Corciresi e Corintii, colà pugnarono in costume navale. Altri ancora, fuori della città, pugnarono nel bosco di Caio e Lucio[177], che Augusto per quella cagione avea fatto scavare. Conciossiacchè colà il primo giorno un combattimento di gladiatori si eseguì, e l’uccisione di molte fiere, coperto essendosi con tavole il lago dalla parte [37] che risguarda le statue, e al di fuori tutto circondato ugualmente di un tavolato. Il dì seguente celebrati furono i giuochi Circensi; il terzo giorno si diede un combattimento navale di tremila uomini, che susseguito fu da una pugna di fanti. Perciocchè gli Ateniesi, superato avendo i Siracusani (giacchè sotto questo nome pugnato avevano), scesero nell’isola, ed assalito avendo certo muro che intorno al monimento di quel luogo era condotto, lo presero. Per cento giorni[178] durarono quegli spettacoli atti a pascere la vista. Ma utile riuscì ancor questo alla plebe, perchè Tito piccioli globi di legno da luogo eminente nel teatro gettava, i quali tessere contenevano coll’indicazione di qualche vivanda, di una veste, e di un vaso d’argento o d’oro, di cavalli, di giumenti, di bestiami e di servi. Chiunque, alcuno di quei globetti coglieva, portavalo al dispensatore de’ donativi, e la cosa che dentro era scritta, conseguiva».
Tito dedicò l’Anfiteatro in nome proprio e non in quello del padre; ed a questa dedicazione, nonchè alle sontuose feste e giuochi in quell’occasione celebrati, alludono due medaglie, portanti nella parte dritta la figura di Tito, assisa sopra trofei ed in atto di presentare un ramoscello d’olivo; e, sul rovescio, l’Anfiteatro con la Mèta Sudante a sinistra[179], ed un portico a doppio ordine di colonne a destra: prospetto che corrisponde alla parte dell’edificio che guarda il Celio, il cui arco, prossimo al centrale del primo ordine esterno, portava il numero I[180]. Che il cono che osservasi a sinistra dell’Anfiteatro rappresenti la Mèta Sudante, checchè ne dica il Maffei[181], non v’ha ormai chi dubiti. Ma che cosa sia quel portico a doppio ordine di colonne che si scorge a destra, è ancora molto disputabile. Se col Guattani[182] e col Nibby[183] si volesse ritenere che quel portico abbia comunicato col palazzo di Tito sull’Esquilino, [38] noi non ci sapremmo spiegare come esso si potesse vedere dal lato opposto dell’Anfiteatro. Il prospetto dell’edificio rappresentato nella medaglia corrisponde, come si è detto, alla parte che guarda il Celio. Ma a destra di chi guarda l’arco centrale, prossimo al fornice che portava il numero I, non v’è certamente l’Esquilino. Che cosa adunque potrebbe rappresentare quel portico? Forse un luogo ove s’intrattenevano le persone di riguardo, allor chè i raggi del sole eran troppo ardenti, facendovi combattere qualche coppia di gladiatori?[184] — Forse un luogo coperto destinato al ritiro di chi voleva sollevarsi un poco dall’incomodo di stare nell’Anfiteatro molto tempo per tornarvi tosto, o per ristorarsi, giacchè nell’Anfiteatro era proibito il bere, ecc.?[185] — Forse un apoditerio, o finalmente un propilèo?[186].
Fra tante opinioni, anch’io mi permetto esprimere la mia.
Sappiamo che l’Anfiteatro è opera dei Flavî: Vespasiano lo incominciò, Tito proseguì l’edificio e lo dedicò, Domiziano lo portò a compimento. Sappiamo inoltre che Tito costrusse presso l’Anfiteatro le sue Terme, e che, finalmente, Domiziano ristabilì la Mèta Sudante, facendola assai bella e decorata[187]. Non potremmo adunque congetturare che in quelle medaglie si siano volute commemorare simultaneamente le tre famose opere dei Flavî, vale a dire, l’Anfiteatro, le Terme e la Mèta Sudante? E questa congettura non si rende ancor più verosimile se si rifletta che solamente nelle medaglie dei Flavî vediamo effigiato il portico a doppio ordine di colonne? Se così fosse, il portico di cui parliamo sarebbe una parte delle Thermae Titianae[188]. Le ragioni poi che ci spingono a ritenere le Terme di Tito verso il Laterano piuttosto che sull’Esquilie, le esporremo a suo luogo[189].
La prima di queste medaglie ha l’iscrizione:
IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. PPP. COS. VIII S. C.[190]
Anno 883/80
Tito fu console per l’ottava volta l’anno 80; i titoli corrispondono a quelli di un Imperatore vivente. L’altra medaglia ci mostra Tito già morto, poichè gli si dà in essa il titolo di DIVO.[191] Il Nibby opina che Domiziano sia stato colui il quale fece coniare queste due medaglie; e che, per conservare quest’imperatore [39] la data della dedicazione fatta dal fratello, abbia unito alla prima medaglia i titoli di lui come ancor vivente; e, sull’altra, ne abbia fatta l’apoteosi, dandogli il titolo di DIVO:[192]
DIVO. AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIAN S. C.
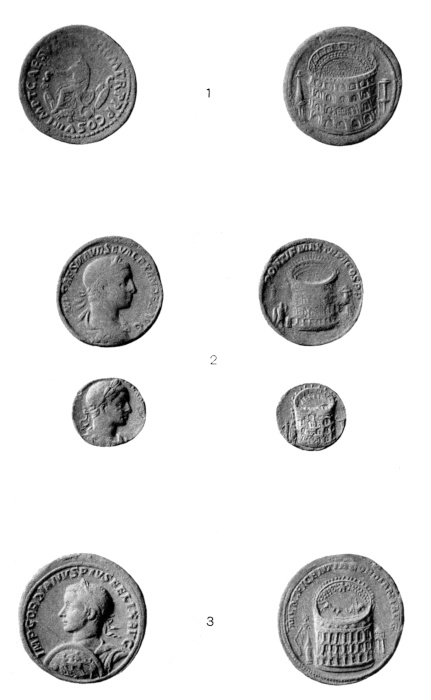
NUMMI COMMEMORATIVI RIPRODOTTI DAGLI ORIGINALI CHE SI CONSERVANO NEL GABINETTO NUMISMATICO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI.
Il Donaldson[193] dà la riproduzione litografica di questa medaglia, con l’annotazione delle varianti. Egli ritiene non essere ingiustificabile il supporre che l’Anfiteatro fosse eretto in origine coll’attico rappresentato in questa medaglia, ma che dopo le conflagrazioni e dilapidazioni alle quali andò soggetto in tre secoli, si fosse ridotto l’attico ad un altezza maggiore; non potendo persuadersi che nella medaglia si fosse fatto un attico tanto basso per rappresentare un attico tanto alto quale noi lo vediamo, perchè questo supererebbe la convenzionale licenza che si osserva comunemente nelle medaglie. L’Eckel[194] opina che la suddetta medaglia sia falsa, e basa la sua tesi principalmente sull’esecuzione, la quale, dice, non è d’arte romana ma d’arte moderna. A questa obiezione il Donaldson non risponde. Ma anche ammesso che il nummo di cui parliamo non sia d’arte moderna ma romana, noi non potremmo mai dedurne che originariamente l’Anfiteatro non avesse quattro ordini quanti al presente se ne ravvisano[195] e quanti se ne riscontrano pur anche in una forma di stucco di epoca posteriore, rinvenuta da A. Pellegrini al V miglio della Via Portuense e mostrata in un’adunanza dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica[196]. Io ho esaminata la riproduzione litografica del Donaldson[197]; ho pur studiate altre medaglie ed ho dovuto convincermi che esse presentan tutte, oltre ai tre ordini di arcate, il quarto piano con pilastri, finestre e dischi[198]; ad eccezione delle medaglie di Severo Alessandro, le quali, pur avendo finestre e dischi nel quarto piano, mancano di pilastri: ed ho inoltre osservato che in tutte le medaglie d’età posteriore, l’attico è rappresentato nella stessa proporzione relativamente agli ordini arcuati, benchè a quell’epoca fosse tant’alto quanto al presente lo vediamo[199].
[40]
Cassiodoro[200] attribuisce a Tito le ingenti spese e tutta la gloria del nostro edificio, dicendoci che vi versò un fiume di ricchezze, e che colla somma spesa si sarebbe potuto fabbricare una città capitale.
Barthelemy ed il P. Jacquier[201], formando un calcolo approssimativo delle spese (secondo i prezzi in vigore verso l’anno 1756) valutarono il solo muro esterno dell’Anfiteatro 2,218,065 scudi, ossia L. 11,825,349,37. Noi non giudicheremo sull’esattezza delle cifre esposte, giacchè queste sono da calcolarsi giusta i prezzi della mano d’opera in vigore al tempo dei citati scrittori: prezzi, del resto, che ai dì nostri si sarebbero quasi triplicati.
«L’erezione e la dedicazione dell’Anfiteatro Flavio, dice, e giustamente, il Ch.º R. Lanciani[202], debbono essere state ricordate da grandi iscrizioni monumentali contemporanee. Hübner[203], illustrando le iscrizioni dell’Anfiteatro note nel 1856, trascrive tre frammenti di un epistilio di pietra tiburtina: infixa muro exteriori litteris aevo Titi vel Domitiani non indignis.
ESA VST
V M VRA
VI
(C. I, l. IV, parte 4, 32254).
Questi frammenti potrebbero facilmente prestarsi al supplemento:
Imp. T. CaESAr divi f. Vespasianus Aug VST us; ma possono anche convenire a qualunque altro predecessore di Sev. Alessandro, del quale sappiamo esser stata restaurata quella parte più alta del Colosseo».
Contemporanee all’edificazione del nostro Anfiteatro debbono anche credersi alcune iscrizioni dipinte a pennello sui travertini delle arcuazioni del secondo ambulacro interiore; e si trovano inseriti nel c. I, l. VI, parte 4, 32254.
[41]
La forma dell’Anfiteatro Flavio è ovale, come ovali sono generalmente tutti gli anfiteatrali edificî[204]. La lunghezza dell’asse maggiore di questo grande ovale, compreso il primo gradino che circonda la mole, è di m. 191,20; quella dell’asse minore è di m. 158,50. La periferia, presa sempre sul ciglio del detto gradino, dà m. 546. L’altezza, dal livello stradale alla sommità, è di metri 50[205].
Un’area lastricata di travertini, larga m. 17,60, attornia l’Anfiteatro, secondandone la curva. È quella terminata da grossi cippi di travertino, tagliati superiormente a semicerchio, alti m. 1,75, larghi m. 0,76 e grossi m. 0,60[206]; distano l’uno dall’altro m. 3,40, e nella loro faccia interna rimangon tracce dell’impernatura, forse delle sbarre metalliche, che collegavano l’un cippo con l’altro.
L’intiera mole sorge esternamente sopra due gradini, il primo dei quali ha m. 0,425 di pedata e m. 0,20 di alzata; il secondo m. 0,18 di alzata, e, [42] dal ciglio al plinto della base della colonna, una pedata di m. 1,02, la quale si unisce nel vuoto degli archi col pavimento del portico.
Consta l’edificio di quattro piani. I primi tre sono arcuati ed ornati con colonne di mezzo rilievo, d’ordine rispettivamente Dorico, Jonico e Corintio; il quarto piano non ha archi, ma finestre rettangolari; ed anzichè da colonne, come i tre sottoposti, è decorato da pilastri con capitelli Corintî: il che, secondo alcuni architetti, meglio asseconda l’occhio in tanta altezza.
Nei due primi piani le colonne sporgono dai pilastri degli archi per due terzi del diametro, e nel terzo piano per la sola metà. Esse hanno tutte egual diametro, e di eguale larghezza sono eziandio i pilastri dell’ultimo piano.
L’ordine del piano terreno è un Dorico non legittimo: non ha triglifi nel fregio; il capitello in luogo dei tre listellini ha una gola, ed al fusto della colonna è sottoposta una base, di un carattere differente dalle quattro consuete. L’altezza di quest’ordine è di m. 10,50: gli archi hanno m. 4,30 di larghezza e m. 7,10 di altezza.
L’ordine del secondo piano è Jonico, ed è alto (compreso il piedistallo) m. 11,85. La colonna ha la base attica. Gli archi hanno m. 4,30 di larghezza e m. 6,50 di altezza. Essendo il pavimento del portico di questo piano a livello della cimasa del piedistallo della colonna, vi si dovette fare un parapetto dell’altezza di un metro.
L’ordine del terzo piano è Corintio, ed è alto (compreso il piedistallo) m. 11,60. La base della colonna è toscana: nella cornice di quest’ordine è da notarsi che essa non ha gocciolatoio, ma i modiglioni reggono immediatamente il listello sottoposto alla gola finale. Gli archi sono larghi m. 4,30 ed alti m. 6,40. Anche qui, come nel sottoposto piano, v’è, per la stessa ragione, un parapetto alto un metro.
I pilastri del quarto piano sono Corintî, hanno la base attica, e tutto l’ordine, compreso il piedistallo ed un dado che è sottoposto alla base, è alto m. 13,90. Il cornicione di quest’ultimo ordine è classico, perchè (mentre mantiene le altezze dell’architrave, del fregio e della cornice proporzionate al pilastro), per l’introduzione di robuste mensole nel fregio e per la semplificazione della cornice (che, decorata a guisa di architrave da tre fasce ed una cimasa, forma nel suo assieme, senza esser pesante, un grandioso gocciolatoio), corona stupendamente l’intiera mole.
Questo piano, come già si disse, invece di archi ha finestre rettangolari, le quali sono di due dimensioni, e si trovano disposte negli intervalli fra i pilastri alternativamente. Le maggiori si trovano nella parte superiore; hanno una dimensione di m. 1,72 × 2,57; le minori di m. 1,30 × 0,90, e trovansi nel dado del basamento.
[43]
Il Maffei[207] parlando dell’ordine di questo piano, dice che, essendo il fregio ornato da modiglioni, questi, nonostante che i capitelli dei pilastri siano Corintî, fanno divenire l’ordine Romano o Composito. Anche il Serlio chiama quest’ordine così, ma non a ragione; giacchè la caratteristica principale di un ordine architettonico è il capitello: e bene a proposito il Desgodetz scrisse: «La somiglianza che hanno gli ordini affini, come sono il Romano ed il Corintio, il Dorico ed il Toscano, e qualche licenza che l’architetto si prenda, non deve farli confondere fra loro».
Il nostro edificio non ha intagli, e giustamente; perchè, a parer mio, l’intagliar foglie, volute e cornici che doveano essere collocate a tanta altezza ed in fabbrica cotanto gigantesca, sarebbe stato, più che superfluo, sconvenevole; come, viceversa, sarebbe sconvenevole non decorar con intagli ordini destinati a decorar una sala.
D’altronde l’esecuzione dell’edificio in genere, e dei particolari in ispecie, è trascurata assai. Una trascuratezza siffatta, per non aver riscontro nelle fabbriche contemporanee, ci attesta la fretta con cui fu eseguita la grandiosa opera dell’Anfiteatro Flavio.
In ciascuno dei tre piani arcuati v’erano 80 fornici: quelli del piano terreno erano numerati, ad eccezione di quei quattro che si trovavano all’estremità dell’asse maggiore e minore, dei quali i primi due erano i grandi ingressi all’arena, e i due secondi gli ingressi imperatorî; sicchè ogni quadrante della periferia conteneva 19 fornici intieri e due dimezzati.
Gli archi caduti sono 47; i superstiti 33, portanti dalla parte esterna incisi al di sopra degli archivolti, i seguenti numeri:
XXIII XXIIII XXV xxvi XXVII XXVIII XXVIIII XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIIII XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII (segue un arco non numerato, all’estremità orientale dell’asse minore) XXXVIIII XL XLI XLII XLIII XLIIII XLV XLVI XLVII .... XLVIIII ... L LI LII LIII LIIII.
(C. I, l. VI, Parte 4, 32263).
I numeri servivano indubbiamente ad indicare a coloro che doveano assistere agli spettacoli, qual fosse l’ingresso a loro più comodo per portarsi al sito della scalinata assegnato alla rispettiva condizione sociale. L’Agostini, nel quarto dei suoi dialoghi sulle medaglie, osservò che ad ogni quattro archi corrispondeva una scalinata interiore, la quale sboccava ad un vomitorio, ossia uscita alla grande scalinata della cavea: e che anche sugli archi di questi vomitorî erano scolpiti numeri onde evitare confusione.
[44]
Il numero I trovavasi a destra di chi guarda l’Anfiteatro dalla parte del Celio; il numero LXXVI a sinistra. Al lato opposto, l’arco senza numero lo vediamo fra i numeri XXXVIII e XXXVIIII; e questo fornice si fa rimarcare non solo per la mancanza del numero, ma pure per le tracce di una speciale decorazione. Non lungi da esso si rinvennero, e si veggon tuttora, due pezzi di colonna di marmo frigio e residui di trabeazione di marmo bianco. I gradini che circondano esternamente l’Anfiteatro, sono in quel punto interrotti, ed i massi di travertino formano, nella parte centrale dell’arco, un rientramento. Il Marangoni pensa che gli archi senza numero fossero destinati all’ingresso degli Imperatori, della loro corte e di tutti coloro che doveano sedere al podio. Ciò troverebbe una conferma, dice, nel fatto che, passati i due portici, e dove principiano gli archi che sostenevano le gradinate verso l’arena, v’ha come una spaziosa sala, illuminata da qualche apertura corrispondente alla gradinata stessa. Quest’ambiente vedesi adornato con lavori e figure di stucco, le quali, benchè danneggiate dall’aria e dal tempo, appariscono di squisito lavoro[208]. E poichè sull’arco mancante di numero manca eziandio l’intera cornice, sino al piano dell’ordine superiore; si può pensare che esso fosse adornato da qualche gruppo o bassorilievo od anche con iscrizioni[209].
Il Nibby[210] ed altri argomentano dalle medaglie che «dinanzi al parapetto di ciascun arco vi dovea essere esteriormente un piedestallo con una statua pedestre: fatto, aggiunge egli, confermato dagli ultimi scavi, e che apparisce da qualche traccia superstite». Io stesso ho veduto coi miei occhi queste tracce patentissime, e specialmente le ho osservate nel parapetto che trovasi nel fornice del terzo piano e sopra l’arco che porta il numero XXXIII, ove rimane il posto già occupato dal piedistallo; ed ho osservato l’interruzione della cornice che serve di finimento al parapetto stesso, perchè coperto dalla parte posteriore del piedistallo (V. Fig. 2).
[45]
Il Guazzesi[211] opina che le statue che si veggono incise nelle medaglie ornassero effettivamente l’Anfiteatro Flavio; ma dice che esse non furono stabili e di marmo, bensì d’altra materia e mobili, da esporsi in mezzo agli archi giusta le circostanze e qualità degli spettacoli da rappresentarsi nel nostro Anfiteatro. E basa la sua opinione sul fatto (?) del non trovarsi nel mezzo di essi archi alcun segno o vestigio di base o di piedistalli, che rivelino la cessata esistenza di statue stabili e di marmo.
Si vede che il Guazzesi esaminò molto superficialmente l’edificio!
In ogni modo, le statue fossero o mobili od immobili, di marmo o di gesso, di terracotta o lignee; se non vogliamo negar fede alle medaglie ed ai fatti, l’Anfiteatro Flavio fu indiscutibilmente decorato con statue. «Gli archi aperti del secondo e terzo piano, dice il ch. H. Grisar[212] erano nell’ampio giro animati di statue di marmo e di bronzo».
Ciascuno dei tre ordini arcuati, come ho detto poc’anzi, consta di 80 fornici; le finestre maggiori però del 4º piano non sono che 40, perchè s’alternano in modo che per ogni due archi v’è una finestra. — Esaminando le medaglie, vediamo che in ogni spazio libero, tra un finestrone e l’altro, vi fu scolpito un disco. Sarà stato questo un capriccio dello scultore, o veramente in quegli spazî vi fu qualche cosa? Vediamolo.
Alcuni archeologi, tra i quali il Nibby[213], ritennero che i clipei dei quali ci parla il cronografo dell’anno 334[214], non furono altro che quegli ornamenti rotondi che sormontavano la cornice dell’Anfiteatro, formando una specie di merlatura. Rispetto il parere di tali scrittori; ma siccome quella specie di merlatura che si vede accennata nelle medaglie, io dubito non sia altro che la serie delle grossi travi del velario, rivestite probabilmente di bronzo e coronate alla testata da un ornamento finale, così ho voluto intraprendere uno studio speciale intorno a questo punto. Ecco il risultato delle mie ricerche.
Per clypeus, clypeum e clupeus tutti gli scrittori antichi, in relazione ad edificî, han voluto sempre significare quello scudo rotondo, per lo più di bronzo, coll’effigie scolpita od a rilievo, di una divinità o di un eroe o di qualche personaggio illustre[215]: scudo che si soleva collocare sulle pareti esterne dei tempî[216], ed in luoghi pubblici[217].
[46]
Ora, dicendoci il cronografo suddetto che Domiziano portò l’Anfiteatro usque ad clypea, non potremmo noi congetturare che i clipei non fossero quegli ornamenti rotondi che sormontavano la cornice dell’Anfiteatro, ma bensì veri scudi di bronzo, i quali, come si rileva dalle medaglie, sfolgoravano fra i pilastri esterni del quarto piano?[218].
Il Maffei[219], non potendo non prestar fede alle medaglie, dovè conchiudere: «nel quarto piano del Coliseo veggiam finestre quadrate alternatamente, nelle medaglie veggiamo gli spazî intermedî, non nudi come son nella fabbrica, ma occupati da certi tondi, che paion clipei, ed altro non possono rappresentare, che ornamenti posticci (?), quali si ponessero e levassero». Osservando il monumento, m’avvidi che nel mezzo degli spazî che si alternano colle grandi finestre del quarto ordine dell’Anfiteatro, vi sono dei fori, nei quali evidentemente furono fissati i perni degli scudi stessi.
Questi fori da me veduti, e da non confondersi con quei buchi fatti, come vedremo, ne’ bassi tempi per estrarre i perni metallici, li troviamo negli spazî superstiti che sono a piombo degli archi portanti i numeri: XIII XXV XXXI XXXIII XXXV XXXX XLII XLVIII L (Vedi Fig. 2).
L’ordine con cui furono fatti questi fori ci dà chiaramente a vedere la forma dell’oggetto ad essi raccomandato. Quattro sono disposti in modo da poter per essi condurre una circonferenza, e due altri si trovano laterali al più basso, formando con questo una linea orizzontale.
Pertanto l’oggetto raccomandato a quei fori fu senza dubbio uno scudo rotondo circondato da una corona di lauro con la tenia di legamento accappiata nel basso. Da questi fori si può anche dedurre approssimativamente il diametro del clipeo, perchè due dei quattro fori pei quali si può condurre una circonferenza si trovano, come gli spigoli degli stipiti delle finestre maggiori, a piombo del mezzo dei due spazi interposti fra i tre mensoloni.
Che nell’Anfiteatro Flavio vi siano stati clipei è indiscutibile. Il cronografo ce lo dice chiaramente: che questi scudi o clipei siano stati posti fra una finestra e l’altra del quarto ordine, ce lo dimostrano evidentemente le medaglie e le vestigia che ne rimangono nel monumento. — Ma chi si rappresentò in quegli scudi? Perchè non li collocarono in tutti e singoli gli spazi liberi? Perchè procedono e si alternano in una maniera sì strana?
La risposta a questi quesiti non è certamente facile. Io, nondimeno, nella IV parte — Questione 2. — di questo scritto presenterò il mio umile giudizio; e sarei lietissimo se altri potessero dare ai quesiti proposti soluzione più plausibile.
[47]
Negli interpilastri, al piano degli architravi delle finestre, sporgono dalla parete grandi modiglioni di travertino, aventi ciascuno un incavo; e, corrispondenti a questi, nella cornice di coronamento, vi sono altrettanti vani o fori. Allorchè l’Anfiteatro Flavio era ancora intiero, il numero dei modiglioni ascendeva a 240.
Questi servivano a sostenere (ed i vani a contenere) le travi verticali, fasciate di bronzo, le quali a lor volta sostenevano il velario, perchè gli spettatori fossero riparati dai cocenti raggi solari[220].
La già citata cronaca dell’Anonimo, pubblicata dall’Eccardo, e le medaglie ci rivelano, dice il Nibby[221], che la sommità dell’Anfiteatro era coronata intorno da una specie di merlatura di scudi rotondi, che l’Anonimo sovrammenzionato chiama CLYPEA. Altri poi disegnano questi merli a foggia di piramidette sormontate da globi o palle, ornamento trascurato da molti.
Noi già abbiamo esposto il nostro parere circa il significato della voce clypeus o clypeum ed abbiamo accennato che quella specie di merlatura e [48] di piramidette rappresentate nelle medaglie altro non fu che l’insieme dei finimenti delle antenne che sorreggevano il velario. Passiamo perciò ad altro.
In tutto il recinto esterno dell’Anfiteatro, ed anche internamente[222], il materiale usato nella costruzione è il travertino. I massi, come è proprio dell’opera quadrata, sono commessi senza malta; o al più come dice il Gori[223], furono assestati con una leggera còlla di calce, ed erano collegati fra loro con spranghe e perni di ferro, i quali rimangono tuttora entro alcuni buchetti quadrati, profondi un dito circa. Tal modo di costruzione è antichissimo; e ce lo dimostra un passo di Tucidide[224], il quale afferma che nelle grosse mura, fabbricate per consiglio di Temistocle dagli Ateniesi intorno al Pireo, non v’era nè ghiaia, nè malta; ma grosse pietre commesse insieme e tagliate in quadro, le esteriori delle quali erano collegate fra loro con ferro e piombo. «Arduo dovè essere il lavoro di chi, in età men rimota, smantellò una parte del Colosseo!» esclama il Fontana.
L’Eschinardi[225] ci assicura d’aver visto grosse spranghe di ferro in una colonna fra gli archi LII e LIII, e nell’arco XLVIII; e che il 12 Agosto 1689, giorno in cui cadde un arco interno dell’Anfiteatro, vide fra i materiali molte altre spranghe. Anche il Ficoroni[226] ci narra che allorquando, nel 1703, a cagione del terremoto, cadde un’ala dello stesso Anfiteatro, trovò fra i travertini due spranghe, una di metallo ed una di ferro, le quali commettevano l’una coll’altra pietra.
Eccettuati alcuni rari casi in cui a collegare i massi di pietra quadrata s’usò il legno, fin da antichissimi tempi s’usò, come si è detto, il metallo e specialmente il ferro. Vitruvio[227] prescrive che nei monumenti composti di un nucleo di muratura rivestito di un paramento di pietra quadrata, questo si colleghi con una controparete interna di tufi squadrati, per mezzo di spranghe di ferro e piombo. L’uso di concatenare in questa guisa le antiche fabbriche fu causa che col tempo nascessero nei monumenti quei tanti buchi che anche oggi vediamo, e che così orribilmente deturpano eziandio l’Anfiteatro Flavio. Vi fu chi credè che quello sfregio fosse opera delle mani dei barbari; altri poi l’attribuirono ai mercanti, i quali avrebbero fatto quei fori per introdurvi i pali onde sostenere le tende in occasione di fiere, ecc.[228]. Oggi però nessuno [49] dubita che la maggior parte di quei fori siano stati praticati collo scopo di estrarre i perni metallici che stringevano le pietre fra di loro. In ogni parte dell’Anfiteatro o furono asportate le chiavarde o fu tentato estrarle. Nell’età di mezzo il ferro addivenne un articolo un po’ raro, e quindi crebbe di prezzo; l’abbandono, d’altra parte, della città fece sì che i custodi degli armenti ed i pastori frequentassero quel rione; e questi poi, chi per povertà, chi per speculazione e chi per passatempo, intrapresero quella pessima occupazione.
Alcuni opinano che quel latrocinio abbia avuto principio fin dai tempi di Teodorico[229], giacchè questi riprese aspramente coloro che rubavano dai muri il metallo ed il piombo. Altri invece, e con più ragione, sostengono che Cassiodoro non parli dell’Anfiteatro Flavio, ma bensì delle rovine del teatro di Pompeo e d’altre fabbriche. Laonde, dicono, presero equivoco Flavio Biondo[230], Lucio Fauno[231], ed il Martinelli[232], che dissero l’Anfiteatro già in rovina ai tempi di Teodorico, la cui lettera (sulla quale questi scrittori fondano la loro opinione) non parla delle rovine dell’Anfiteatro Flavio, in cui a quell’epoca si rappresentavano ancora i giuochi, ma bensì delle rovine dell’Anfiteatro di Catania.
Dobbiamo confessare esser cosa ben difficile potere stabilire il tempo preciso in cui ebbe principio questa deturpazione dei monumenti. Il Nibby[233] ritiene che quei buchi siano stati fatti ai tempi in cui i Frangipani abitarono il Colosseo. Il Fea[234] dice, invece, che, osservando bene la fabbrica del Colosseo, ha notato che alcuni di quei buchi si dovettero fare in tempi molto remoti, prima, cioè, che (come vedremo a suo luogo) i Frangipani ne prendessero possesso: perchè, dice, innanzi tutto è inverosimile che quei signori, sì ricchi e potenti, abbiano potuto far compire per un vile guadagno quell’atto vandalico; e neppure è credibile che abbiano lasciato il Colosseo, in balìa di miserabili guastatori di monumenti, i quali facevano professione di cercar piombo, ferro e metallo, per trarne utile colla vendita: e secondariamente, perchè i buchi suddetti si trovano anche in quei luoghi, su de’ quali i Frangipani fabbricarono o appoggiarono muri da loro fatti per abitarvi. Altri buchi poi, soggiunge, furono certamente fatti dopo che quella famiglia lasciò di possedere l’Anfiteatro Flavio: nell’epoca, cioè, in cui i Papi trovavansi in Avignone, e dopo la caduta di una gran parte del portico esteriore. Si vedono infatti buchi praticati nei siti delle rovine, ove mai si sarebbero potuti fare, se [50] l’edifizio fosse stato nel suo essere: buchi, che negli stessi luoghi e nella parte conservata non si osservano davvero; vale a dire, nelle piante dei pilastri che corrispondono alle vólte rovinate.
È un fatto incontestato che fin dai tempi degli Imperatori, ed anche prima, vi fosse gente iniqua, che, per capriccio o per far dispetto a qualcuno, deturpasse i monumenti sepolcrali, e rompesse le statue poste in pubblico, o le insudiciasse[235]; che vi fossero oziosi e mal viventi, i quali rubassero i metalli di cui gli edifizî erano esteriormente adorni, o fracassassero statue di metallo già dedicate o esposte al pubblico[236], o che mandassero in rovina i sepolcri[237] di coloro i quali (contravvenendo alle leggi)[238] si facevano tumulare con gioie, oro, argento e vesti preziose[239].
Stabilitisi gli Imperatori in Costantinopoli, crebbero in Roma le miserie e gli oziosi; e tosto si sospesero le relazioni commerciali con quelle nazioni estere, donde s’importavano i metalli. Allora non mancò chi si dedicasse a raccogliere il piombo, il ferro ed i bronzi dalle fabbriche fatiscenti, ora con permesso ed ora colla semplice tolleranza dei magistrati. Ammiano Marcellino[240] ce lo dice chiaramente, allorquando ci riferisce che dovendo Lampadio[241], per suo ufficio, restaurare varie fabbriche, ed ergerne delle nuove, inviava apparitori in traccia dei raccoglitori dei metalli, sotto il pretesto di comprarli; e che gli inviati, trovatili, li toglievan loro senza pagamento, correndo in tal guisa serio rischio d’essere uccisi dai defraudati. Dal codice Teodosiano[242] poi apprendiamo che non solo i privati, ma pur anche i Prefetti ed altri Magistrati, o per avarizia o per risparmio, tolsero gli ornamenti metallici dagli antichi monumenti, sebbene fossero in bonissimo stato. La legge contro questo abuso fu emanata dagli imperatori Arcadio ed Onorio nell’anno 398. In seguito i barbari, non paghi di spogliare Roma del suo oro, del suo argento e di qualsiasi opera artistica di metallo, giunsero perfino a tormentare il suo popolo, onde obbligarlo a manifestare i supposti tesori[243]. Allora crebbe più che mai il bisogno dei metalli, e principalmente del bronzo, e la mania di estrarlo dai pubblici monumenti. Teodorico permise, o piuttosto [51] confermò l’uso di appropriarsi qualunque pezzo di metallo che fosse caduto dagli edifizî, vietando, in pari tempo, di toglierlo da monumenti, se ancora trovavasi al posto per ornamento[244].
Malgrado queste disposizioni, la strage del bronzo e del piombo cresceva smisuratamente: i metalli si toglievano dovunque si trovavano; e di notte si rompevano anche le statue che ancora in gran numero ornavano la città. Fu allora che Teodorico si vide nella necessità di deputare un magistrato, detto Comitiva Romana[245], al quale diede l’incombenza speciale d’invigilare sopra coloro che approfittavano delle tenebre notturne onde perpetrare più impunemente quel vandalismo.
Nelle calamità sopravvenute a Roma sul cadere del secolo VI, e nella quasi totale indipendenza dai magistrati, dagli Imperatori e dai Sommi Pontefici, della quale cominciavano a godere i suoi cittadini, accrebbe la noncuranza dei monumenti; e le statue ed altri lavori artistici, che erano sfuggiti alla rapacità dell’Imperatore Costantino III, perirono quasi tutti prima del secolo X. Secoli di miseria universale, di barbarie nelle arti, nelle lettere e nei costumi; secoli, in cui la metropoli del mondo ad altro non pensava che a consumare e a divorare se stessa! — A quei disgraziati secoli perciò, a mio parere, dobbiamo riportare la maggior parte di quei buchi che sì orribilmente deturpano l’Anfiteatro Flavio.
Nell’arco di Susa[246] s’osservano varî fori, simili a quelli fatti nel nostro Anfiteatro. Ecco quanto a questo proposito scrive il Maffei:[247] «Richiesto, quando fui sul luogo, che significassero (quei buchi dell’arco), feci osservare come i buchi soprastanno sempre al congiungimento di due pietre, e non si veggono oltre ad una certa altezza. Ma perchè ognuno si rendea difficile a crederlo, mandato in cerca di scalpelli, e fatto fare un simil buco in sito non ancor tocco, apparve la chiave, qual levata, e portata meco conservo fra le cose antiche da me raccolte. Il ferro, così perchè più tenacemente legasse, come perchè fosse da ruggine difeso, è tutto circonvestito di piombo, onde appare il riscontro e la verità dei passi di Tucidide e di Vitruvio»[248].
[52]
Ma non tutti i buchi che s’osservano nelle pareti dell’Anfiteatro Flavio, furono fatti allo scopo di asportarne i perni metallici. Esaminando infatti la forma, il luogo e la disposizione simmetrica di alcuni di essi, si scorge ad evidenza, dice il Fea[249], che furono fatti per appoggiarvi legni, onde sbarrare le arcate, o per difendersi, come era solito farsi in tempi di guerre civili, in cui si sbarravano anche le case e le strade per combattervi[250]; o per farvi divisioni di camere, o per uso di qualche arte; e alcuni forse per uso antico di giuochi, in occasione di essi: come può congetturarsi da altri simili nell’Anfiteatro di Pola, che non può dirsi mai stato abitato nei bassi tempi, come il Colosseo.
Osservando attentamente il profilo o sezione delle pareti esterne dell’Anfiteatro Flavio, si vedrà che la grossezza di esse pareti diminuisce gradatamente verso l’interno, in guisa che il basamento del piedistallo delle colonne del secondo piano cade a piombo del diametro superiore delle colonne del primo piano; e così via dicendo[251]. Questo non lo riscontriamo nell’anfiteatro di Verona. Il Serlio dice, e con ragione, che il ritrarsi delle pareti verso l’interno dà maggior fortezza all’edificio.
Al Palladio piaceva opinare che i muri diminuissero piramidalmente dall’una e dall’altra parte; ma dato che da una sola parte le pareti dovessero diminuire, questa dovea essere l’esterna, giacchè l’interna era resa solida dalle travature. E questa è forse la ragione per cui tuttora rimane una buona parte dei portici esterni del nostro Anfiteatro, mentre del Veronese rimane sì poca cosa!
Quanto alla tinta di color di calcina, la quale sembra passata su molti travertini, essa è un effetto del vento freddissimo di tramontana dominante nell’inverno in Roma[252].
L’aspetto esterno del monumento, benchè deformato dalle ingiurie degli uomini e degli elementi, è imponentissimo. Basta vederlo, per non dimenticarlo mai più. La sveltezza di una mole così colossale è dovuta alla sua forma curvilinea, che sfugge ed inganna l’occhio, e sorprende lo spettatore. Il pittoresco che v’ha insensibilmente introdotto il tempo colla sua opera di distruzione, l’ha reso sì vago ed interessante, che molti giunsero a non desiderare la riedificazione della parte diruta.
Ma già è tempo di descrivere la parte interna del nostro Anfiteatro. .
[53]
L’arena dell’Anfiteatro Flavio era lunga metri 79 e larga 46.
Non tutto lo spazio dell’arena era libero ai giuochi, ma attorno al podio girava un’area, larga quanto l’altezza di questo toglieva di visuale agli spettatori. Nell’anfiteatro di Pozzuoli questa zona è larga m. 1,12 circa, ed è limitata da un solco, nel quale vi sono due fori a distanza uguale, che trapassano la vôlta dell’ipogeo. Lo Scherillo opina che in questi fori stessero fissate le aste verticali che sostenevano la rete di bronzo. Nel nostro Anfiteatro questa zona (diremo morta) sarebbe stata proporzionalmente larga m. 2,50 circa: ed appunto a questa distanza dal muro del podio vediamo ricorrere nell’ipogeo una serie di pilastri di massi tufacei, disposti regolarmente attorno attorno e a distanze uguali; ai quali massi furono verosimilmente raccomandate le travi della grande rete, fin da quando (dopo il regno di Domiziano) fu modificata l’arena[253]. Io congetturo che precisamente in quest’epoca, a fine di dare un po’ di luce all’ipogeo (il quale ne avea certamente bisogno), si lasciassero delle aperture munite d’inferriate nel pavimento della zona morta[254].
Per comodità dei combattenti il suolo si ricopriva con strati di arena comune, donde quell’area si ebbe il nome di arena[255]. Si fe’ pur uso di polveri di vario colore, ma ciò potè accadere soltanto in occasione di solenni rappresentazioni. Plinio[256] ci dice che nel Circo Massimo s’adoperò a tal uso la raschiatura di pietra specolare. Caligola e Nerone, in occasione di giuochi straordinarî, [54] vi sparsero il minio e la crisocolla[257]; e da Lampridio apprendiamo che Eliogabalo fe’ cospargere il portico di limatura di oro e d’argento, dolente di non avervi potuto spargere la limatura di elettro[258]. Questo però non potè avvenire nel nostro Anfiteatro, perchè il restauro di questa mole, grandemente danneggiata dal famoso incendio, non fu, come vedremo, compiuto sotto Eliogabalo; ma se ai tempi di quest’Imperatore si fossero potuti dare degli spettacoli nell’Anfiteatro Flavio, anche l’arena di questo sarebbe stata certamente coperta di un tanto prezioso tappeto: sappiamo infatti che quel Principe ripetè una tal pazzia spesso e dovunque: «Idque frequenter quocumque fecit; iter pedibus usque ad equum vel carpentum ut fit hodie de aurosa arena»[259].
L’arena dell’Anfiteatro Flavio vide il pietoso spettacolo narratoci da Marziale[260] e del quale noi già parlammo nell’Introduzione. Due fanciulli mentre rimovevano col rastro la sabbia per coprire il sangue di cui era inzuppata, furono sbranati da un leone.
Nelle estremità dell’asse maggiore[261] v’erano due ingressi, pei quali s’accedeva all’arena. L’ingresso rivolto a Sud-Est dovè essere la porta chiamata libitinense, giacché appunto da quella parte estendevasi la regione II celimontana, ove il Curiosum e la Notitia pongono lo spoliarium, o luogo dove venivano strascinati i gladiatori uccisi ed i mortalmente feriti, per essere finiti a colpi di maglio, se boccheggianti, e poi tutti, spogliati delle loro armi e vesti non appena divenuti cadaveri. Per questa porta fu messo fuori due volte l’elmo di Commodo[262]; per essa si traevano via i caduti e le belve uccise[263]; per [55] essa erano introdotti gli elefanti, gli ippopotami, i rinoceronti e tutti gli animali che per la loro grossa corporatura non capivano nei pozzi; da quella porta finalmente entravano, a mio parere, eziandio i gladiatori ed i bestiarî per combattere nell’arena. Quest’ingresso era in una parola la porta di servizio.
L’altro ingresso è a Nord-Ovest, rivolto cioè alla parte più ragguardevole della Città (vale a dire il Palatino ed i Fori); fu la porta principale, che potrebbe chiamarsi pompae, per la pompa gladiatoria, che da quella usciva sull’arena prima che si desse principio ai ludi.
I gladiatori, vestiti di toga, muniti delle loro armi, e dopo studiate evoluzioni, due per due andavano a presentarsi all’Imperatore, se presiedeva, ovvero al magistrato da lui delegato a presiedere in sua vece, se assente, acciocchè esaminasse le armi. Ora per potersi eseguire quest’esame dall’Imperatore o dal magistrato, faceva d’uopo che i gladiatori salissero fino al parapetto dei suggesti: era dunque necessaria una scala.
Nell’anfiteatro di Pozzuoli venne in luce una piccola scala addossata al muro del podio, dinanzi al pulvinare imperiale. Il can. Giovanni Scherillo, illustratore di quel monumento, opina che quella scala fosse costruita appunto alla scopo indicato. La ragionevolezza della cosa e la scoperta avvenuta nell’Anfiteatro Puteolano ci autorizzano ad argomentare che anche nell’Anfiteatro Flavio vi fosse il mezzo di salire dall’arena ai suggesti.
V’è questione fra i dotti se l’arena primitiva dell’Anfiteatro Flavio fosse o no sostrutta. Le ragioni dell’una e dell’altra opinione le esporrò quando si parlerà degli scavi praticati nell’Anfiteatro[264]. Noi vediamo oggi l’arena sostrutta, come sostrutta la vediamo negli anfiteatri di Capua, Pozzuoli e Siracusa. I sotterranei (hypogaea) servirono per poter dare improvvisi spettacoli. Nelle celle (cubilia)[265] si racchiudevano le belve destinate per lo spettacolo, le quali, per mezzo di elevatori meccanici[266], si facevano (al momento opportuno) [56] sbucare dal pavimento dell’arena. Quanto io asserisco ci è stato tramandato dagli antichi scrittori[267]; e d’altronde così doveva essere, perchè con sicurezza si potessero introdurre nell’arena le belve. Il pavimento dovè essere formato di un tavolato appoggiato su grosse travi; soltanto immaginandolo di tal fatta potremo darci ragione dei repentini cangiamenti di scena, facendosi comparire sull’arena, come vedremo nel seguente capitolo, fiere, monti, boschi artificiali, ecc.
Io congetturo che per introdurre le fiere nelle cellette si facesse così: si accostava la gabbia alla porticina della cella, e sollevato il cancello scorritore della gabbia, la bestia sbucava nella celletta, dove, appena entrata, si racchiudeva, facendo calare la saracinesca di ferro; in tal guisa la belva restava stretta in modo da non potersi muovere, posando sul pavimento mobile di legno, il quale, messo a suo tempo in movimento, la sollevava quasi fino al piano dell’arena: tanto, cioè, quanto bastava alla belva per uscirne fuori di un salto. Questa particolarità me la persuade tanto il maggior effetto che avrebbe prodotto l’impetuoso uscir delle fiere dal suolo, quanto il fatto di quell’orso, che, destinato a sbranare Saturo legato sul ponte de cavea prodire noluit.
Il sollevamento ed abbassamento dei cancelli delle gabbie e delle saracinesche delle cellette, si facevano comodamente dal ballatoio, del quale in breve parleremo, che ricorreva in alto innanzi alle celle.
Qui è necessario determinare che cosa s’intendesse dagli antichi del basso Impero per posticum e portae posticiae, allorquando essi parlavano di anfiteatri.
Il passo di Ammiano: «ut saepe faciunt amphitheatrales ferae, diffractis tandem solutae posticis», ci fa conoscere chiaramente che per postica s’intendevano i luoghi dove erano racchiuse le fiere, e donde queste sbucavano per dare spettacolo di sè nell’arena. Ci fa pur conoscere che questi luoghi erano chiusi alla bocca da sportelli che si disserravano: diffractis posticis; frase [57] che noi troviamo pur usata in una lapide Veliterna dei tempi di Valentiniano[268]: Amphitheatrum cum portis posticiis et omnem fabr.... Arene (sic.). Questa lapide mi sembra possa diradare la nebbia addensatasi attorno alle parole portis posticiis, e ci fa conoscere che tra le riparazioni fatte in quell’anfiteatro [58] furono rinnovati eziandio gli sportelli lignei alle bocche dei postica. Questi sportelli avevano non poca importanza, sia per il meccanismo necessario a disserrarli e richiuderli con prestezza, sia, e molto più, per il risalto e gradito effetto che acquistava per essi lo spettacolo della venatio. Di questo gradito effetto ce n’è prova un testo di Vopisco[269], il quale deplora l’immissione nell’arena di cento leoni, fatta da Probo una missione, e la loro insipida uccisione per il mancato effetto del furioso slancio delle fiere, che soleva avvenire [59] quando (diremo con Ammiano) diffractis tandem solutae posticis, balzavano sull’arena: ed io opino che questa sia la ragione per cui siffatti sportelli li troviamo ricordati nelle lapidi commemorative di restauri eseguiti negli Anfiteatri dopo il loro deperimento nella decadenza dell’Impero, gloriandosi i restauratori di avere con ciò rimessa l’arena nel suo perfetto essere.
E qui è bene notare che le aperture dalle quali nei giuochi si facevano uscire le belve, si dissero in ogni tempo portae. Le parole di Plauto[270] son chiare: «Citius a foro fugiunt, quam ex PORTA ludis cum emissus ut lepus»; parola con cui dopo l’invenzione degli anfiteatri furono chiamate anche le bocche delle cellette dalle quali uscivano le fiere, e quindi anche gli sportelli che le chiudevano; come accade anche adesso, che si dice porta tanto il vano che l’imposta che lo chiude.
Conosciuto ciò che fossero negli anfiteatri i postica e le portae posticiae, vediamo dove quelli e queste fossero.
Le bocche dei postica doveano comunicare coll’arena, se da essi sbucavano le fiere. Negli anfiteatri non v’erano che due porte che immettessero nell’arena, e queste due grandi porte si trovavano alle estremità dell’asse maggiore: una era la principale, e potremmo dirla pompae; l’altra era la libitinensis. A nessuno potrà cadere in mente che da queste porte sbucassero le fiere propriamente dette. Nella parete poi che attorniava l’arena e sosteneva il terrazzo del podio, non v’erano nè potevano esservi porte a quel fine, perchè dietro di quella parete girava un corridoio, il quale era destinato, come in breve vedremo, ad uso delle persone ragguardevoli che occupavano il ripiano del podio. Ma anche dato e non concesso che nella parete attorno all’arena vi fossero state porte allo scopo suddetto, come queste si sarebbero potute chiamare posticae se stavano davanti?!...
Ma dove adunque dovremo noi ricercare il luogo per il quale le fiere sbucavano nell’arena? Non altrove che nell’ipogeo dell’arena stessa: in quei pozzi stretti, oscuri e necessariamente coperti da sportelli di legno. Se poi mi si domandasse la ragione per cui quei pozzi si fossero potuti chiamare postica (almeno dal sec. IV in poi, epoca degli esempî che possediamo), risponderei:
Il sostantivo neutro posticum ha due significati: 1º uscio di dietro della casa; 2º bottino degli agiamenti[271]. In questo secondo senso gl’interpreti ed i lessicografi spiegano quell’appositum posticum di Lucilio[272]: Pistrino appositum posticum — sella, culina. — Ed invero le cellette in cui si racchiudevano le fiere, per poi da esse farle sbucare sull’arena, aveano la forma di veri bottini; cosicchè non disse male Ammiano allorchè scrisse che Massimino [60] era furibondo come erano spesso le fiere anfiteatrali, quando uscivano finalmente libere dai disserrati bottini. E qui si noti che nella lapide Veliterna del IV secolo cadente, che noi già riportammo, non si legge portis posticis, porte, cioè, della parte posteriore dell’anfiteatro (espressione, d’altronde, da non potersi intendere, come saggiamente osserva il ch. Lanciani[273], che relativamente a quegli anfiteatri i quali stanno sul limite estremo di una città, ovvero in quelli che avevano o uno o due o quattro soli ingressi, ovvero a metà incassati sotterra), ma portis posticiis, con due i, ossia gli sportelli dei bottini. Una porta appunto posticia era quella che una leonessa (per non offendere i ss. Taraco e compagni, tornatasene al bottino donde era uscita, e trovatane chiusa la bocca) tentò di rompere coi denti.
Nell’Anfiteatro Flavio le celle per le fiere erano 72, disposte in quattro corsie parallele all’asse maggiore[274].
Cinque ambulacri, tre rettilinei e due mistilinei, fiancheggiavano le corsie che contenevano le celle. Parallelamente ai lati curvilinei degli ultimi dei cinque ambulacri ne correvano altri due, comunicanti tutti fra loro. Negli ambulacri venivano all’occorrenza disposte le macchine (pegmata), le quali, fatte uscire dalle aperture del pavimento dell’arena, andavano crescendo, e talora si elevavano ad altezza considerevole[275]. Queste macchine, dal regno di Vespasiano a quello di Adriano, si costruirono sulla summa Sacra Via, nell’officina summum choragium. In Marziale[276] leggiamo:
Inde sacro veneranda petes Palatia clivo,
Plurima qua summi fulget imago ducis.
Nec te detineat miri radiata Colossi.
Quae Rhodium moles vincere gaudet opus,
Flecte vias hac. . . . . . . . . . .
E nel libro Spectaculorum, Epig. II, dice:
Hic ubi sidereus proprius videt astra Colossus
Et crescunt media pegmata celsa via.
Lo deduciamo pur anche dalle osservazioni che l’architetto Apollodoro fece ad Adriano: «quod sublime illud (il tempio di Venere e Roma) et vacuum [61] fieri oportebat, ut ex loco superiori in Sacram Viam magis conspicuum esset et in concavitate machinas exciperet, ita ut latenter in eo compingi et ex occulto in theatrum duci possent»[277].
Dopo l’edificazione del tempio di Venere e Roma, quell’officina fu traslatata nella regione d’Iside e Serapide, e là ce la ricordano i ragionarî del secolo IV; ma anche così distava poco dall’Anfiteatro.
Nell’ambulacro centrale e nei due laterali v’erano, addossate alle pareti, delle branche di scale, per le quali s’ascendeva ad un ballatoio, che ricorreva in alto dinanzi alle celle delle fiere.
I muri di sostruzione dell’arena sono composti di grandi massi di travertino, di tufo e di costruzione laterizia[278]. A m. 6,08 circa dal piano dell’arena v’è un pavimento ad opus spicatum, nel quale, oltre al canale per lo scolo delle acque, si veggono massi quadrati di pietra tiburtina, con una bocchetta incavata nel mezzo.
Dalla parte settentrionale s’apre sull’andamento dell’asse minore una strada sotterranea o cripto-portico, larga m. 2,95, la quale si dirige verso l’Esquilino. Un altro cripto-portico, con un accesso della larghezza di m. 2,17 che poteva chiudersi con una saracinesca, trovasi sull’andamento dell’asse maggiore, in direzione del Laterano. Il pavimento di questo sotterraneo, è elevato sopra quello dell’ipogeo dell’arena m. 1,50 circa, a cagione di uno speco, che corre sotto al pavimento del corridoio, seguendone la direzione.
Ai lati del cripto-portico vi sono otto celle; con queste e con quello comunicano per mezzo di scale due grandi stanze, lunghe m. 25, larghe m. 3,20; il pavimento delle quali si trova allo stesso livello di quello dell’arena, e quindi più basso del pavimento del cripto-portico e delle celle laterali di m. 1,50 circa. Si conservano tuttora sei massi quadrilateri di travertino, simili a quelli dell’ambulacro curvilineo, ma aventi le bocchette munite di boccolari metallici. — Altre bocchette, ma senza metallo, le vediamo nel suolo di cinque delle otto celle che fiancheggiano il cripto-portico. Questi massi e queste bocchette, la cui forma circolare suscita naturalmente l’idea di assi verticali giranti, sono le tracce del grande movimento dei meccanismi dell’ipogeo dell’arena. Da questo corridoio, per mezzo di due scale, si ascende al piano del vestibolo ad esso soprapposto. Le due scalette sboccano nel detto vestibolo in prossimità della porta libitinense.
Il cripto-portico è spurgato per la lunghezza di m. 83,90; esso, fino al portico esterno dell’Anfiteatro, ha le pareti composte di grandi massi di travertino, dalle quali sporgono a distanze pressochè uguali cinque pilastri, congiunti [62] nella parte superiore da piattabande formate di grossi cunei di travertino. Il tratto interno del cripto-portico fu probabilmente coperto da soffitto di legname. Questa strada sotterranea, uscita fuori dal perimetro dell’Anfiteatro, ha le pareti e la volta di mattoni; e a m. 12 circa dal perimetro stesso, lascia a destra un altro corridoio con piano inclinato; cosicchè dopo un lungo percorso doveva sboccare sopratterra. Quest’ultimo corridoio, il cui andamento seconda la curva dell’Anfiteatro, a m. 6 circa dal punto ove si dirama dal cripto-portico è traversato da una porta, la quale ha un arco laterizio e la soglia di travertino.
Un terzo cripto-portico, uguale a quello ora descritto, si apriva dalla parte opposta, seguendo sempre l’andamento dell’asse maggiore. Già fu esso scoperto in gran parte negli scavi praticati dal Governo Francese nei primi anni del secolo XIX[279]; ora rimane interrato, come per la metà è pur interrato l’ipogeo dell’arena.
Di un quarto cripto-portico, sull’andamento dell’asse minore, incontro a quello che si dirige all’Esquilino, se ne ha un indizio in un pozzo scoperto a Sud-Ovest dell’Anfiteatro, e precisamente dinanzi all’arco mediano esterno, che dava accesso al pulvinare imperiale.
Oltre a questi quattro cripto-portici, disposti simmetricamente sull’andamento dei due assi maggiore e minore, ve n’è un quinto, il quale, partendo dal sottopodio presso il pulvinare imperiale (dal quale vi si discendeva per una scala), ricorre sotto il cuneo V, giusta la numerazione degli archi, ed a pochi metri dal perimetro dell’Anfiteatro rivolge, ad angolo quasi retto, dalla parte del Laterano.
Il pavimento di questo corridoio era a mosaico; la volta era adorna di stucchi, dei quali rimangon tracce; ed aveva di tanto in tanto, ora a destra ora a sinistra, degli abbaini, dai quali prendeva luce; le pareti erano dipinte, ma nel basso avevano uno zoccolo di marmo. Sembra andasse con piano inclinato a riuscire sopratterra poco lungi da dove sboccava il corridoio[280] testè descritto. Fu sgombrato dalle terre e macerie per circa 37 metri.
Si ritiene comunemente, e credo a ragione, che questo cripto-portico fosse quell’andito angusto ricordato da Dione[281], dove il congiurato Claudio Pompeiano tentò di uccidere Commodo, allorchè questi per quell’andito si recava all’Anfiteatro. Io ritengo con alcuni archeologi che questo cripto-portico fosse senz’altro opera di Commodo.
[63]
Ma è già tempo di descrivere la cavea. La cavea del nostro Anfiteatro era divisa in cinque parti: il podio, tre ordini di gradi ed il portico[282].
Il podio (determinato da una praecinctio e dal rispettivo iter) era composto di un ordine di sette gradi[283] ai quali si accedeva per dodici vomitorî aperti nella praecinctio, e di un ripiano largo circa due metri (dove venivan disposti i subsellia), il quale, girando a piè della piccola gradinata, dava immediatamente sull’arena. Esso era munito di un parapetto a transenna, ed aveva otto vomitorî proprî, pei quali s’accedeva indipendentemente dalla gradinata. La larghezza dello spazio occupato dall’iter della praecinctio dalla gradinata e dal ripiano è (presa orizzontalmente) di m. 8 circa. Il muro del podio, che faceva fronte sull’arena, era alto m. 5, compreso il parapetto a transenna.
Che il podio fosse formato come l’ho descritto, risulta dalle espressioni degli antichi scrittori[284], confermate dall’esame dei suoi ruderi.
Sotto il ripiano dei subsellia v’era un ambulacro, al quale s’accedeva dal corridoio che girava a piè delle scale dei vomitorî del detto ripiano. L’ambulacro aveva m. 1,80 circa di larghezza; e nella parete opposta a quella che fronteggiava l’arena, aveva, in ogni quarto dell’ovale, sei nicchie rettangolari, quattro delle quali della larghezza di m. 2: le altre due erano di minor larghezza; tutte però avevano una profondità uguale di un metro, e tutte ugualmente eran alte m. 2 circa. — A proposito di questo corridoio, il Nibby[285] scrive: «di marmo era inoltre fasciato il corridore sotto di esso (ripiano del podio) che oggi è parte dell’arena, nel quale i riquadri allorchè vennero scoperti conservavano tracce di essere stati ornati di stucchi analoghi per lo stile a quelli della sala d’ingresso degl’Imperatori». — Io congetturo che ivi fossero gli agiamenti o cessi per i personaggi che occupavano il ripiano del podio. Si vedono tuttora nel basso delle nicchie le cloache coperte a capanna, [64] e qualcuna ve n’è anche nei piloni tra una nicchia e l’altra, al piano del pavimento. Eran essi indispensabili, e specialmente in quei luoghi ove le persone si trattenevano per lunghe ore e talvolta per una intiera giornata. Suetonio scrisse di Augusto che nel circo «spectabat interdum e pulvinari, et quidem cum coniuge ac liberis, sedens spectaculo plurimas horas; aliquando totos dies aderat»[286]. Tal comodo dovette esservi per tutti gli ordini della gradatio, e probabilmente furono ridotti a tal uso i vuoti dei sottoscala. — Lo studiato sistema di chiaviche nel substrato dell’Anfiteatro servì a smaltire parimente le acque piovane e le immondezze degli agiamenti.
La forma del podio era ovale, e secondava il perimetro dell’arena; ma i due grandi ingressi di questa lo interrompevano, facendogli formare due bracci. Nel centro di ciascuno di essi v’erano i due suggesti; dei quali quello a sud-ovest era il pulvinare imperiale; ce lo indicano e la sua posizione ed il passaggio chiamato giustamente di Commodo, il quale termina precisamente a quel suggesto. Ho detto la sua posizione, perchè trovasi nella parte più nobile dell’Anfiteatro: parte che fu sempre rappresentata sulle medaglie a preferenza delle altre, e che è rivolta verso la regia Palatina. Ivi sedeva l’Imperatore, e di lì presiedeva agli spettacoli.
L’altro suggesto era di fronte al pulvinare, ed era destinato principalmente al magistrato delegato dall’Imperatore a presedere in sua vece ai giuochi. Si accedeva ai suggesti per i due ingressi principali, rivolti l’uno al Celio e l’altro all’Esquilino[287]; e si passava per due saloni, divisi ciascuno da diciotto pilastri di travertino, con arcate e volte ornate di stucchi. «Prima del terremoto del 422, scrive il ch. Lanciani[288], lungo l’orlo del suggesto più basso della cavea (dove sedevano i personaggi clarissimi) al disopra del podio correva una cornice marmorea, modinata a somiglianza delle basi attiche[289], e questa cornice reggeva il parapetto o pluteo che forse era di bronzo, forse di marmo. Lo scuotimento della terra avendo rovesciato giù nell’arena cornice e parapetto, colui che condusse i risarcimenti nell’Anfiteatro non volle o non potè riporre le cose al luogo loro. I massi marmorei della cornice furono fatti girare di 90, di modochè la cornice che prima stava sulla fronte dei medesimi si trovò sul piano di sopra, ed il piano di sotto, cioè il piano di posatura primitivo, divenne la fronte. Su di essa furono incise una o più lunghissime leggende a lettere assai grandi, le quali leggende vennero così a fare il giro di tutto il suggesto o di tutto il podio».
[65]
Nel podio, come si disse, avevano il loro posto i personaggi più illustri, e da prima i Senatori, ai quali (secondo il decreto emanato da Augusto[290] e che a mio parere fu in vigore in ogni tempo) era riservato il primo ordine dei subsellia: ordine che nell’Anfiteatro Flavio fu probabilmente primus et unicus, e situato senza dubbio nel ripiano del podio immediatamente prossimo all’arena. Dissi primus et unicus, perchè lo spazio di due metri non potè essere capace che di un solo ordine di subsellia, attesochè dietro di essi dovea rimanere lo spazio sufficiente per il passaggio.
Oltre ai Senatori, sedevano nei gradi del podio le persone investite delle più alte dignità sacerdotali, i clarissimi delle famiglie dei Senatori, i viri consulares, i magistrati curuli e gli ambasciatori esteri. Prudenzio ci attesta che avean posto nel podio eziandio le Vestali, le quali nei pubblici giuochi furono sempre tenute in considerazione[291]. Cicerone accenna al posto che esse aveano nei giuochi gladiatorî: nec si virgo vestalis, huius (L. Nattae) propinqua et necessaria, locum suum gladiatorium concessit huic[292]. Augusto, facendo eccezione alla disposizione data per le donne, assegnò alle Vestali un posto ragguardevole nel teatro: «Solis virginibus vestalibus locum in theatro separatim et contra praetoris tribunal dedit»; e Prudenzio, come ora dicevamo, ce le indica sedute nel podio del nostro Anfiteatro, anzi nella miglior parte di esso:
An quoniam podii meliore in parte sedentes[293].
Ora ci domandiamo: qual fu la miglior parte del podio assegnata alle Vestali?
Non possiamo ritenere che esse sedessero nell’ordo subselliorum insieme coi Senatori, perchè, come osserva lo Hübner[294], non è noto «che anche nell’anfiteatro e nel circo le Vestali avessero partecipato ai posti dei Senatori». [66] E poi, se vogliamo accettare come precisa l’espressione di Prudenzio: «Podii MELIORE IN PARTE sedentes», noi non dovremo ricercare le Vestali fra i Senatori, per la ragione che nel podio v’era qualcosa di meglio dell’ordine dei subsellia. La miglior parte del podio erano indiscutibilmente i due suggesti. Non mi sembra ammissibile che le Vestali sedessero nel pulvinar, perchè questo suggesto era riservato all’Imperatore; ed ebbe il nome di pulvinar (nome proprio della sedes o lectisternium deorum) «quasi che (dice il Morcelli) in quel suggesto imperatoris tamquam numinis sedes esset». Che ivi sedesse eziandio la famiglia imperiale masculini sexus, lo possiamo dedurre dalle parole di Svetonio, il quale narra che Augusto «spectabat interdum e pulvinari, et quidem cum coniuge[295] ac liberis»: che vi sedessero talvolta anche le persone estranee alla famiglia imperiale invitatevi dall’Imperatore, ce ne fanno fede e il fatto di Tito, che invitò i due patricii generis convictos in affectatione imperii ad assistere al suo fianco ai giuochi gladiatorî, ed ai quali patrizî oblata sibi ornamenta pugnantium inspicienda porrexit[296]; e l’altro fatto di Domiziano, il quale per tutto il tempo dello spettacolo gladiatorio aveva con sè il fanciullo portentoso parvoque capite, cum quo plurimum fabulabatur, nonnunquam serio[297]: ma che vi sedessero anche le Vestali, lo ignoriamo. Anzi dai due decreti emanati nel regno di Augusto, e che sono di questo tenore: 1.º Faeminis ne gladiatores quidem, quos promiscue spectari solemne olim erat, nisi ex superiore loco spectare concessit. Solis virginibus vestalibus locum in theatro separatim et contra praetoris tribunal dedit[298]. 2.º[299] Quoties Augusta theatrum introisset, ut sedes inter vestalium consideret[300], mi pare potersi dedurre che le Vestali non sedessero insieme all’Imperatore nel pulvinare. Io inoltre opino che il primo decreto destasse non poco malumore nel popolo, giacchè gladiatores promiscue spectari SOLEMNE olim erat; ed in tal caso Augusto dovè non disprezzare il pericoloso fermento, e cercare un mezzo opportuno onde calmare il malcontento suscitatosi; e forse fu questa la ragione per cui emanò un secondo decreto col quale stabiliva che neppure all’Imperatrice fosse lecito di assistere agli spettacoli «promiscue», ossia, nel caso suo, coll’Imperatore nel pulvinare; ed essa era in obbligo, andando in teatro, assidersi fra le Vestali, mostrando così che la legge era uguale per tutti[301]. Di qui apparisce chiaramente che le Vestali [67] non sedevano nel suggesto imperiale; e poichè occupavano la miglior parte del podio, non ci rimane che assegnar loro il luogo più distinto dopo il suggesto imperiale, vale a dire il suggesto che era di fronte al pulvinare. Ivi, come dicemmo, sedeva il personaggio delegato dall’Imperatore a presedere ai giuochi in sua vece; alla sua destra, in separato scompartimento (separatim), le sei Vestali[302]; alla sinistra, i consoli insieme al munerator, editor o dominus, alle cui spese si davano i giuochi, e che in quella circostanza aveva le insegne e l’autorità di un magistrato. Severino Boezio ci mostra l’editor nel circo, assiso appunto tra i due consoli: «Cum in circo duorum medius consulum circumfusae multitudinis expectationem triunphali largitione satiasti?»[303].
Nè mi sembra di avere esagerato, assegnando alle Vestali anzichè ai Consoli la parte destra; poichè sappiamo che questi, qualora si fossero imbattuti con le sacerdotesse di Vesta, dovean ceder loro il passo; e che, secondo il decreto del 776 d. R., tra le Vestali dovea avere il suo seggio l’Augusta.
Per completare la descrizione del podio, ci resta di parlare dell’apparecchio di cui questo era munito onde gli spettatori fossero sicuri dagli assalti delle fiere. Di quest’indispensabile apparecchio se ne avea già una vaga notizia, e sapevasi che consisteva in una serie continua di reti tessute di grossi fili metallici[304]: ma non ci sarebbe stato certamente possibile farne una descrizione esatta, se il poeta Calpurnio, vissuto ai tempi di Carino e Numeriano, non avesse nei suoi versi così particolareggiatamente parlato della sua struttura e magnificenza. Egli dice che al termine dell’arena dell’Anfiteatro Flavio, verso il muro marmoreo del podio, era distesa tutt’attorno un’ammirabile serie di rulli d’avorio, che, girando intorno ad assi, rendevano impossibile alle fiere l’appigliarvisi con le unghie, facendole, se vi si fossero provate, ricadere subito al basso. Aggiunge che v’era una rete tessuta di aurei [68] fili, insieme a molti denti di elefante sporgenti in sull’arena, tutti d’egual grandezza e lunghi più ancor d’un aratro[305].
Da questa descrizione mi sembra poter dedurre come fosse nell’Anfiteatro Flavio disposta quest’opera di difesa. A breve distanza dal muro del podio del nostro Anfiteatro, al termine della zona che noi già dicemmo morta, sorgevano ad eguali intervalli delle travi foderate di bronzo, in tutto o in parte dorate, collegate a due a due da una trave orizzontale, formando così un dolce poligono inscritto nell’ovale: poligono necessario per il movimento dei rulli, il quale sarebbe stato impossibile ottenere su di una curva; — sull’alto delle travi poi erano solidamente fissati i robusti assi rettilinei, intorno ai quali giravano i rulli d’avorio. Negli specchi fra una trave e l’altra erano tessute le reti, e dalle fronti delle travi sporgevano i denti verso l’arena.
Al podio seguiva immediatamente un ordine di dodici gradi, determinato da una praecinctio, col suo iter largo m. 3,50. Questa straordinaria larghezza dell’iter è dovuta ai quaranta abbaini, fatti in esso per illuminare il sottoposto ambulacro. La gradinata ha quattordici vomitorî aperti nella praecinctio, era destinata ai quattordici ordini dei cavalieri, e costituiva la prima cavea.
Segue quindi un terzo ordine di diciannove gradi, determinato esso pure da una praecinctio col suo iter. Quest’ordine ha trentadue vomitorî, sedici dei quali sboccano alla metà della gradinata e sedici dalla praecinctio. Questa era straordinariamente alta, ed in essa, oltre le porte dei vomitorî, v’erano ventotto finestre, dalle quali prendeva luce il corridoio posteriore. La serie delle finestre era frammezzata con simmetria da trentasei nicchie con statue. V’ha chi opinò che quei tripodi marmorei, con faccia piana nella parte posteriore per addossarsi al muro, rinvenutisi negli scavi dell’Anfiteatro (la loro non poca quantità ci fa argomentare ve ne siano stati in buon numero), fossero collocati in quelle nicchie per bruciarvi sostanze aromatiche. Ma collocando i tripodi in quegli incavi ed in quella sola precinzione, mal si sarebbe provveduto al fine cui essi erano destinati. A me sembra più ragionevole che i tripodi fossero stati addossati esternamente alle pareti di ciascuna delle [69] precinctiones, ove le essenze odorifere avrebbero prodotto il loro completo effetto, e tutto l’ambiente anfiteatrale sarebbe rimasto egualmente profumato.
Che quelle nicchie poi invece di tripodi contenessero statue, ce lo fa argomentare ciò che si legge nelle Memorie Enciclopediche Romane[306], «Si sono trovate negli scorsi giorni sull’alto del Colosseo fra scarichi antichi di macerie, due torsi di donne panneggiate assai bene, una delle quali si vede aver avuta la testa incassata, cosa non rara nelle statue antiche; mancano ambedue di testa, braccia e piedi; dovettero probabilmente ornare quel giro di nicchie ancora esistenti che al di sopra della seconda precinzione facevan prospetto all’Anfiteatro».
Questa praecinctio straordinaria, che, a guisa di grandiosa fascia, cingeva l’immensa cavea, io congetturo che sia il balteus di Calpurnio, decorato probabilmente da intarsî di fine pietra e forse anche da mosaici di smalto.
La parola balteus, che vuol dire propriamente cingolo[307], s’adoperò dagli oratori[308] e dai poeti come sinonimo di praecinctio, benchè questa e non quella sia la voce tecnica per indicare le zone verticali che dividevano in diversi ordini la gradatio dei teatri, degli anfiteatri e dei circhi. Questo terzo ordine costituiva la media cavea.
A quest’ordine ne seguiva un quarto, summa cavea, composto di sette gradi, la cui praecinctio formava zoccolo al basamento del portico. Anche qui l’iter girava al basso della gradinata ed ivi sboccavano dodici vomitorî.
La cavea era coronata da un portico di ottanta colonne di ordine composito. La gradinata del portico, costruita da legname, si componeva di undici gradi, ed era divisa da tavolati (tabulationes)[309].
La parte della cavea dalla praecinctio della gradinata assegnata ai quattordici ordini dei cavalieri a tutta la summa cavea (ossia la media e la summa cavea), nonchè una buona parte del portico, era destinata ai cittadini, plebs, la quale plebs con ogni verosimiglianza, era divisa secondo le tribù.
I varî ordini di cittadini che vi avevano cunei propri, e dei quali abbiamo particolar notizia, sono i seguenti:
a) I Tribuni. Leggiamo in Dione[310] che fra gli onori decretati a Giulio Cesare v’era: «ut semper sella curuli sederet, excepto per ludos. Tum enim sessio ei in tribunicio subsellio inter eos qui quoque anno Tribuni essent concedebatur». [70] E similmente fra quelli decretati ad Augusto: «ut in subselliis Tribunorum plebis sederet»[311]. In Calpurnio leggiamo:
«Nivei loca densavere Tribuni»
Presso i Tribuni ebbero luogo speciale i loro viatores. Tacito[312] scrive: «liberto et accusatori praemium operae, locus in theatro inter viatores tribunicios datur».
b) I COLLEGI SACERDOTALI: eccettuate le persone costituite nei gradi più alti del sacerdozio, le quali, come già si disse, sedevano nel podio. Arnobio scrive: «Sedent in spectaculis publicis sacerdotum omnium collegia». I collegi sacerdotali officiali erano otto: Pontifices, VII viri epulones, XV viri sacris faciundis, augures, fetiales, arvales, sodales Titii, Salii. — I collegi semi-officiali erano cinque: Collegium Lupercorum, Collegium Mercurialium, Collegium Capitolinorum, Collegium Veneris Genetricis, Collegium Minervae.
V’erano poi le Sodalitates: sodales Matris magnae, Augustales, Claudiales, ecc.
I posti assegnati al collegio degli Arvali ce li ricorda con esattezza la nota lapide[313], e la chiara notizia che questa ci porge ci potrà servire di guida per investigare dove avessero avuto posto gli altri collegi sacerdotali.
c) I Patres familias. «Maritis e plebe proprios ordines assignavit»[314]. Marziale[315] dice:
«Sedere in equitum liceat an tibi scamnis,
Videbo Didyme: non licet maritorum».
d) I Praetextati. Pueri nobiliores et honestiores, e vicini a questi i pedagogi. Ce l’attesta Svetonio: «Praetextatis cuneum suum et proximum PEDAGOGIS». Di questi due cunei rimangon tracce nell’Anfiteatro Flavio, in due gradi, nella fronte dei quali leggiamo le lettere:
ETEXT
VIIIS
(C. I, l. VI, parte 4, 32098c).
E nella fronte dell’altro:
(paedagogis) (p) VERO (rum)
(C. I, l. VI, parte 4, 32098d)
[71]
e) La Milizia. «Militem secrevit a populo» Svet.
Alla classe meschina della cittadinanza fu assegnata la maggior parte del portico. Suetonio ci dice che Augusto «sanxitque ne quis pullatorum media cavea sederet», e noi per la testimonianza di Calpurnio dobbiam dire che nell’Anfiteatro Flavio non solo quella classe non sedette nella media ma neppur nella summa cavea, e che ebbe il suo posto unicamente nel portico:
«Venimus ad sedes ubi pulla sordida veste
Inter femineas spectabat turba cathedras.
Nam quocumque patent sub aperto libera coelo
Aut eques aut nivei loca densavere tribuni».
Nel portico ebbero parimenti posto le donne: «inter femineas spectabat turba cathedras». La legge augustea relativa al posto che le donne doveano occupare nei pubblici spettacoli rimase sempre in vigore, ed io opino (come già accennai) che riguardasse le donne tutte, di qualunque grado si fossero, eccettuate le Vestali e l’Imperatrice. Le parole usate da Suetonio «feminis» (termine generico) e «solis Vestalibus» (contrapposto a «feminis») bastano da sè sole a provare l’universalità della legge. Al passo di Suetonio s’aggiunga l’autorità di Calpurnio. Questo poeta non è satirico, e quindi nelle frasi e nelle parole di quel pastorale componimento in cui egli ci descrive l’Anfiteatro Flavio, non ci è lecito sospettare nascosti sali mordaci. Ora dicendoci il poeta che la «turba pulla» sedeva inter femineas cathedras; sapendo che la cathedra non era sedia per donne volgari, mi pare che Calpurnio venga a confermarci che la legge colpì le donne tutte, non escluse quelle di grado elevato.
Sennonchè qual sarà stata la ragione per cui fu assegnato alle donne il portico? Se questo provvedimento fosse stato determinato da soli motivi di moralità, bastava che Augusto le avesse raccolte in cunei separati, mantenendole nell’ordine corrispondente alla rispettiva casta!... La ragione che mosse Augusto ad assegnare alle donne il portico, a me sembra di poterla scorgere nella confusione grandissima che dovea nascere allorquando una pioggia avesse interrotto lo spettacolo e costretti gli spettatori a ricoverarsi nei portici, i quali, come dice Vitruvio[316], si facevano appositamente a questo scopo: «Post scenam porticus sunt constituendae, uti cum imbres repentini ludos interpellaverint, habeat populus quo se recipiat ex theatro».
La ressa per uscire dai vomitorî sotto la sferza di una pioggia dirotta dovè essere stato qualche cosa di serio. Questo gravissimo inconveniente fu forse il motivo precipuo che spinse Augusto ad assegnare alle donne posto [72] nel portico. In caso di pioggia esse non sarebbero state costrette a muoversi; e su dai loro posti avrebbero potuto tranquillamente godersi la fuga di quell’immensa moltitudine. Spettacolo invero esilarante per chi non si trovava in mezzo a quel parapiglia! — Senza questa provvida disposizione il confusissimum atque solutissimum morem spectandi non sarebbe stato sufficientemente corretto.
La legge di Augusto rimase in vigore per tutto il periodo imperiale. Ai tempi di Carino e Numeriano[317] le donne sedevano ancora nella parte più alta dell’Anfiteatro, vale a dire nel portico. Nè poteva essere altrimenti, perchè la causa determinante della legge era sempre viva; e i teatri, gli anfiteatri ed i circhi rimasero in tutto il periodo imperiale quali erano ai tempi di Augusto.
Occorreva però un temperamentum che rendesse alle donne nobili del patriziato e alle doviziose della plebe meno dura l’impressione di trovarsi (sebbene del tutto separate) sotto lo stesso tetto colla parte più meschina della cittadinanza. Questo temperamentum fu opportunissimo; e nella nota lapide degli Arvali ve ne troviamo sicure tracce. In essa leggiamo che ai detti fratelli, oltre agli VIII gradi del meniano I ed ai IV nel II sommo, furono assegnati XI gradi nel MENIANO SUMMO IN LIGNEIS alla tabulatio LIII. Dunque nel portico, tra la turba pulla, oltre le donne ebbero luogo anche gli Arvali; e come ve l’ebbero gli Arvali, vi poterono aver luogo gli altri collegi sacerdotali. Posto ciò, io credo di non essere troppo ardito, se, basato su questi dati, espongo la mia opinione circa la disposizione degli spettatori nel portico.
Nei quattro punti del portico, corrispondenti alle estremità dell’asse maggiore e minore, si destinarono alcuni intercolonnî per le donne; e riterrei ragionevole, che alle estremità dell’asse minore (sulle quali eranvi anche i due nobilissimi suggesti) sedessero le donne del patriziato; e che alle estremità dell’asse maggiore fossero destinati alcuni intercolonnî per quelle della plebe, escluse, ben inteso, le pullatae.
Il numero degl’intercolonnî dovette essere proporzionato alla quantità delle donne dell’una e dell’altra classe; e poichè il numero delle plebee superava indiscutibilmente quello delle patrizie, le prime dovettero avere nel portico un numero maggiore d’intercolonnî.
La tabulatio assegnata agli Arvali è la LIII. Da quest’intercolonnio a quello di mezzo ve ne sono altri quattro; sicchè, prendendone pure quattro dalla parte opposta ed il mediano, alle donne plebee sarebbero stati assegnati nove intercolonnî in ciascuna delle due estremità dell’asse maggiore. Ragion vuole poi che la tabulatio simmetrica a quella degli Arvali (ossia la LXII) fosse stata assegnata ad un altro collegio sacerdotale.
[73]
Il provvedimento fu, come si disse, opportunissimo, perchè le donne si videro onorate di potersi assidere fra la classe dei cittadini più veneranda; e la plebe misera, che (già fin dai primi decreti di separazione nell’assistere ai ludi, emanati, per testimonianza di Livio, da Scipione Africano) aveva dimostrato forte risentimento, si trovò fra la nobiltà, l’agiatezza ed il sacerdozio; in una parola, il provvedimento fu tale, che lasciò tutti contenti e..... gabbati.
Alle donne della plebe misera furono verosimilmente assegnate nel mezzo della turba pulla due tabulationes nei quattro centri dei quadranti dell’ovale fra le estremità degli assi maggiore e minore. Le donne del patriziato e quelle dell’alta plebe sedettero (come si deduce da Calpurnio) in cattedre più o meno ricche secondo il grado; le clarissimae forse ebbero cattedre mobili nella prima fila; le altre l’ebbero probabilmente fisse nei gradi, nei quali ciascun dei posti fu guarnito di una spalliera concava.
I quattro gruppi d’intercolonnî destinati alle donne del patriziato e dell’alta plebe dovettero esser decorati più che gli altri del restante del portico, ed arricchiti di dorature. Ne abbiamo un cenno in una lapide di Terni (Orell. 3279) che dice:
OPVS. THEATRI. PERFECIT. IN. MVLIEBR.
AERAMENTIS. ADORNAVERE.
Poste le cose in questa guisa, i versi di Calpurnio acquistano una chiarezza che forse prima, almeno per me, non avevano.
«Venimus ad sedes ubi pulla sordida veste
Inter femineas spectabat turba cathedras
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balteus en gemmis EN ILLITA PORTICUS AURO
Certatim radiant.....».
Sulle iscrizioni dei sedili e sulla distribuzione dei loca, abbiamo uno studio interessante del ch.º R. Lanciani[318], il quale mi pregio prendere per mio duce e maestro; ed egli permetterà che io usi, qui, delle stesse sue dotte parole.
«La divisione dei posti, discrimina ordinum[319], nell’Anfiteatro, a tenore delle leggi già promulgate, dell’etichetta e delle precedenze di corte, dei privilegi, [74] dei diritti acquisiti, delle costumanze invalse fra i varî ordini dei cittadini, fu fatta nell’anno stesso della solenne dedicazione dell’Anfiteatro, e naturalmente prima che questa avesse luogo, imperando Tito, consoli suffetti L. Elio Plauzio Lamia, Q. Pattumeio Frontone. Se ne ha memoria negli atti arvalici dell’anno stesso[320], dei quali sarà fatta più speciale menzione fra poco. Non so spiegare per quale ragione lo Hübner sia stato indotto a credere tale assegnamento di posti posteriore di un anno alla dedicazione dell’Anfiteatro[321] poichè la testimonianza di quegli atti e specialmente della frase loca adsignata (fratribus arvalibus) in amphit(h)eatro L. Aelio Plautio Lamia, Q. Pactumeio Fr(o)ntone cos non ammette discussione.
«L’ufficio di distribuire i posti, in questa solennissima contingenza, fu affidato a Manio Laberio Massimo, procuratore della Giudea sotto Vespasiano[322], prefetto dell’annona nell’anno 80[323], il quale è stimato dal Cardinali[324], consenziente il Borghesi[325], la medesima persona col Manio Liberio Massimo, legato della Mesia e console per la seconda volta nell’anno 104.
«Il Marini, il Guasco, il Torre, il Morcelli, lo Hübner hanno interpretato in vario senso cotesta ingerenza di Laberio prefetto dell’annona nella distribuzione dei sedili anfiteatrali. La frase loca adsignata...... ab Laberio Maximo procuratore praef. annonae..... curatore Thyrso l. è certamente oscura, e non trova riscontro nell’epigrafia contemporanea. Una sola cosa è certa, ed è che quei due individui ebbero la direzione nel gravissimo affare.
«Rimangono documenti intorno ai posti assegnati ai senatori, ai cavalieri, a varî collegi sacerdotali, agli ambasciatori ed agli ospiti, ai pretestati, ai pedagoghi dei fanciulli, agli apparitori dei magistrati, alla plebe, ai gregarî di stanza in Roma.
«Per gli altri ordini, collegi, sacerdozî, corporazioni ecc., si può supplire alla mancanza di documenti speciali con le notizie che si hanno indirettamente intorno le precedenze gerarchico-amministrative di ciascuno di essi. Prima di ragionare minutamente dei posti assegnati ai singoli gruppi e delle memorie che ne rimangono, incise sui marmi del Colosseo, mi è d’uopo stabilire due canoni fondamentali. In primo luogo, benchè le notizie relative ai singoli gruppi, che trarrò dagli scrittori e dai marmi, non si riferiscano tutte all’Anfiteatro, ma talora ai teatri, talora al foro, scena antichissima di giuochi gladiatorî, talora al circo, pure hanno uguale valore, uguale significato anche per l’Anfiteatro: [75] in quanto che Tito e Domiziano inaugurandolo e distribuendone i sedili, non poterono in modo alcuno derogare alle leggi promulgate sugli spettacoli, ed alle costumanze già invalse. Intorno a questo canone abbiamo splendida testimonianza nei marmi stessi dell’Anfiteatro, e sopratutto in quel sedile lungo m. 1,50, alto m. 0,39 e largo m. 0,45, sulla cui fronte leggermente ricurva sta scritto a caratteri del secol d’oro:
sigle che lo Hübner interpreta e supplisce: [collegio..... orum qu]ib. in theatr. lege pl[ebis] ve [scito..... sedere l]icet p. XII.....
Il Fea crede che la voce theatrum stia qui a far la vece di amphitheatrum: mentre è chiaro che tutt’intera la leggenda esprime questo senso: a tenore delle leggi, dei plebisciti, dei senatus consulti vigenti, si assegna al collegio dei tali e tali quel dato numero di piedi, quel dato posto, cui hanno diritto nel teatro. Del resto il senatus consulto di Augusto, cui accenna Suetonio si riferiva[326] ad ogni genere di spettacoli, e noi vedremo fra poco con quanta mirabile precisione le epigrafi dei sedili del Colosseo corrispondano ai singoli paragrafi di quel senatusconsulto[327].
«Il secondo canone si riferisce alla cronologia delle iscrizioni dei sedili. A partire dall’anno 80, fino a tutto il secolo terzo si incisero sui sedili soltanto i titoli dei varî ordini, corpi morali, gruppi ecc. con cifre indicanti il numero dei piedi cui ciascun ordine ecc. avea diritto di occupare: giammai si incisero nomi di individui.
«Nel secolo quarto incominciano ad apparire nomi senatori, individuali, predominando però il caso plurale, il che significa che coteste prime iscrizioni furono graffite per indicare il posto non di un individuo ma di una famiglia. Nel secolo quarto scadente e nei successivi, ogni senatore volle graffito il proprio nome nel sito ove la propria sedia e il proprio cuscino eran collocati in occasione di spettacoli. E siccome quest’uso ha durato per parecchie generazioni, così quelle pietre sono state incise e scalpellate sin quattro volte.
[76]
1. Senatores «Spectandi confusissimum ac solutissimum morem (Augustus) correxit, motus iniuria senatoris, quem Puteolis per celeberrimos ludos consessu frequenti, nemo receperat. Facto igitur decreto patrum, ut, quoties quid spectaculi usquam publice ederetur primus subselliorum ordo vacaret senatoribus[328]. La origine antichissima della confusione deve riconoscersi nel fatto che — prima del trionfo di L. Mummio — cioè prima dell’introduzione dei sedili di legno, tutti stavano in piedi nel circo o nel foro, pochissimi sedevano in terra o sugli scanni recati espressamente dai servi. Un’assemblea di gente in piedi non può non essere disordinata: pur tuttavia, la modestia e la riverenza del popolo verso i padri coscritti era spontanea e profonda abbastanza da lasciar loro i posti migliori. Narra Val. Massimo (4, 5, 1), che dalla fondazione di Roma fino all’anno 560, promiscuus senatui et populo spectandorum ludorum locus erat; nunquam tamen quisquam ex plebe ante patres conscriptos in theatro spectare sustinuit; adeo circumspecta nostrae civitatis verecundia fuit. In quell’anno 560, nel quale la supremazia del governo senatorio sul plebeo fu definitivamente costituita, i senatori furono separati dalla plebe negli spettacoli. Per quingentos autem et quinquaginta octo (560) annos senatus populo mixtus spectaculo ludorum interfuit. Sed hunc morem Atilius Serranus et L. Scribonius aediles, ludos matri deum facientes, superioris Africani sententiam secuti, discretis senatus et populi locis solverunt[329]; e Livio conferma: Censores Sex. Aelius Paetus et C. Cornelius Cethegus...... gratiam quoque ingentem apud (senatores) pepererunt, quod ludis romanis, aedilibus curulibus imperarunt, ut loca senatoria secernerent a populo, nam antea in promiscuo spectabant[330].
«Il Becker[331], crede che Augusto abbia semplicemente separato senatori e cavalieri dalla plebe, senz’altra divisione fra le classi più nobili: a me sembra poter dedurre dal passo di Suetonio che i senatori fossero separati dai cavalieri, ed ai primi fosse attribuito (nel circo) il primus subselliorum ordo, che è quanto dire il posto d’onore. Ciò è confermato dal passo di Dione, relativo all’anno 5, τὰς ἱπποδρομίας χωρὶς μὲν οί βουλευταὶ, χωρὶς δὲ οί ἱππεις άπό τοῦ λοιποῦ πλήθους εἱδον, ὄ καὶ νῦν γίγνεται[332].
«Claudio fece qualche cosa di più: circo vero maximo.... propria senatoribus constituit loca, promiscue spedare solitis[333]. Il Becker interpreta questa notizia come una separazione dei senatori dai cavalieri. Si oppone a questa teoria il passo parallelo di Dione, dell’anno 41, così tradotto dallo Jordan[334], [77] antea in circo spectabant senatores, equites, plebes urbana, PRIVATIM SUO QUISQUE LOCO, nimirum ex quo tempore hic spectandi mos lege (roscia, giulia teatrale etc.) sanctus est: neque vero certa loca attributa erant, sed tum (a. 41) Claudius senatoribus eam quam nunc tenent sedem concessit. Questo racconto di Dione può interpretarsi in tre maniere:
1º che prima di Claudio, purchè senatori e cavalieri e plebe stessero vicendevolmente divisi, potevano occupare quel posto che loro talentava: e che Claudio abbia alle tre classi assegnato un posto fisso. Ciò non è ammissibile, perchè molto tempo prima di Claudio ai due ordini senatorio ed equestre, quel posto fisso era stato assegnato:
2º che le leggi anteriori a Claudio abbiano voluto soltanto separare la massa dei senatori e dei cavalieri della plebe, e che Claudio abbia suddiviso il gruppo dei senatori per cariche, vale a dire in consolari, pretori, edilici etc. Di una suddivisione generale per cariche e per dignità al tempo dell’impero si ha indizio nel passo di Erodiano, ove narra di un affronto fatto a Commodo nel teatro πληρωθέντος δὲ τοῦ θεάτρον μετὰ πάσης εὐκοσμιας, τῶν τέ ἐν ἀξιώσεσιν ἐν ἐξαιρέτοις ἐδραις καὶ ώς ἐκὰστοις διετέτακτο ἱδρυμένον etc.[335]. Della separazione dei consolari dal restante ceto, abbiamo due documenti: il primo nel passo di Arnobio sedent in spectaculis publicis..... senatus, CONSULATO FUNCTI PATRES etc.[336]: il secondo nel seguente brano di iscrizione scoperto negli scavi del 1874[337]:
3º che Claudio abbia assegnato a ciascun senatore e sua famiglia un posto determinato lungo tanti piedi nel tale o tal altro cuneo del «primus subselliorum ordo»; conciossiachè sappiamo da Suetonio che anche i posti senatorî eran divisi per cunei. Nel secondo giorno delle feste settimonziali, Domiziano omne genus rerum missilia sparsit, et quia pars maior inter popularia deciderat, quinquagenas tesseras in singulos cuneos equestris ac senatorii ordinis pronunciavit[338].
«Questo assegnamento di posti personali, il quale mi sembra confermato dal passo di Sparziano in Didio[339], occupatis, omnium subselliis populus geminavit convicia in Julianum, — non deve credersi una novità assoluta. Se ne hanno esempî anche ne’ tempi della repubblica (benchè come eccezione alla regola) tanto nel foro per le monomachie, quanto nel circo per le [78] ippodromie[340]: SELLAE. CVRVLIS. LOCVS. IPSI. POSTERISQUE. AD. MURCIAI. SPECTANDI. CAVSSA. DATVS. EST. Sedecim eodem tempore Aelii erant, quibus una domuncula erat...... inque maximo et Flaminio spectaculo locus: quae quidem loca ob virtutem publice donata possidebant. Assai importante, fra tutti, è il passo di Cicerone: senatui piacere Sergio Sulpicio statuam in rostris statui, circumque eam statuam locum ludis gladiatoribus liberos posterosque eius quoquoversus quinque pedes habere[341] equivalente a m. q. 2,187. Che nelle assegnazioni di posti personali si tenesse conto, in generale, perfino delle semiuncie e dei sicilici, lo sapevamo dagli atti arvalici dell’anno 80; che poi di tal rigorosa parsimonia si facesse uso anche verso chiarissimi personaggi di rango senatorio, è confermato dal seguente brano di Cicerone[342]: (Clodius) quaerit ex me, num consuessem siculis locum gladiatoribus dare? Negavi; at ego, inquit, NOVUS PATRONUS (?) instituam sed soror quae tantum habet consularis loci, unum mihi solum pedem dat.
«Come nel teatro i senatori ebbero il posto migliore nell’orchestra[343] nella quale sedeva anche l’imperatore[344], così nell’anfiteatro fu loro assegnato il podio[345] nel quale fu anco il palco del sovrano, protetto da gelosie[346].
«Dalle dotte disquisizioni dello Hübner[347], è provato quanto sia difficile ritrovare nel Colosseo il sito esatto nel quale sedevano senatori e cavalieri; quanto sia difficile riconoscere la forma e la disposizione del podio, e quanto sia oscura la stessa divisione in meniani.
«Ma che i senatori sedessero sul ripiano infimo che dominava immediatamente l’arena, privi di sedili marmorei, ma capace di due o tre file di seggiole, credo poterlo dimostrare così:
«I massi marmorei scorniciati sui quali è incisa la grande iscrizione di Placido Valentiniano, mentre servivano di coronamento al murello del podio, servivano pure di base e sostegno alla ringhiera forse di marmo, ma assai più probabilmente di bronzo, la quale formava parapetto. Infatti tutti quei massi scorniciati conservano la incassatura del parapetto a questo modo:
«Ora le più antiche e perfette iscrizioni recanti i nomi di due, di tre, di quattro clarissimi viri, sono incise precisamente su quella lista che corrisponde [79] al di fuori della ringhiera: la qual cosa dimostra che i chiarissimi personaggi sedevano precisamente su quei massi di marmo. Che poi questi stessero dove li ho collocati, cioè sul ciglio dell’infimo suggesto o podio, è dimostrato dalla regolarità somma con la quale sono caduti in fondo all’arena. I massi scoperti nel 1878 contenenti le prime parole dell’iscrizione di Valentiniano III, si seguivano con regolarità e senza gravi lacune nel testo. Ora ciò non potrebbe essere avvenuto se fossero precipitati dai baltei superiori. Del resto è cosa nota che i nove decimi dei marmi di ogni specie trovati nell’arena spettano al suggesto senatorio siccome quello che le stava più vicino».
2. Equites. «Dei cavalieri si può ripetere quello che si è detto dei senatori. Assisterono promiscuamente agli spettacoli, misti alla folla, prima dell’introduzione dei sedili: poi si saranno riuniti in gruppo tenendosi fra i senatori e la plebe: e col tempo avranno acquistato una specie di diritto e di privilegio a preceder questa in tutte le rappresentazioni circensi, teatrali, gladiatorie. Nell’anno 687/87 L. Roscio Otone, tribuno della plebe, confermò con la sua lex roscia theatralis gli antichi privilegi dell’ordine, aggiungendone forse dei nuovi e più speciali[348]. L. Otho, vir fortis, meus necessarius equestri ordini RESTITUIT non solum dignitatem sed etiam voluptatem. Itaque haec lex, quae ad ludos pertinet, est omnium gratissima, quod honestissimo ordini cum splendore fructus quoque iucunditatis est RESTITUTUS»[349]. Furono destinati ai cavalieri in theatro quatuordecim gradus proximi[350] e che facevan giro attorno l’orchestra dei senatori. Questa misura sollevò l’indignazione del popolo al punto, che Cicerone dovette far ricorso a tutto l’artificio della sua eloquenza per calmare gli spiriti esacerbati[351]: esacerbati non tanto dal mero fatto dei XIV ordines, quanto dal riconoscimento indiretto sì, ma solenne del ceto equestre (cioè del ceto capitalista) come seconda autorità politica dello stato[352]. Del resto queste lotte fra le varie classi dei cittadini pei posti negli spettacoli non erano cosa nuova. « Ἔμελλεν ὁ δὴμος θεάσθαι μονομάχους ἔν ἀγορᾷ καὶ τῶν ἀρχόντων οί πλεῖστοι θεωφητήρια κόκλῳ κατασκευάσαντες ἐζεμίσθουν. Ταῦτα ὁ Γάιος ἐκέλευεν αὺτοὺς καθαιρεῖν, ὅπος οῖ πένητες ἐκ τῶν τόπων ἑκείνων ἄμισθὶ θεάσασθαι δύνωνται»[353].
«Dalla legge roscia ebbero origine le frasi: sedere in quatuordecim ordinibus — in equite spectare — in equestribus, in pulvino equestri sedere, assai frequente presso gli scrittori[354]. Quum autem plerique equitum, attrito [80] bellis civilibus patrimonio spectare ludos E QUATUORDECIM non auderent, metu poenae theatralis: pronunciavit, non teneri ea, quibus ipsis parentibusve equester census unquam fuisset[355]. Non è questa la sola alterazione che le vicende dei tempi avevano recato alla regolare osservanza della legge roscia. Quum spectaculo ludorum gregarium militem, in quatuordecim ordinibus sedentem, excitari per apparitorem iussisset, rumore ab obrectatoribus dilato, quasi eundem mox discruciatum necasset, minimum abfuit quin periret concursu et indignatione turbae militaris[356]. Benchè Suetonio, nel notissimo paragrafo del c. 44, non faccia menzione di ordinamenti speciali riguardo al ceto equestre, non v’ha dubbio che Augusto si sia occupato anche di loro, come, del resto, dimostrano e il paragrafo poco anzi citato dal c. 40, ed i testi già recati a proposito dei senatori.
«Nerone adottò pei cavalieri, e soltanto nel circo, un’altra misura, la quale non è ben chiara. Ne parlano Tacito e Plinio. Il primo nel libro 15, capo 32 degli annali riferisce, che nell’anno 65 l’imperatore equitum romanorum locos sedilibus plebeis ANTEPOSUIT apud circum. Namque ad eam diem indiscreti inibant, quia lex Roscia nihil nisi de quatuordecim ordinibus sanxit. Il secondo poi aggiunge aver Nerone soppresso gli euripi che circondavano la lizza attribuendo ai cavalieri il maggiore spazio così guadagnato. (Caesar dictator) euripis harenam circumdedit, quos Nero princeps sustutit, equiti loca addens[357].
«Dal confronto di due testi sembra apparire che la legge roscia sia stata rispettata nel solo teatro: e che nel circo (dove i 14 ordini sarebbero stati esuberanti, eccessivi) i cavalieri avessero preso posto, non appresso ai subselli senatorî, ma forse nelle gradinate più alte, che erano veramente le migliori per godere tutto lo insieme delle cose, e più lontane da quei nembi di polvere dei quali parla Ovidio. Nerone li avrà fatti discendere nell’ordine più basso, e per non togliere troppo posto alla plebe, avrà spinto in fuori i posti dei senatori, nell’area già occupata dagli euripi, attribuendo ai cavalieri lo spazio lasciato libero dai senatori. Si veggano i dotti commenti dello Hübner[358] e dello Jordan[359]. Tito, ed il suo agente Manio Laberio Massimo, dividendo i sedili del Colosseo, attribuirono ai cavalieri gli ordini più bassi e più vicini ai senatorî, uniformandosi se non alla lettera, allo spirito almeno della legge roscia. Domiziano con editto promulgato forse quando ebbe recata a compimento la fabbrica dell’Anfiteatro licentiam theatralem promiscue spectandi IN EQUITE inhibuit. Marziale lo chiama: edictum quo subsellia certiora fiunt[360].
[81]
«Intorno ai posti dei cavalieri nel Colosseo, alle scamna equitum di Marziale (5, 41), abbiamo un documento contemporaneo alla sua prima dedicazione. È un gradino marmoreo lungo m. 1,17, alto m. 0,72, largo m. 0,40 sulla fronte del quale è scritto a lettere auree:
EQVITI (bus)
(C. I, L. VI, Pars. 4, 32098).
«Questi posti erano divisi per cunei, come risulta dalla testimonianza di Suetonio[361] già allegato di sopra. Uno dei cunei[362] era chiamato IVNIORVM[363]. Equester ordo cuneum Germanici appellavit, qui IUNIORUM dicebatur. — Questo passo dimostra che i cavalieri, senza avere forse posti personali, sedevano però distinti fra loro, per cariche e per dignità. Le divisioni, delle quali ho contezza, sono queste:
a) iuniores, forse quelli che attualmente prestavano servizio nelle turme equestri. Sedevano in un cuneo separato.
b) decoctores, cavalieri decaduti nel censo. Sedevano nei due ordini più alti e più lontani dall’orchestra e dall’arena.
c) coloro che, di origine libertina, avevano raggranellato il censo equestre. Sedevano c. s.[364].
d) i tribuni militari ed in genere gli ufficiali superiori delle milizie stanziate in Roma[365].
e) i decemviri litibus iudicandis[366].
f) Tribuni plebis. Forse a questa classe va riferita la glossa di Porfirio ad Horat. Epod. 4: ex quattuor (decim) autem ordinibus, quos lege Roscius Otho tr. pl. in theatro equestri ordini dedit, duo primi..... tribuniciis vacabant. Le si riferisce senza dubbio il passo di Dione 44,4 nel quale fra gli onori decretati in favore di Cesare nell’anno 710/44 si registra: καὶ καθὲζεσθαι ἑπὶ τοῦ ἀρχικοῦ δίφρου παντακῆ πλὴν ἐν ταῖς πανηγύρεσιν..... τότε γὰρ ἐπῒ τε τοῦ δημαρχικοῦ βάθρου καὶ μετὰ τῶν ἀεὶ δημαρχούντων Θεὰσθαι ἔλαβεν.
«A tutte queste classi di magistratus ordinis equestris allude Calpurnio nei ben noti versi della settima ecloga: Venimus ad sedes ubi pulla sordida veste, — Inter foemineas spectabat turba cathedras — Nam quocumque patent sub aperto libera coelo. Aut eques aut nivei loca densavere tribuni.
[82]
«I cavalieri, a differenza dei senatori, non graffiarono il nome nel proprio loco, nemmeno in tempi di decadenza assoluta, forse perchè non ebbero posti personali. Una sola leggenda conosco che possa applicarsi agli ordini dei cavalieri: ed è incisa in un gradino di marmo, spettante ad uno scalare, a lettere di forma esilarante. Dice:
AbinsteiF. A[367]
(C. I, L. VI, part. 4, n. 32098).
e lo attribuisco ai gradini equestri, perchè i senatori non sedettero mai nel marmo.
3. Sacerdotum omnium collegia. «Il testo principe intorno ai posti sacerdotali è il lamento di Arnobio 4, 35 p. 151 Hild. Sedent in spectaculis publicis sacerdotum omnium collegia:
a) pontifices maximi
b) et maximi curiones
c) sedent quindecim viri laureati.
d) et Diales cum apicibus flamines.
e) sedent interpretes augures divinae mentis et voluntatis.
f) nec non et castae virgines perpetui nutrices et conservatrices ignis.
«È chiaro che Arnobio non parla rigorosamente, e che è d’uopo tener conto la sua enfasi rettorica. Nondimeno tengo per certo che, nel periodo di Augusto a Claudio, questi sacerdoti abbiano indistintamente seduto in senatu e che, dopo Claudio, abbiano ciascuno avuto la propria sede distinta e determinata di tanti piedi nel tale o tal altro cuneo, dell’ordine cui appartenevano. È certo parimenti che Arnobio non mentova tutti i collegi sacerdotali che avevano diritto a sedere sul podio. Abbiamo memoria e documenti per ciò che spetta a) agli arvali, b) alle vestali, c) al flamine diale, d) ai sacerdoti augustali, e, particolarmente ai soldati fluviali.
a) Fratelli Arvali[368].
b) Vergini vestali[369].
c) Flamine diale. «Di costui fanno parola Arnobio, nel passo soprariferito, e, indirettamente, Suetonio[370] narrando aver l’imperatore presieduto al certamen quinquennale assidentibus Diale sacerdote — cet.».
[83]
d) Sacerdoti Augustali. Dei posti riservati agli augustali fa menzione Tacito[371] narrando del senatus consulto per le onoranze funebri a Germanico: honores decreti....... ut sedes curules sacerdotum augustalium locis, superque eas querceae coronae statuerentur. E nel senatus consulto per le onoranze a Druso si ripete:[372]
VTIQUE. OMNIBVS theATRIS sellae curules habentes drusi
CAESARIS NOMINA Inscripta locis augustalium ponerentur.
«Del collegio dei sodali fluviali, abbiamo indirettamente notizia da Suetonio[373].
«Paeanisti (?) — Ai LOCA del collegio dei peanisti[374] si è voluto riferire[375] questo brano d’iscrizione trovata circa dieci anni or sono[376] nel cimitero di s. Agnese, sulla via Nomentana:
«Ed infatti quella cifra dei quattro piedi e la menzione dei cunei fenestrarum non disconverrebbero ad un rescritto di concessioni di posti dell’anfiteatro. Ma prescindendo dalla difficoltà di spiegare come i peanisti abbiano potuto extruere cosa alcuna nell’anfiteatro, il confronto del libello greco con il rescritto di Severo, benchè ambedue mutili, mi induce a credere trattarsi piuttosto di qualche contravvenzione alle leggi promulgate da Severo e Caracalla circa gli edificî e le insulae della città[377] — per es. la sporgenza abusiva di un meniano in area pubblica: — contravvenzione per la quale sarà stata richiesta e concessa la condonazione.
[84]
4. Legati-Hospites. «La maggior parte delle memorie lasciate dagli scrittori sui posti propri degli ambasciatori e rappresentanti diplomatici si riferisce al teatro. Romae legatos liberarum sociarumque gentium vetuit in orchestra considere, quum quosdam etiam libertini generis mitti deprehendisset[378].
«A questa legge si fecero eccezioni continue. Claudio permise ai legati dei Parti, degli Armeni e dei Germani di sedere in senatu cioè nell’orchestra[379]. Sotto Nerone avvenne qualche cosa di simile, se pure Tacito non confonda i suoi due ambasciatori frisî Verrito e Malorige con gli ambasciatori germani di Suetonio[380]: Traiano τοὺς πρεσβευτὰς τοὺς παρὰ τῶν βασιλέων ἀφικρομένους ἐν τῷ βουλευτικῷ θεάσασθαι ἐποίει[381].
«Anche nei giuochi gladiatorî ebbero ab antico sede onorevolissima. Agli ambasciatori marsigliesi, venuti in Roma dopo l’incendio gallico locus spectaculorum in senatu datus (est)[382]. Finalmente sappiamo l’istesso essere avvenuto nel circo quodam autem muneris die Parthorum obsides, tunc primum missos, per arenam mediam ad spectaculum induxit, superque se subsellio secundo collocavit[383]. A questa classe di persone riferisco due epigrafi dei sedili del Colosseo. La prima, appartenente al primo secolo, dice:
hos]PITIB[us
(C. I, L. VI, parte 4, 32098 (e))
«La seconda è ripetuta su due gradini, grezzi nella superficie, con lettere dei tempi Severiani:
l GADITANORVM
m GADITANorum
(C. I, L. ib.).
«Ambedue questi sedili sono degni di osservazione, perchè conservano la famosa linea di divisione. Nel primo è segnata 4 centimetri all’infuori, cioè a sinistra, della lettera G: nel secondo 2 centimetri all’infuori della stessa lettera.
5. Pretextati. «Il senatus consulto augusteo rilegò i pretestati in un cuneo del teatro: praetextatis cuneum suum assignavit. Chi sa che non sia [85] questo il cuneus iuniorum del quale abbiamo parlato di sopra. Di questo gruppo è rimasto documento epigrafico nel Colosseo. Sulla fronte di un sedile è scritto con lettere della buona epoca[384]:
ETEXT
VIIIS
(C. I, L. VI, p. 4, 32098 c).
6. Paedagogi. «Questi due marmi, prosegue il ch.o Lanciani, confermano egregiamente la sentenza, aver Tito o Domiziano seguito alla lettera i regolamenti augustei nella divisione dei posti anfiteatrali.
paedagogis p VERO um
(C. I. L, part. 4, 32098, d).
7. Apparitores magistratuum publicorum populi romani. «Dalla narrazione di Tacito[385] riferibile all’anno 819/66 — liberto et accusatori (Publii Galli eq. r.) locus in theatro inter viatores tribunicios datur — con molta probabilità si può argomentare che gli apparitores dei diversi magistrati, cioè gli scribae, lictores, viatores, praecones, secondo le loro rispettive decurie avessero posti fissi nel teatro[386].
8. Popularia (loca). «La plebe fu divisa per tribù e per istato civile. Della divisione per tribù negli spettacoli si hanno memorie fino dagli antichissimi tempi di Roma. Essa fu fomentata dall’abuso dell’ambitus tribuarius e degli spectacula tributim data per parte di chi cercava, acquistare sul pubblico influenza all’approssimarsi delle elezioni: in circo totas tabernas tribulium causa comparare. Si consultino Cicerone, Vatin. 15, 37; Mur. 34, 72; Orelli, Ind. leg. p. 286; hanc autem (plebem) tributim divisa loca occupasse tempore Ciceronis et Dionysii, ipsorum verba sat certo testantur: ad Severi usque tempora, an idem mos manserit, incertum est[387]. Io credo che il costume fosse serbato anche nei tempi imperiali: in primo luogo perchè non v’era ragione di rinunciare ad una misura così semplice e così opportuna a disciplinare quelle folle tremende: in secondo luogo, perchè, della continuazione del costume, mi sembra trovare documento nella basis magna marmorea litteris magnis scoperta sulla fine del quattrocento in angulo circi maximi [86] versus templum Herculis victoris in foro Boario et Tiberim dedicata a Traiano, nell’anno 103, dalle
TRIBVS . XXXV
QVOD . LIBERALITATE
OPTIMI . PRINCIPIS
COMMODA . EARVM . ETIAM
LOCORUM . ADIECTIONE
AMPLIATA . SINT
(C. I. L. VI, 955).
«Si sa in qual modo avvenisse cotesta locorum adiectio dal c. 5 del panegirico di Plinio. Poco prima dell’anno 100 Traiano fece demolire la tribuna imperiale, cedendone l’area al popolo. Quest’area era capace di cinquemila posti, dal che risulta che il cubiculum principis era vasto due volte più dei nostri teatri della Scala, di S. Carlo, ecc. La plebe di ciascuna tribù fu suddivisa per istato civile; i coniugati da una banda, le donne (e forse i celibi) dall’altra.
a) Maritis a plebe proprios ordines assignavit[388], la quale misura sembra allo Hübner essere conseguenza delle leggi iulia de adulteriis dell’anno 757/4, e papia poppea dell’anno 762/9 e degli editti contro il celibato, emessi dopo la vittoria di Azio[389]. Ho già notato che cotesta separazione degli ammogliati dagli scapoli, ebbe vigore soltanto inter popularia non mai per gli ordini senatori ed equestri. Gli ammogliati delle trentacinque tribù sedettero fra l’ultima fila dei cavalieri ed il maenianum summum in ligneis, ubi pulla sordida veste — inter foemineas sedebat turba cathedras.
b) «Anticamente le donne sole non erano escluse dal consorzio comune: antiquitus solebant mulieres cum viris omnibus interesse spectaculis indifferenter come dice lo scoliaste di Giovenale[390]. Il costume durava al tempo di Silla[391], di Cicerone[392] e di Ovidio[393], benchè da alcune frasi del poeta possa dedursi che le donne scompagnate occupavano già per abitudine il portico in cima ai sedili: Sic ego marmorei respexi summa theatri. — Eligis e multis unde dolere velis[394]. Augusto rese obbligatorio e legittimo il loro isolamento: [87] Foeminis ne gladiatores quidem, quos promiscue spectari solemne olim erat, nisi ex superiore loco spectare concessit..... Athletarum vero spectaculo; prosegue Suetonio: muliebre sexus omne adeo summovit, ut pontificalibus ludis pugilum par postulatum distulerit in sequentis diei matutinum tempus, edixeritque — mulieres ante horam quintam venire in theatrum non placere.
«L’usanza di Roma divenne generale, almeno nelle regioni italiche: e gli altissimi sedili dei teatri furono chiamati muliebri. Cf. l’iscrizione di Terni ap. Orelli 3279: OPVS . THEATRI . PERFECT . IN . MVLIEBRIB . AERAMENTIS . ADORNAVER.
c) «Dai citati versi di Calpurnio, sulla sordida turba pulla veste, arguisco che anche gli scapoli debbono essere stati rilegati lassù; e mi sembra che a questa speciale classe accennino gli scrittori, usando la voce pullati. Stazio, silv. 1, 6, 43, parlando delle largizioni di Domiziano, conferma indirettamente questa triplice divisione: una vescitur omnis ordo mensa: parvi, femina, plebes, eques, senatus.
9. Militari. «È ragionevole il credere che i gregarî dei corpi di milizia stanziati in Roma, i pretoriani, gli urbani, i peregrini, i vigili, i misenati, i ravennati, ecc. avessero posto fisso nell’anfiteatro, come lo avevano senza dubbio negli altri luoghi di spettacolo. Cf. il militem secrevit a populo del regolamento di Augusto. I corporis custodes, gli equites singulares avranno forse avuto una distinzione speciale.
«Le epigrafi dei sedili fin qui citate sono quelle che possono con probabilità o con certezza attribuirsi ad un dato ordine o gruppo di spettatori, ma non sono tutte». Fin qui l’illustre Lanciani.
Le sigle ed i numeri, d’epoca buona, che si leggono sulla fronte di altri gradini marmorei, li riporteremo nell’Appendice II.
***
Il Curiosum urbis ci assicura che nell’Anfiteatro Flavio v’erano 87,000 posti, loca: Regio III. Isis et Serapis. Continet Monetam, Amphitheatrum qui continet loca LXXXVII. — Questo stesso leggesi nel De Regionibus, il quale in altro non differisce dal Curiosum se non in questo: che nel primo il numero dei posti vien indicato in cifre, mentre nel secondo s’indica in lettere. Regio III. Isis et Serapis. Cont. Monetam. Anphit..... qui capit octoginta septem millia. — Pomponio Leto nel suo Vittore ritiene la stessa cifra. Fra gli scrittori moderni poi ve n’è chi diminuisce d’assai la capacità dell’Anfiteatro.
[88]
Fra questi noto Leon Home, il quale nel suo Lexique de Topographie Romaine[395] scrive: «L’ensemble de la cavea qui pouvait contener de 50,000 a 55,000 personnes. Le chiffre des Regionales — 87,000 — est évidemment très exagéré». L’Huelsen, prendendo occasione dalla scoperta del Vaglieri, (la quale consiste in aver questi riconosciuto che in alcuni luoghi, ove le tavole degli Arvali sono intiere ed hanno il margine antico, il testo finora creduto intiero non lo è, perchè la scrittura fu continuata sul margine di un’altra tavola attigua), conchiude che il Colosseo non poteva contenere più di quaranta o quarantacinque mila spettatori seduti; e dice che, calcolando che gli spettatori pullati[396] fossero altri cinque mila, non si oltrepasserebbe in nessun modo il numero di 50,000 persone. Però osserva che, almeno nell’epoca buona, non fu assegnato nell’Anfiteatro un posto ad hominem, ma che si assegnò alle corporazioni, ai sodalizi, ai collegi sacerdotali, un certo numero di piedi di spazio rispettivamente, lasciandosi ai singoli membri dei collegi stessi il diritto di accordarsi fra loro sulla distribuzione di detto spazio. Sicchè se su piedi 5 5⁄16, che erano degli Arvali[397], si fossero voluti adagiare due soli sacerdoti, oppure starvi tre alla stretta, ciò non riguardava affatto l’officiale incaricato della distribuzione dei posti[398].
Ammessa l’opinione del ch.º Huelsen apparisce chiaro che se (specialmente in caso di spettacoli straordinarî) la curiosità avesse fatto occupare disagiatamente a due persone il posto designato per una, si sarebbe raddoppiato il numero degli spettatori; ossia l’Anfiteatro sarebbe stato materialmente capace di circa 100,000 persone. La cifra pertanto indicata dai Regionarî non è assolutamente esagerata, molto più se si rifletta che il Codice Vaticano n. 3227 del Curiosum, invece di loca LXXXVII ha: capet loca LXXVII.
Dai portici del piano terreno dell’Anfiteatro si accedeva ai varî ordini di gradi per passaggi e scale diverse[399]. In ogni quadrante dell’ovale dal secondo giro (2) del portico esterno tre passaggi (3) immettevano nell’ambulacro (6) sottoposto all’iter della praecinctio della gradinata dei cavalieri: da quest’ambulacro, per quattro scale (8), si saliva alla gradinata del podio, e per mezzo di dodici passaggi si giungeva all’ambulacro (9), dal quale si ascendeva al ripiano dei subsellia.
Inoltre dallo stesso secondo giro (2) del portico esterno, quattro scale (5) ad una branca conducevano all’ambulacro, nel quale s’aprivano i vomitorî della [89] gradinata dei cavalieri; ed altre cinque scale (4) a due branche menavano ai piani superiori, vale a dire alla media cavea, alla summa ed al portico. Con tal sistema l’immensa folla degli spettatori era ripartita in modo, che questa poteva discendere ed uscire dall’Anfiteatro senza confusione e disordine.
Ora, a compire la descrizione dell’interno dell’Anfiteatro Flavio, mi resta a parlare del velario.
Lo scopo del velario già l’enunciammo[400]: esso serviva a riparare gli spettatori dagli ardenti raggi solari. Plinio[401], dopo aver narrato delle vele di vario colore adoperate nelle flotte di Alessandro Magno, e di quelle purpuree che avea la nave con cui M. Antonio andò ad Azio con Cleopatra, dice: «Postea in theatris tantum umbram facere»; le quali parole c’insegnano che, abbandonato nelle navi l’uso di vele colorate, passarono queste a far ombra ai teatri. Anche Lucrezio fa menzione di siffatto lusso nei velarî:
«Et vulgo faciunt id lutea intenta theatris
Per malos vulgata trabesque trementia flutant»[402].
Il primo che introdusse la tela da navi colorata nei teatri fu, per testimonianza di Plinio[403], Q. Catulo, allorquando dedicò il Campidoglio. Questa tela parve troppo rozza a Lentulo Spinter, e nei giuochi apollinari, come scrive il citato autore, usò per primo nel teatro vele di finissimo lino: «Carbasina deinde vela primus in theatro duxisse traditur Lentulus Spinter apollinaribus ludis»[404]. Ed infine lo stesso Plinio ci attesta che Nerone adornò le vele con ricami d’oro: Vela nuper colore caeli stellata per rudentes, terra etiam in amphitheatris principis Neronis rubente»[405].
Sembra che i velarî ordinariamente s’incominciassero a stendere in primavera. L’apprendiamo da due AVVISI, scoperti in Pompei, scritti in caratteri rossi, nel primo dei quali Numerio Popidio Rufo notificava al pubblico che egli il 29 d’Ottobre avrebbe dato in quella città una caccia, e che il 29 di Aprile l’anfiteatro sarebbe stato coperto con velario. L’altro avviso fu scoperto sulla Via degli Augustali[406].
Relativamente alla struttura del velario, non s’ha a credere che questa sia una cosa tanto facile ad immaginarsi come comunemente si ritiene. Fino [90] a pensare che vi dovè essere un’armatura, probabilmente di corde, costituita da duecento quaranta raggi, che partendo dalle travi verticali andassero a rannodarsi ad un ovale centrale più o meno ampio, non vi si trova difficoltà. Ma se si rifletta che il peso dei canapi, delle carrucole, delle tende e delle corde che servivano per tirarle, avrebbe fatto necessariamente calare, e non poco, l’ovale centrale, e fatto rimanere il velario pendente in basso, producendo un pessimo effetto ed una disgustosa soffocazione negli spettatori del portico; siamo costretti a ricercar il modo con cui avranno gli antichi cercato di evitare quello sconcio.
Per ottenere lo scopo, si dovea far sì che l’ovale, e quindi i raggi fossero, per quanto era fisicamente possibile, orizzontalmente tesi: in questo caso le tende, attaccate per un capo all’ovale e fissato per l’altro al disopra dell’attico del porticato, avrebbero formato un dolce padiglione dall’alto in basso, producendo un gradevole effetto.
Questa tensione (che dovea essere fortissima, a cagione del non intercedere tra il piano delle testate delle travi e quello dell’attico del colonnato spazio maggiore di tre metri) non si sarebbe potuta ottenere che per mezzo di verricelli, i quali agissero su ciascuno dei duecento quaranta raggi.
Il Canina saggiamente opinò che alle travi esterne ne corrispondessero altre all’interno dell’edificio, onde ottenere maggiore resistenza. Erano esse necessariamente collegate insieme per mezzo di traverse, formando tutto un sistema. Ce l’assicura Calpurnio: «Vidimus in coelum trabibus spectacula TEXTIS»:
«Coronato di travi in un conteste
Vidi il superbo Anfiteatro al cielo
Surgere. . . . . . . . . . . »
traduce il Biondi.
Alle testate delle travi interne erano fissate robuste carrucole, a fin di mandare verticalmente le funi ad arrotolarsi ai verricelli orizzontali, i sostegni dei quali poggiavano sul pavimento del portico, ed erano assicurati con arpioni alla parete di perimetro dell’Anfiteatro.
È bene qui notare che le testate delle travi che sostenevano il soffitto del portico e il soprapposto pavimento, oltre ad essere incassate nella cortina del muro di perimetro, poggiavano sopra solidi mensoloni; e questo dimostra che quelle testate dovevano sopportare un peso maggiore di quello d’un soffitto e di un pavimento.
Sorge una difficoltà, ed è che qualora si volesse supporre l’ovale centrale non di altra materia che di canapo, sarebbe stata cosa ben difficile fargli prendere e mantenere la sua forma regolare.
[91]
A rimediare a quest’inconveniente, si potrebbe immaginare l’ovale centrale formato di una zona orizzontale di piastra metallica, di una sufficiente consistenza e del minor peso possibile; immaginandone inoltre la periferia esterna non maggiore di quanto era necessario per attaccarvi le duecento quaranta funi, e (perchè la sua massa fosse relativamente minima) composta di due fasce riunite a traliccio. A questa zona metallica si sarebbero fissati duecento quaranta anelli, onde attaccarvi gli uncini legati ai capi dei canapi. Agli anelli avrebbero fatto capo altre duecento quaranta corde che, discendendo in dolce curva fin sopra l’attico del portico, avrebbero servito di guida al distendimento e raccoglimento delle vele.
Una corona di metallo dorato, dalla quale scendessero vele cerulee ornate di auree stelle; padiglione degno dell’imponente cavea ove tutto era splendore: «sic undique fulgor percussit»[407], sarebbe, non v’ha dubbio, una brillante idea! Ma si sarebbe potuta attuare?... La risposta la dovrebbe dare il calcolo, al quale nè io ho tempo di consacrare, nè, credo, varrebbe la pena di consacrarvelo, restando la cosa in ogni modo nel campo delle ipotesi.
L’operazione di tendere il velario si eseguiva sul terrazzo soprapposto al portico, ed era affidata a’ soldati di marina.
Lampridio[408] scrive: «Sane quum illi saepe pugnanti, ut deo, populus favisset, irrisum se credens, populum romanum a militibus classariis qui vela ducebant in amphitheatro interimi praeceperat»; e questi marinai furono certamente i Misenati, perchè essi avevano il loro quartiere nella stessa regione dell’Anfiteatro. Nel Curiosum e nel De Regionibus leggiamo: III Regio.... Castra Misenatium. Preziosa indicazione topografica, la quale, mentre ci rende certi della vicinanza del quartiere dei Misenati all’Anfiteatro, dà pur anche valore alla scoperta di un frammento d’iscrizione, in cui si fa menzione dei Castra Misenatium, rinvenuto dall’Henzen tra le schede del Fea, nelle quali si attesta che il frammento fu scoperto fuori della parte semicircolare delle terme di Tito[409], ossia poco lungi dal nostro Anfiteatro.
La situazione del quartiere dei marinai della flotta di Ravenna (in Trastevere, presso la naumachia di Augusto, al servizio della quale erano destinati quei militi) rafforza l’argomento desunto dalla vicinanza del quartiere dei Misenati all’Anfiteatro Flavio, e prova che essi appunto erano i classarii destinati a tendere il velario.
Nel 1776, alle radici dell’Esquilino verso il Colosseo, si rinvenne un raro anemoscopio di marmo, il quale fu trasportato al Museo Vaticano, e tuttora si [92] ammira sulla Loggia del Belvedere. Esso consiste in un prisma dodecagonale, largo (da faccia a faccia) m. 0,555, e alto m. 0,30: gli spigoli, formati dalle facce laterali, sono adorni di un risalto cilindrico di m. 0,03 di diametro; e sulla faccia superiore (orizzontale), ai quattro punti cardinali, sono incisi in bella paleografia le seguenti parole:
MERIDIES — SEPTENTRIO — ORIENS — OCCIDENS. (V. Fig. 3ª).
Nel centro v’è un foro circolare del diametro di m. 0,045: in esso fu introdotta l’asta della banderuola, e tuttora si vede l’impiombatura che la fissava. Dal residuo dell’asta che rimane incassato nel foro, sappiamo che la grossezza di detta asta era di m. 0,025. (V. Fig. 4ª).
Sulle facce laterali vi sono incisi in caratteri molto spontanei, ed anche belli, i nomi dei venti (in greco ed in latino) in questo modo:
ΖΕΦΙ
ΡΟΣ
FAVO
NIVS
(V. Fig. 5ª)
Questo raro istrumento trovato presso il Colosseo, appartenne alla Mole dei Flavî?
[93]
Non sarebbe certo irragionevole opinare, che, sull’alto dell’Anfiteatro, vi fosse stato un indice esatto dei venti per norma del comandante dei Misenati; affinchè questi, conosciuta con certezza la direzione del vento, potesse (qualora impetuoso) dar ordine o di tendere le vele soltanto da quella parte in cui rimanevano a riparo, ovvero, se già distese, ordinare di ritirare quelle che si trovavano nella direzione del vento. La forma del velario richiedeva senza dubbio una sorveglianza diligente: poichè la grande apertura centrale lasciava libero adito ai venti; e questi, se si fossero introdotti sotto il velario ed avessero invaso la parte che trovavasi di fronte, avrebbero fatto sollevare violentemente le vele, le quali, agitandosi soverchiamente, avrebbero recato non poca molestia agli spettatori e causato gravi danni. Che il vento potesse danneggiare gli edificî destinati ai pubblici spettacoli, si può ragionevolmente argomentare dalla stessa loro struttura a cielo aperto: e che talora il vento l’abbia realmente danneggiati, lo possiamo dedurre da Plauto, il quale nella sua commedia «Curcullio»[410], fa narrare alla giovane Planesium, ciò che a questa accadde allorquando, ancor fanciulletta, assistè agli spettacoli dionisiaci, ove aveala condotta Archestrata sua nutrice. Non appena questa avea [94] adagiato la fanciulletta nel teatro, levossi un VENTO tanto TURBINOSO, che pose a soqquadro l’intiero edificio[411].
La forma dell’anemoscopio rinvenuto presso il Colosseo è adattissima per ottenere il fine sopra indicato. Occorreva infatti che il comandante avesse sott’occhio e quasi direi, stando a tavolino, la Rosa dei venti, e vedesse la direzione dei medesimi. Pertanto sarebbe stato necessario che il prisma dodecagonale marmoreo stasse sul terrazzo dell’Anfiteatro, nel senso del meridiano astronomico locale, e sopra un piedistallo alto 90 centimetri circa: vale a dire, collocato in modo, che, una persona in piedi, volendo, avesse potuto vedere comodamente il piano superiore dell’istrumento e leggere agevolmente i nomi dei venti incisi sulle facce laterali[412]. E perchè, guardando la faccia superiore [95] dell’istrumento, si potesse vedere la precisa direzione del vento, io congetturo che la banderuola fosse fissata ad un cannello metallico lungo quanto l’asta; che il cannello fosse appoggiato liberamente sulla punta dell’asta, ed in basso munito di un indice orizzontale, il quale, secondando il movimento della banderuola, avrebbe mostrato sul piano, la direzione del vento. La banderuola poi, avrebbe dovuto superare l’altezza dell’attico dell’Anfiteatro, affinchè potesse esser mossa liberamente da ogni vento; e la grossezza dell’asta è tale, da potersi innalzare con ogni solidità fin oltre a due metri; altezza che, aggiunta a quella del piedestallo e del prisma soprappostogli, avrebbe permesso alla banderuola di superare l’attico di un metro e mezzo almeno.
La cura di evitare la violenza molesta del vento e i danni dei quali spesso è causa, non è cosa nuova presso gli antichi. Vitruvio prescrive che nell’edificazione di una nuova città, s’abbia riguardo alla direzione dei venti; e vuole, che, costruita la cinta, nel centro dell’area da questa racchiusa, si descriva, sopra un levigato piano di marmo (da lui chiamato «marmoreum amussium»), orizzontalmente disposto (ovvero sul suolo stesso spianato a perfezione e livellato), la Rosa dei venti; e ciò, a fin di stabilire la direzione delle vie e delle piazze tra l’una e l’altra regione degli otto venti principali; e per liberare da molestia i cittadini e da malanni la loro salute[413].
In conclusione: se in tutti gli antichi teatri ed anfiteatri era cosa prudente prevenire i pericolosi effetti del vento, nell’Anfiteatro Flavio era di necessità assoluta. Se quell’immenso velario, a tant’altezza, si fosse lasciato senza sorveglianza e a discrezione dei venti, si sarebbe facilmente potuto ivi verificare il fatto immaginato da Plauto: «Exoritur ventus: turbo: spectacula ibi ruunt». Questa necessità evidente, e la prudenza degli antichi, specialmente nelle cose pubbliche, mi hanno indotto a congetturare che quell’anemoscopio rinvenuto in prossimità del Colosseo, sia appartenuto alla Mole Vespasianea per la sorveglianza del velario. E la mia congettura trova appoggio nella bella paleografia delle quattro parole incise sulla faccia superiore dell’anemoscopio; paleografia che, per la forma e regolarità delle lettere, può convenire benissimo all’età dei Flavî. Anche le lettere dei nomi dei venti, si potrebbero forse riportare a quei tempi; perchè, quantunque siano state eseguite con minor cura e con una paleografia che tende al corsivo, pur nondimeno [96] sono di buona forma. Chè se taluno volesse ritenere quei caratteri per un’opera posteriore all’età dei Flavî, non credo che potrebbe farli discendere più giù degli inizi del secolo terzo; ed in questo caso si dovrebbe conchiudere, che i nomi dei venti furono incisi ai tempi dei grandi restauri fatti da Eliogabalo e Severo Alessandro nel nostro Anfiteatro.
***
Dopo d’aver contemplato così minutamente questa stupenda mole, sorge spontaneo il desiderio di sapere chi ne fosse l’architetto. Vana speranza: il nome di questo grande giace sepolto in un oblio inesplicabile. Il silenzio dei classici e degli antichi scrittori reca veramente maraviglia! Lo stesso Marziale, che tanti epigrammi dedicò al Flavio Anfiteatro, non ne fa parola.
Chi mai fu quell’ingegno sublime che diresse questa grandiosa e sontuosa opera? È questa la domanda che in tutti i tempi, e sempre indarno, si è fatta costantemente dai dotti; questo l’oggetto perenne di congetture, questioni e dispute infruttuose. Non possediamo documento certo; e finchè questo non apparisca, l’architetto del Colosseo ci sarà sempre ignoto. Nondimeno, per ragione di storia, riporteremo qui le differenti opinioni, lasciando a ciascheduno la piena libertà di accettare quella che crederà più verisimile.
Giuseppe Antonio Guattani[414] scrive: «Gli intendenti non lasciano di censurare le parti di quest’edificio (del Colosseo), trovandovi profili inesatti, modinature cangianti di altezza, di misure e distanze non corrispondenti. Al Serlio piacquero sì poco tutte le cornici, che le chiamò tedesche(!), deducendone che l’ARCHITETTO fu sicuramente un tedesco». In nota poi aggiunge: «Marziale, ne fa autore un certo Rabirio, architetto della casa di Domiziano, perchè di tutta la fabbrica vorrebbe darne l’onore a quell’Augusto, il di cui pane mangiava. Ma è a tutti noto il dolce stomachevole di quel suo epigramma. Se ne fa generalmente autore un certo Gaudenzio cristiano, in vigore di una iscrizione (che trovasi) nel sotterraneo di S. Martina; oscura per altro, e che poco persuade».
Dalle parole del Guattani rileviamo chiaramente che il preteso architetto dell’Anfiteatro o fu un tedesco, o fu Rabirio, o, finalmente, un cristiano di nome Gaudenzio.
La prima opinione è del Serlio. Che Vespasiano si fosse servito di un tedesco, non sarebbe cosa da recar maraviglia. Le province Germaniche erano già soggette all’Impero, ed uno schiavo di quelle regioni, reso libero, potè benissimo [97] servire l’Imperatore in qualità di architetto. L’opera di artisti liberti prestata ai reggitori dell’Impero non è una novità per gli archeologi. Ma dedurre assolutamente la nazionalità dell’architetto dalle modinature è un po’ troppo! Molto più che la fretta con cui furono eseguiti i lavori dell’Anfiteatro, tradì il pensiero dell’architetto. Forse un anacronismo trasse il Serlio a quella conclusione, credendo di vedervi rispecchiate le goffe cornici gotiche degli edifici settentrionali dell’epoca, come si suol dire, antico-moderna.
La seconda opinione ne fa architetto Rabirio. I sostenitori di questa s’appoggiano al LV epigramma del lib. VII di Marziale, il quale dice:
«Astra polumque tua cepisti mente, Rabiri,
Parrhasiam mira qui struis ante domum;
Phidiaco si digna Jovi dare templa parabit
Has petat a nostro Pisa Tonante manus».
Ma chi non vede che qui Marziale non parla dell’Anfiteatro, bensì della costruzione di una domum diretta da Rabirio, il quale era architetto non di Vespasiano ma di Domiziano? E chi ignora che quando «nell’anno 80 fu solennemente dedicato (l’Anfiteatro) esso era stato recato a compimento, salvo forse nei particolari dell’ornamentazione, i quali saranno stati perfezionati dal Domiziano»?[415].
La terza opinione, finalmente, sostenuta dal Marangoni e da altri scrittori, attribuisce la direzione del nostro augusto monumento ad un cristiano di nome Gaudenzio.
Il Nibby[416] dice che ai suoi tempi «i più s’inclinavano ad accettare quest’opinione». I moderni però la rigettano unanimemente.
Ciò che fece credere al Marangoni e a tutti i seguaci di quest’opinione che fosse Gaudenzio l’architetto dell’Anfiteatro Flavio, fu una lapide con iscrizione cristiana rinvenuta nel cimitero di S. Agnese[417]. Riporto qui le parole del Bellori contemporaneo della scoperta: «Non pigeat hic inscriptionem veterem advertere quae Amphitheatri Flavii architecto adscribitur, elapsis annis reperta erutaque in coemeterio divae Agnetis via Nomentana.... neque spuria reque recens, sed orthographia et caractheres longe sequiorem Vespasiano Augusto aetatem indicant»[418].
La paleografia di questa lapide, la quale, come dice il Muratori, già esisteva presso Pietro da Cortona e schedis Ptolomaeis, ci riporterebbe (secondo [98] il Nibby)[419] al secolo V dell’êra volgare; ed il Nibby stesso aggiunge che l’iscrizione non dichiara che Gaudenzio fosse l’architetto, ma che solo si può dedurre aver Gaudenzio lavorato in quest’Anfiteatro. Detta epigrafe non è stata mai pubblicata conforme all’originale. Il Marangoni, il Visconti, il Marucchi, ecc., ce la presentano in caratteri comuni di stampa; e benchè l’abbiano riprodotta esattamente riguardo alla disposizione delle parole, sono stati inesatti riguardo ai segni, i quali dal Marangoni e dal Marucchi furono espressi tondi, e dal Visconti in forma di lunghi apici. L’Aringhi, il Venuti, il Nibby, il P. Scaglia ed i recenti Bollandisti la riproducono altri in caratteri comuni di stampa (come il Nibby, il Venuti ed i Bollandisti), altri in un fac-simile arbitrario (come l’Aringhi ed il P. Scaglia); ma tutti inesattamente in quanto alla disposizione delle parole. Solo l’Aringhi ed il P. Scaglia esprimono con più verità degli altri la forma degli apici.
Ora avendo io fortunatamente saputo essersene testè fatto un calco dal Sig. Attilio Menazzi (una copia del quale si conserva nell’Accademia di S. Luca) ed avendone potuto avere una fotografia, posso presentare l’iscrizione nella sua reale genuinità. (Vedi Fig. 6ª).
Nel Gori[420] leggo: «Una lapide marmorea, rinvenuta nelle catacombe di S. Agnese lungo la via Nomentana, parlando in nome di un Gaudenzio costruttore di un teatro del crudele Vespasiano, e che in luogo di essere premiato dalla città da lui nobilitata col detto monumento, fu condannato a morte pella sua religione cristiana, indusse nel Marangoni l’opinione che fosse costui l’architetto del Colosseo. Ma in primo luogo la paleografia irregolare [99] e scorretta di quest’iscrizione che ho nuovamente copiata nel sotterraneo di S. Martina, indica chiaramente che non è dell’epoca di Vespasiano o de’ suoi figli, ma sibbene del V secolo riproduzione forse di qualche leggenda popolare contraria alla verità storica (sic); giacchè Vespasiano punì i giudei per la loro ribellione, non perseguitò mai i cristiani, nemici naturali degli ebrei. In secondo luogo in detta iscrizione si parla non dell’Anfiteatro Flavio, ma di un teatro costrutto da Vespasiano (?) non si sa in quale città».
Il Marangoni[421], dal canto suo, ragiona così: «Ella è cosa di riflessione, come, essendo l’opera di questo Anfiteatro così eccellente per l’architettura, e di ammirabil lavoro, e giudicata da Marziale molto più pregevole di tutte le più celebrate maraviglie del mondo, nè egli nè altri scrittori di quel secolo e de’ susseguenti abbiano fatta memoria del suo ingegnosissimo architetto. Marziale stesso, che visse nei tempi di Vespasiano, di Tito e di Domiziano, celebra con elogio ben singolare quella di Rabirio, architetto di Domiziano, per la fabbrica di un palagio sul Palatino, dicendo che avendola eretta emulatrice del cielo conveniva dirsi che la di lui mente avesse penetrato il cielo e compresa la nobiltà e bellezza degli astri, avendo fabbricata una casa ad essi somigliantissima[422]. Or quanto più degnamente, e con tutta giustizia, avrebbe dovuto immortalare il nome e la memoria dell’architetto di questa grande ed ammirabile opera dell’Anfiteatro, uomo senza dubbio a quei giorni celebratissimo, ed anche da sè conosciuto. Siami pertanto lecito di attribuire questo silenzio all’odio di questo ed altri scrittori Gentili di que’ secoli, che alla cristiana religione portavano, invidiando sì bella gloria al grande architetto dell’Anfiteatro, per essere egli Cristiano, e per tal cagione ancora martire di Gesù Cristo.
La congettura (prosegue) sembrami non mal fondata sopra un’antica iscrizione in marmo, della lunghezza di sette palmi e poco più di uno largo, che serbasi nella Confessione della chiesa di santa Martina alle radici del Campidoglio....
Le lettere di questa lapide non sono di eccellente scultura, benchè fatte in tempo di Vespasiano, in cui fiorivano in Roma le buone arti; e molte parole di essa non sono staccate: ma ciò non dee recar maraviglia, posciachè non poterono i fedeli, fra le loro angustie, fare scolpire questa iscrizione da qualche eccellente maestro gentile; e perciò anche quasi tutti i monumenti cimiteriali sono per lo più di cattivi o non ben formati caratteri, quantunque siano de’ tempi migliori. Di questa iscrizione non fece memoria Marsilio Onorato, ecc....».
[100]
Il tenore dell’epigrafe già noi l’abbiamo veduto. Qui basterà riportarne la traduzione, che lo stesso Marangoni[423] fa nella nostra italiana favella:
«Così dunque tu premî, o Vespasiano crudele?
Premiato sei colla morte, o Gaudenzio.
Gioisci, Roma, ove all’autore di tua gloria
Promise quegli, ma ogni premio ti dà Cristo
Che altro teatro ti preparò nel cielo».
«Quivi (continua lo stesso Marangoni)[424], si pone la parola theatrum per contrapposto all’Anfiteatro, poichè ne’ teatri si rappresentavano cose gioconde e dilettevoli, e negli Anfiteatri spettacoli funesti e sanguinosi. Quindi è che questo Gaudenzio potrebbe dirsi che, essendo cristiano, fosse in premio di aver eretta questa gran fabbrica, con tanta gloria di Roma, da Vespasiano stesso fatto morire. Potrebbesi però opporre che Vespasiano non incrudeli contro i Cristiani; ma a ciò può rispondersi che anche sotto di lui non mancarono martiri; poichè, sebbene non rinnovò editti contro di essi, nulladimeno continuava la persecuzione di Nerone: imperciocchè, per testimonianza del Martirologio Romano, si ha di S. Apollinare vescovo di Ravenna: 22 Julii. «Qui sub Vespasiano Caesare gloriosum martyrium consumavit». Inoltre è certo ch’ei fece ricercare ed uccidere tutti quelli ch’erano della stirpe di David[425], e che si eccitò una grande strage e persecuzione contro gli Ebrei[426]; e non v’ha dubbio che a quei tempi sotto il nome di Ebrei compresi erano anche i Cristiani di Roma, come si ha dagli stessi scrittori Gentili; e specialmente Domiziano, figliuolo di Vespasiano medesimo, fece morire diversi, qui in mores Judeorum transierant[427], cioè che abbracciata aveano la cristiana fede: quindi è che, stante l’addotta iscrizione, potrebbe argomentarsi che Gaudenzio, perfetto cristiano, fosse stato l’eccellente architetto dell’Anfiteatro Flavio....».
Questa opinione del Marangoni piacque al Marini, e la disse elegans[428]. Ma i moderni, ripeto, la rigettano unanimemente; ritengono la lapide per falsa, e molti attribuiscono la falsificazione a Pirro Ligorio. A dire il vero, quando comparve la lapide, Pirro Ligorio era già morto da più di un mezzo secolo: sarebbe stato meglio l’avessero questi attribuita ad un redivivo Ligorio, come si espresse il De Rossi a riguardo delle poche lapidi cristiane falsificate.
«Nunquam in Christianis epitaphiis acclamatio ad imperatorem apparet» scrive il P. Sisto O. C. R.[429], nelle sue Notiones Archaeologiae Christianae. [101] La forma delle lettere, aggiunge il Mantechi, i segni d’interpunzione, l’intiero testo, rivelano la falsità dell’iscrizione (di Gaudenzio)»[430].
È certo che la paleografia di quest’epigrafe, come pure la sua dicitura, non è affatto ordinaria; e nessuno potrà senza dubitarne asserire, come fece il Marangoni, che quella lapide sia dei tempi dei Flavî. Ma chi ne sarà stato l’autore? A quale scopo questa falsificazione? Non forse per speculazione, come fanno gli odierni spacciatori di antichità? Ovvero per ingannare i posteri?... Nell’uno e nell’altro caso dobbiam dire che il falsificatore non si sarebbe manifestato molto atto ed esperto nel suo vile officio. Difatti, o che la lapide sia stata falsificata a scopo di lucro, o a fine d’ingannare; in ambedue i casi il falsificatore avrebbe dovuto imitare un po’ meglio la paleografia e lo stile dell’epoca. Oltre a questo perchè nasconderla e sotterrarla nel cimitero di S. Agnese?
A suo luogo[431] esamineremo particolareggiatamente tutte e singole le opinioni, e vedremo il loro valore. Fin d’ora però dobbiamo dichiarare arbitraria l’osservazione del Gori[432]; giacchè la lapide «Sic premia servas» non può essere «una riproduzione di qualche leggenda popolare contraria alla verità storica»; e non può essere per la semplicissima ragione che la verità storica circa l’architetto del Colosseo è finora ignota a tutti.
[103]
Nel capo primo già descrivemmo le sontuosissime feste celebrate in Roma, in occasione dell’inaugurazione dell’Anfiteatro fatta da Tito nell’anno 80 dell’êra nostra. Ora passiamo a ricordare gli spettacoli che vi diedero i suoi successori, fino al secolo VI.
Domiziano (81-96), figlio di Vespasiano e fratello di Tito, fece celebrare durante il suo impero, sontuosi spettacoli in quell’Anfiteatro, che egli avea portato a perfetto compimento. Di questi giuochi ce ne parla Suetonio[433]; e fra i varî spettacoli vi fu pur data una pugna navale. Ma avvedutosi Domiziano che l’Anfiteatro non si prestava ai grandi combattimenti navali, fè costruire presso il Tevere una naumachia, il cui materiale fu poscia impiegato da Traiano al risarcimento dei due fianchi del Circo Massimo, che s’erano incendiati[434]. In questa naumachia si potevano azzuffare delle vere flotte[435]; ma tali giuochi non son da confondersi con la pugna navale che Domiziano diè nell’Anfiteatro Flavio.
Domiziano amò assai le venationes e gli spettacoli gladiatorî; e talvolta, perfin di notte, alla luce delle faci, assisteva ai certami esibiti non solo dagli uomini ma pur dalle donne; e per tutto il tempo degli spettacoli intrattenevasi, talor seriamente, con un fanciullo, puerulus, che gli stava ai piedi vestito di scarlatto, coccinatus, e che era una maraviglia per la sua portentosa sebben piccola testa[436].
[104]
Io penso che questo fanciullo portentoso parvoque capite, prediletto da Domiziano e col quale fabulabatur nonnumquam serio, possa essere l’undicenne Q. Sulpicio Massimo coronato dallo stesso Domiziano in Campidoglio, per avere, nel concorso poetico indetto nel terzo lustro o certame dell’agone capitolino, riportato l’onore del primato sopra cinquantadue competitori, grecamente poetando: il cui sepolcro venne in luce nel 1871 nel demolire la torre destra della Porta Salaria[437].
Un dì, seduto sulle gradinate dell’Anfiteatro, trovavasi un padre di famiglia, il quale, parlando, asserì che «un Trece o Mirmillone, non poteva paragonarsi a quel gladiatore che allora dava uno spettacolo al popolo». Risaputolo Domiziano ordinò che dai gradus quegli passasse tosto nell’arena, e divenisse preda dei cani. Dietro le spalle gli mise la scritta: «Empiamente ha parlato questo parmulario», ossia fautore dei Traci, i quali, come si disse nell’introduzione, erano armati di parma[438].
Marziale[439] scrisse l’ultimo epigramma dopo la morte di Domiziano; poichè dice di lui che più giovevole cosa sarebbe stata alla gente Flavia il non avere avuto i due degnissimi Imperatori Vespasiano e Tito, che l’aver sortito questo terzo Cesare, malvagio e scelleratissimo.
Domiziano fu uno dei più bravi arcieri[440]; talvolta prendeva di mira la palma destra di un fanciullo, che, in lontananza, teneva stesa, e vi dirigeva le frecce con tant’arte da farle passare innocue fra gli intervalli delle dita[441].
[105]
Nell’anfiteatro della sua villa Albana fe’ combattere cogli strali, da vicino e senza armatura, contro gli orsi della Numidia, Acilio Glabrione, il quale fu console nell’anno 91 dell’êra volgare:
Profuit ergo nihil misero quod cominus ursos
Figebat numidas albana nudus arena[442].
Lo stesso Imperatore uccideva a centinaia le belve di vario genere, e tra queste uccise un enorme leone africano[443].
Se giuochi tanto magnifici faceva celebrare in Albano, quanto più sontuosi non li avrà dati nell’Anfiteatro Flavio? Marziale, che fu il descrittore ufficiale degli spettacoli celebrati sotto i Flavî nel nostro Anfiteatro, ci dà una chiara idea della singolarità e magnificenza dei suddetti spettacoli esibiti al popolo. «Una donna, dice il poeta, vinse ed uccise un leone. Uno dei più grandi facinorosi venne affisso ad una croce, ed esposto non ad un falso orso, come nella commedia di Nevio il mimo ed attore Laureolo, sibbene ad un vero orso della Caledonia, che lo sbranò[444]. Un condannato, che, come Dedalo, dovea volare per isfuggire agli artigli di un orso, cadde a terra, e fu lacerato dalla belva[445]. Un rinoceronte col corno palleggiò un toro[446]. Un leone, che avea ferito il suo maestro o mansuetario mentre lo percuoteva, fu per ordine dell’Imperatore, ucciso colle frecce[447]. Un orso, che, per difendere la testa dai colpi del bestiario, se la copriva colle zampe anteriori, e, facendo la ruota, fuggiva per la sanguinosa arena; fu costretto a fermarsi, rimasto preso al vischio come un uccello[448]. Il bestiario Carpoforo meritò di essere anteposto a Meleagro e ad Ercole, perchè, nello stesso giorno e nello stesso spettacolo, uccise venti fiere: tra le quali due giovenche, un bufalo, un bisonte, un orso ed un leone di gran mole, insieme ad un velocissimo pardo[449]. Una macchina elevò in alto nel mezzo dell’arena un toro, sul cui dorso era stata imposta l’effigie di Domiziano camuffato da Ercole[450]. Simili macchine si lavoravano, come abbiam detto, nell’officina summum choragium; ed erano composte con tanta maestria, che da sè medesime si elevavano, mandando in alto i varî piani in esse occultamente contenuti; variavano inoltre di forma, [106] o svolgendosi le parti che erano unite, o riunendosi per sè stesse le dispiegate, od abbassandosi lentamente le elevate; e su di esse apparivano talvolta i gladiatori, fuochi dilettevoli ed altre sorprese di questo genere. Un elefante, dopo aver ucciso un toro, s’inginocchiò innanzi a Domiziano[451]; una tigre riuscì a lacerare un leone (cosa nuova e non mai prima avvenuta) e un toro, che, stimolato colle fiamme per tutta l’arena, aveva colle corna alzato in aria molti fantocci, pilae, e che rimase in ultimo ucciso da un elefante, il quale lo palleggiò alla sua volta colla proboscide[452]».
Sotto lo stesso Domiziano venne accomodata l’arena del nostro Anfiteatro in modo da rappresentare Rodope, nella cui sottoposta pianura, come in un teatro, Orfeo cantava, e intorno a lui ballavano scogli e selve con ogni genere di uccelli e di animali mansueti e feroci. Orfeo era rappresentato da un reo, il quale rimase lacerato da un ingrato orso[453]. I fanciulli si aggrappavano alle corna dei tori; o, correndo essi sulle groppe dei medesimi, agitavano tela, venabuli ed aste, senza ricevere nocumento di sorta[454].
Altri spettacoli somiglianti ci ricorda lo stesso Marziale: spettacoli magnifici e straordinarî, che noi, per brevità, tralasciamo di riferire.
Traiano amò moltissimo gli spettacoli venatorî e gladiatorî[455] e ne fece dare in gran copia e di magnifici. L’Henzen[456] scrisse: Ipse vero Traianus, ut vir bellicosus ac fortis, valde iis laetatus est, triumphos suos venationibus ac gladiatorum muneribus magnificentissimis ornavit. Pel suo trionfo Dacico (a. 108) fece combattere nell’Anfiteatro 11,000 belve feroci e 10,000 gladiatori[457]. «Questi spettacoli, dice il Gori[458], ebbero luogo non solo nell’Anfiteatro Flavio, ma anche in quello edificato da Traiano. Pausania infatti scrive, che questo Imperatore costrusse un gran teatro rotondo[459], ossia un anfiteatro,(?) posto, secondo Sparziano, nel Campo Marzio e distrutto in seguito da Adriano contro il voto di tutti[460], non già perchè Adriano fosse nemico degli spettacoli anfiteatrali, ma perchè si era dichiarato rivale di Apollodoro, celebre architetto di cui servivasi Traiano».
[107]
Qual fosse le scopo prefissosi dal Gori, nel creare nuovi anfiteatri, lo vedremo nella IV parte (quest. terza) di questo lavoro. Ora mi limito a dire che Sparziano non usa la voce amphitheatrum, ma theatrum: se uno scrittore greco usasse la parola θέατρον per denotare un anfiteatro, non recherebbe maraviglia, giacchè sappiamo che ai Greci poco piacque usare la voce anfiteatro; ma che uno scrittore romano chiamasse teatro un anfiteatro, è incredibile. Il Lanciani[461] dice: «Pausania registra fra le grandi opere di Traiano in Roma..... theatrum magnum undequaque rotundum, cioè l’Anfiteatro Flavio. È una inesatta asserzione del geografo....». Il teatro perciò fatto edificare da Traiano nel Campo Marzio non possiamo dirlo anfiteatro; e se quest’Imperatore avesse dato, come vuole il Gori, spettacoli nel suo teatro, questi al più sarebbero stati i gladiatorî; non mai le venationes, le quali erano, direi impossibili in edificî di tal natura, e che, come già si disse, dopo l’invenzione degli anfiteatri si celebrarono constantemente in questi e si bandirono financo dai circhi[462].
Anche Adriano si dilettò di dar giuochi nel nostro Anfiteatro. Alle volte egli stesso scendeva sull’arena; e una volta riuscì ad uccidere di propria mano un leone. Durante gli spettacoli, imitando Tito nei 100 giorni della dedicazione dell’Anfiteatro, gettava (separatamente agli uomini e alle donne) globoli o palle con entro diversi donativi. In Atene esibì nello stadio la caccia di 1000 fiere; in Roma fè uccidere molte fiere, 100 leoni ed altrettante leonesse; e nell’anniversario del suo natale, per 6 giorni continui, diè lo spettacolo di ludi gladiatorî e la caccia di 1000 fiere[463].
Adriano ordinò: Decoctores bonorum suorum, si suae auctoritatis essent, catomidiari in amphitheatro, et dimitti iussit[464]; questo castigo fu ben descritto da Prudenzio[465].
Solenni spettacoli fè celebrare Antonino Pio nell’Anfiteatro Flavio. Mostrò tigri, elefanti, crocute[466], strepsiceroti[467], coccodrilli, ippopotami ed altri animali, ricercati in ogni parte del mondo: in una sola giornata mostrò cento leoni: Edita munera in quibus elephantos et crocutas et strepsicerotas et crocodilos [108] etiam hippopotamos, et omnia ex toto orbe terrarum cum tigridibus exhibuit. Centum etiam leones una missione edidit[468].
Nella guerra contro i Marcomanni[469] Marc’Aurelio arruolò moltissimi gladiatori; e gli spettacoli che fe’ dare nell’Anfiteatro furono tanto splendidi che in una sola missione presentò insieme e fece uccidere cogli strali 100 leoni[470].
Ma i ludi più superbi e più magnifici ebbero ivi luogo imperando Commodo.
Più crudele di Domiziano e più impuro di Nerone, provava egli particolar diletto negli spettacoli sanguinarî. Se tal feroce inclinazione fosse in lui perchè nato di adulterio commesso da Faustina sua madre con un gladiatore, secondo alcuni; o perchè concepito, come altri vogliono, dopo che Faustina si era lavata col sangue di un gladiatore svenato, del quale s’era invaghita[471], lo ignoriamo: certo, il fatto ci mostra che Commodo si manifestò piuttosto quale figlio di un gladiatore, che principe generato dal filosofo M. Aurelio.
Frequentò la schola dei gladiatori, e sovente al par degli altri, nudo o velate le spalle con un semplice panno purpureo, entrava all’arena, brandiva il ferro, e comandava che i gladiatori pugnassero con lui. Questi alla più leggiera ferita si dichiaravano vinti; e, prostrati ai suoi piedi, qual trionfante lo veneravano. In tal guisa vinse mille gladiatori; e per celebrare la sua valentia fece troncare la testa al colosso del Sole, del quale a suo luogo parleremo, e in luogo di quella ne fè porre un’altra che presentava le sue sembianze; poi nella base della statua appose la scritta:
MILLE GLADIATORVM VICTOR
(Lampridio)
Ordinò che si registrassero i nomi di tutti i gladiatori da lui vinti; si celebrassero i suoi trionfi nelle pubbliche memorie, e s’aggiungesse che pugnò 635 volte. Nel nostro Anfiteatro uccise di propria mano, con saette, molte fiere; scoccava l’arco con somma destrezza, e sempre colpiva. Fè fabbricare una macchina, che si disse περιδρομος, intorno alla quale egli girava per non essere offeso dalle bestie: e fu così che potè uccidere una quantità di cervi, daini, tori, leoni, pantere, ecc., senza essere obbligato a replicare il colpo. Una volta una pantera si scagliò contro di un uomo. Commodo tende il suo arco, e le assesta una frecciata sì opportuna, che la fiera cade ai piedi del malcapitato. Lampridio racconta anche che una volta Commodo apparve nell’Anfiteatro Flavio vestito in modo strano. Ecco come: egli amava una sua [109] donna, ed aveva il suo ritratto ov’era dipinta in forma di Amazzone. Un bel giorno dunque si veste anche egli da amazzone, si porta all’Anfiteatro e si fa acclamare col titolo di Amazzonio.
Spesso assisteva agli spettacoli anfiteatrali vestito da donna: durante i quali, e contro le leggi, beveva; ed una volta, credendosi schernito dagli spettatori, i quali invece l’acclamavano qual dio, ordinò ai soldati della marina, destinati a tendere il velario, che uccidessero tutti gli accorsi all’Anfiteatro. Dicevasi Ercole, e diè ordine d’incendiare Roma, come colonia sua; ma ciò non avvenne perchè fu dissuaso da Leto, prefetto del Pretorio. Fra i nomi assunti da Commodo vi fu quello di Capo dei secutori[472]: capo, cioè, di quei gladiatori i quali, come vedemmo nell’introduzione, inseguivano i reziarî, Palus primus Secutorum per la secentesima volta.
Dal palazzo, o casa Commodiana Palatina, si trasferì alla casa Vectiliana sul Celio, adducendo a pretesto che in quello gli spettri turbavano i suoi sonni. Contro ogni consuetudine, ordinò che gli spettatori assistessero agli spettacoli non togati, ma vestiti del gabbano (paenula) come nei funerali; ed egli stesso talvolta presiedeva ai giuochi in veste di color bruno. Per due volte gli cadde l’elmo alla porta Libitinensis, che era quella porta per la quale negli anfiteatri si estraevano fuori dell’arena i cadaveri dei gladiatori[473].
Poco prima che Commodo morisse, già da sè stesso erasi procacciati auguri funesti. Erodiano narra che Lucilla, sorella di Commodo, tramò la famosa congiura contro la vita del fratello. Quinziano faceva parte di questa congiura: apparteneva all’ordine senatorio, ed era di animo pronto ed audace. Un giorno questi si nascose in quell’oscuro andito che noi già descrivemmo nel cap. terzo; e, veduto comparire l’Imperatore, snudò improvvisamente il pugnale, e ad alta voce esclamò: «il Senato ti manda questo!» Ma mentre così parlava e stoltamente ostentava il nudo pugnale, venne arrestato dalle guardie, e condannato a morte insieme cogli altri congiurati[474].
[110]
Mai s’era visto nè udito, dice lo stesso storico, che un Imperatore sfidasse i più rinomati gladiatori, ed uccidesse di propria mano tante fiere. Sicchè da ogni angolo d’Italia e dalle regioni finitime accorrevano le genti in Roma, per assistere a quegli straordinarî spettacoli.
Nel giorno stabilito, il nostro Anfiteatro rigurgitava di gente. Commodo scendeva sull’arena, e in destrezza superava i più eccellenti tiratori di arco (i Parti) ed i più bravi lanciatori di giavelotti (i Numidi). Dione, anch’esso ascritto all’ordine senatorio, racconta le prodezze ed i combattimenti di Commodo[475]. Alle sue Storie Romane rimettiamo coloro che bramassero averne una contezza particolareggiata. Noi, per non essere troppo prolissi, ci limitiamo a ricordare sommariamente che Commodo, prima di portarsi all’Anfiteatro, soleva indossare una tunica serica con maniche, bianca e trinata di oro. Dione e tutti i senatori lo salutavano ornato di quell’abito. Lungo la via che conduceva all’Anfiteatro, si portava innanzi ad esso la pelle di un leone e la clava. «Nel primo giorno (dice Dione) ei solo, Commodo, uccise cento leoni, girando intorno alla banchina posta sotto il podio. Tutto l’Anfiteatro era stato diviso da diametri connessi, con tetto e peridromo[476], i quali tagliavano l’Anfiteatro in doppia direzione[477] per potere con dardi più facilmente trafiggere le belve».
Racconta lo stesso storico che Commodo scese dal luogo più elevato al piano dell’Anfiteatro; e qualunque bestia da macello che a lui s’avvicinava, tosto l’uccideva; e che inoltre fece cadere una tigre, un ippopotamo ed un elefante. Dopo il pranzo entrava nella pugna gladiatoria....... Con esso pugnavano i maestri dei giuochi, ed anche altri gladiatori.... dai quali in altro non differiva che in questo: essi discendevano nell’arena per poche monete, mentre Commodo si contentava ogni giorno di venticinque miriadi![478] Simili spettacoli durarono quattordici giorni; e mentre Commodo combatteva, noi Senatori (prosegue Dione) ci raccoglievamo colà coi cavalieri..... Prorompevamo con altissime grida, nelle solite acclamazioni; e talvolta esclamavamo: «Signore sei tu, primo, felicissimo; vinci, a memoria di uomini, Amazonio!»
Molti del popolo neppure entravano nell’Anfiteatro: alcuni poi si dipartivano dopo essersi arrestati un momento a guardare: chi indotto dalla vergogna delle cose che ivi si facevano, e chi per timore. Erasi infatti sparsa [111] la voce che l’Imperatore avea stabilito di trafiggere con saette gli spettatori: di fare, cioè, ciò che fece Ercole cogli Stinfalidi. Il popolo, d’altra parte, avea ben donde di ritenere per vera quella voce che circolava; giacchè non ignorava che quel mostro una volta riunì in un luogo tutti gli storpi, gli zoppi, ecc.; ed avendo loro circondato le ginocchia con figure di serpenti, e date ad essi delle spugne perchè le lanciassero, quasi fossero pietre, e considerandoli quali giganti, li percosse e li uccise.
«Questo timore[479], era a tutti comune, nè più agli altri che a noi stessi appartenenti; perciocchè anche a noi senatori tal giuoco fece che per quella cagione certissimo eccidio avessimo ad aspettarci. Conciossiachè ucciso avendo egli uno struzzo (Στρουδός), e tagliato ad esso il capo, si accostò al luogo ove sedevamo; e quel capo stendendo a noi colla sinistra, colla destra la spada sanguinosa, nulla disse in vero; il capo suo soltanto crollò, sogghignando colla bocca, a fine di mostrare che la stessa cosa avrebbe a noi fatta. Per la qual cosa movendosi molti al riso, perchè quell’atto invece di timore il riso aveva in noi eccitato, sarebbero stati essi con quella spada medesima trucidati, se io masticate non avessi le foglie del lauro che nella corona aveva; e persuaso non avessi agli altri tutti di fare lo stesso; affinchè con un movimento continuato della bocca, celare potessimo gli indizi del riso........ Nell’ultimo giorno de’ giuochi il di lui elmo fu altrove recato per la porta per la quale sogliono fare uscire i defunti. E da queste cose nacque in tutti l’opinione che la di lui morte fosse assolutamente vicina».
Sotto l’impero di Commodo, la professione di gladiatore, che prima era infame per legge, addivenne tanto nobile, che si formò il collegio Silvano Aureliano, il quale era composto di quattro decurie, ed aveva a sua disposizione un tempio dedicato a Silvano[480]. Alla stessa epoca probabilmente rimonta pur anche il collegio degli Arenarî o Bestiarî, del quale fa menzione una lapide modenese[481].
Settimio Severo, per celebrare il proprio ritorno, il decennio del suo impero e le vittorie da lui riportate, diè nell’Anfiteatro Flavio varî spettacoli. Dione[482] ce li descrive così: In quell’occasione «sessanta cignali Plauziani[483], per disposizione fatta, tra di essi pugnarono, ed uccise furono molte altre bestie, e principalmente un elefante ed un corocota[484]. Questo è un animale indiano; [112] e allora per la prima volta che io sappia, fu portato in Roma. Il suo colore è quello della lionessa, mescolato con quello della tigre; la sua figura partecipa degli animali medesimi, ed anche di quella del cane e della volpe per singolare radunamento. E formato essendo il ricettacolo delle fiere nell’Anfiteatro a foggia di una nave, così che 400 fiere racchiuder potesse[485] e mandare fuori in una volta; sciolta essendosi quella nave all’improvviso, ne scapparono fuori orsi, lionesse, pantere, lioni, struzzi, asini selvatici, bisonti, i quali sono una specie di buoi barbara per natura ed all’aspetto. Adunque 700 fiere in tutto e bestie da macello furono vedute scorrere, a vicenda; e quindi rimanere uccise. Imperciocchè secondo il numero dei giorni delle feste, che sette furono, sette centinaia di bestie furono ammazzate».
Caracalla si dilettò grandemente dei giuochi gladiatorî e delle venationes[486]. Parecchi spettacoli fe’ celebrare nel nostro Anfiteatro: colle proprie mani uccise un elefante, una tigre ed un ippotigre[487]. Costrinse il famoso gladiatore Batone, da tutti stimato invincibile, a battersi nello stesso giorno, ed uno dopo l’altro, con altri tre gladiatori: Batone, già sfinito, rimase vittima del terzo.
Antonino Caracalla onorò il cadavere di Batone con pompose e magnifiche esequie[488]; e, per compensare in qualche maniera quel suo atto crudele, gli fece edificare un magnifico sepolcro. Il Fabbretti[489], presso la Via Aurelia, nella villa Doria-Pamphili, ritrasse il disegno del cippo, alto piedi 6, once 6, dedicato a questo famoso gladiatore:
BA . TO . NI .
Sotto il nome così punteggiato, si scorge una figura scolpita, barbata, rappresentante Batone con fasce legate intorno al petto, avente sui lombi una larga cintura, ed al collo una doppia catena, o collana, adornata con due pallottole rotonde (torques). Colla destra stringe un coltello; la sinistra è difesa dallo scudo, ed egli ha la testa nuda. Il Winckelmann[490] pubblicò di nuovo questo bassorilievo, e su di esso fece le seguenti osservazioni: «Egli non ha [113] che un gambale alla gamba sinistra, formato da una lastra, e legatovi dietro con delle fasce...... Questa gamba, che mirasi così armata nelle figure di Castore e Polluce, tanto rinomati pei giuochi ginnici, dipinte in un vaso di terra cotta....; sì in due gladiatori impressi in una lucerna anch’essa di terra cotta[491], fanno vedere quest’uso essere stato proprio di coloro che combattevano nei giuochi pubblici. L’andar poi eglino così armati ne fa supporre che i gladiatori, mettessero avanti il piede sinistro, e ritirassero il destro; sebbene la destra gamba di Batone non rimane senza difesa; vedendovisi legato sotto il ginocchio un riparo per li colpi, che l’avversario avesse cercato di dargli in quella parte».
Regnando Macrino, un fulmine, come vedremo, appiccò il fuoco all’Anfiteatro, che rimase perciò mutilo per qualche tempo; ed i giuochi gladiatorî si diedero nello Stadio[492].
Eliogabalo ne intraprese il restauro, e Severo Alessandro lo portò a perfezione. Una medaglia di quest’imperatore (dell’a. 223) rappresenta il combattimento di un uomo con una belva[493] nell’arena dell’Anfiteatro Flavio. Fuori di questo si scorge, su di un piedistallo, un frammento di colonna, e l’imperatore in atto di entrare nell’Anfiteatro, seguito da una guardia: dall’altra parte apparisce una specie di portichetto con frontone[494]. La medaglia ha questa scritta:
IMP . CAES . M . AVR . SEV . ALEXANDER AVG .
e, nel rovescio:
PONTIF . MAX . TR . P . II . COS . P . P . S . C .[495].
Solennissimi furono gli spettacoli che si celebrarono nell’Anfiteatro Flavio sotto l’impero di Gordiano III[496].
Il Lanciani[497] dice: «È notissima la passione della famiglia di Gordiano Giuniore e di lui stesso per le venationes, e la loro munificenza nel celebrarle». [114] Gordiano III, per festeggiare il suo trionfo Persico[498], avea preparati in Roma 1000 paia di gladiatori fiscali o di proprietà governativa; 22 elefanti, 10 alci, 10 tigri, 60 leoni mansuefatti, 10 belbi ossia iene, un ippopotamo, un rinoceronte, 10 arcoleonti o leoni di prim’ordine, 10 camelo-pardali, 20 onagri, 40 cavalli indomiti ed altre innumerevoli belve feroci. Ma queste bestie furono esposte dal suo successore ed assassino, Filippo, nei ludi secolari, quando, cioè, nel consolato suo e di suo figlio, celebrò l’anno millesimo della fondazione di Roma[499]. Pomponio Leto è di parere che questi ludi siano stati fatti nel Circo Massimo e nel teatro di Pompeo. Il Muratori[500] dimostra che si diedero nell’Anfiteatro. Nondimeno, come giustamente osserva il Salmasio, essendo probabile che la distribuzione dei donativi, solita a farsi dagli Imperatori al popolo, avesse luogo nell’Anfiteatro Flavio; ed è da credersi che, oltre ai ludi celebrati nel Circo Massimo, se ne celebrassero anche altri nell’Anfiteatro: molto più che Giulio Capitolino pare che distingua i giuochi fatti nel Circo dai doni che si distribuirono nell’Anfiteatro: et muneribus atque circensibus.
Anche Probo diede nell’Anfiteatro sontuose cacce nell’anno 281, in cui celebrò il suo trionfo. Vopisco[501] riferisce che in questa circostanza Probo fece uscire dagli ipogei del nostro Anfiteatro 100 leoni di prim’ordine, iubati, colle loro giubbe sciolte, i quali coi loro ruggiti facevano rimbombare la cavea a guisa di tuoni; e furono tutti uccisi dai cacciatori. Si diè poscia la venatio di 100 leopardi africani e di 100 siriaci; di 100 leonesse, e 300 orsi insieme; il quale spettacolo, dice il biografo, riuscì più grandioso che gradito: Magnum magis constat spectaculum fuisse quam gratum.
Alla venatio fe’ seguito un ludo gladiatorio, nel quale lottarono i prigionieri condotti in Roma pel trionfo: questi erano quasi tutti africani, della tribù dei Blemî; e ad essi furono aggiunti alcuni Germani, Sarmati e ladroni Isauri. In tutto, paia 300.
Quando, nel 274, Aureliano condusse sul Campidoglio, dietro al suo carro ed avvinta con catene d’oro, la superba regina dei Palmireni, Zenobia, e i due Tetrici; l’immensa processione fu preceduta da 20 elefanti, 200 belve ammansite, della Libia e Palestina, da diversi camelo-pardali, da alci, e da altre simili bestie forastiere[502]. Succedevano a queste 800 paia di gladiatori e i prigionieri [115] delle varie barbare nazioni soggiogate, cioè: gli Alani, gli Arabi, gli Assomiti, i Battriani, i Blemmî, i Persiani, i Goti, i Sarmati, i Franchi, gli Svevi, i Germani, i Vandali, gl’Iberi, gli Eudemoni, i Palmireni e gli Egiziani. I seguenti giorni furono impiegati in combattimenti gladiatorî, in cacce di fiere ed in naumachie[503]: segno evidente che in quei pubblici sollazzi si fecero massacrare i 1600 gladiatori ed i prigionieri.
Imponentissimi spettacoli ebbero luogo nell’Anfiteatro Flavio ai tempi di Caro, Carino e Numeriano (283). Calpurnio ce li descrive particolareggiatamente; e la sua Ecloga è tanto più interessante, in quanto che fu egli teste oculare di ciò che narra. Calpurnio[504] induce il pastore Coridone a descrivere [116] ad un altro pastore, Licota, gli spettacoli dati nel nostro Anfiteatro ai suoi giorni; ed in pari tempo descrive l’anfiteatrale edificio. Noi riportiamo in nota il testo, dando qui relegante traduzione del march. Luigi Biondi pubblicata in Roma nel 1841.
«Coronato di travi in un conteste
Vidi il superbo Anfiteatro al cielo
Surgere, quasi del Tarpeio colle
Sovrastando alla vetta; e vidi immenso
Ordin di gradi dolcemente acclivi.
Pervenni là dove la sozza plebe
In abbrunati vesti, avea suo loco
Infra le logge ove sedean le donne;
Perchè lo spazio, che non chiuso giace
Sotto l’aperto ciel, riempivan densi
I cavalieri e i candidi tribuni.
Appunto come questa valle in giro
Spazïoso dilatasi, ed i suoi
Fianchi inarcando, concava si curva
Per entro una catena di montagne
Incoronate di pendenti selve;
Così pur ivi flessuoso cerchio
Cinge lo spazio della curva arena:
E due gran moli torte in egual arco
Forman conesse insieme egual figura.
Come ridir potrò le cose tutte,
Se tutte contemplarle a parte a parte
Io medesimo non valsi? fulgor tanto
D’ogn’intorno la vista mi percosse!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Coverto d’auro il portico, di gemme
Ricoverta del portico la fascia,
Splendevano a vicenda: e colà dove
Ha termine l’arena, e il vasto circo
Chiudesi di marmorea muraglia,
Eran d’avorio levigate ruote,
Il cui volubil perno delle fere,
Col volger pronto, l’adugnar fu vano,
[117]
E si avventan, le rovescia a terra.
Splendevan anco di fin auro attorte
Le reti che sporgeano inver l’arena
Per più denti disposti a ugual distanza:
Ed era (s’io pur merto fede alcuna,
La mi porgi, o Licota) era ogni dente
Assai più lungo d’un de’ nostri aratri.
Che mai per ordin potrei dirti? Io vidi
Ogni sorta di belve: i bianchi lepri;
I cinghiali col corno; e la manticora;
E persin l’alce trasportata insieme
Cogli alberi del bosco ov’ella nacque.
Vidi pur tauri moltiformi: alcuni
Squassan le giubbe per lo collo, e ad altri
Aspra la barba giù dal mento scende,
E setolosa la giocaia trema,
Nè solo io vidi le silvestre fere;
Ma vidi pur gli equorei vitelli
Affrontati con orsi: anco la belva
Vidi del nome del cavallo degna,
Se ben deforme, che in un fiume nasce....
Quel fiume che trabocca e i colli irriga.
Oh quante volte trepidando scôrsi
Spalancarsi l’arena, e dall’aperta
Voragin della terra emerger belve!
E spesso fuor de le latebre istesse
Crebber piante che avean d’auro le fronde,
E le cortecce del color del croco»[505].
Contro il costume dei suoi antecessori, sembra che Diocleziano non abbia dato nell’Anfiteatro Flavio solenni giuochi, neppure allorchè venne in Roma per celebrarvi i vicennali. Il Muratori[506] dà di questo fatto, quasi singolare, la spiegazione seguente:
«Parla ancora (Lattanzio) di sontuosi conviti dati in questa occasione da Diocleziano, ma non già dei solenni giuochi, siccome costumarono i precedenti Augusti, perchè egli, studiando il più che potea il risparmio, si rideva di Caro e d’altri suoi predecessori, che secondo lui scialacquavano il danaro nella vanità di quegli spettacoli. Uscirono perciò contro di lui varie pasquinate in Roma; [118] e non potendo egli soffrire cotanta libertà ed insolenza, giudicò meglio di ritirarsi da Roma e di andarsene a Ravenna verso il fine dell’anno, senza voler aspettare il primo dell’anno seguente, in cui egli doveva entrar Console per la nona volta».
Ed ora eccoci ai Cesari cristiani. Costantino, nell’anno 325, che è l’anno del Concilio Niceno[507], diresse da Berito (Beirut) a Massimo una legge[508], colla quale proibiva universalmente gli spettacoli gladiatorî, e li vietò non soltanto per aver letto i libri di Lattanzio Firmiano[509], ma molto più perchè il cristianesimo fu mai sempre nemico acerrimo della barbarie e d’ogni crudeltà. «Sono notissime, dice il ch. Lanciani[510], le fasi della lotta lunga e pertinace sostenuta dalla nascente civiltà cristiana e dal mitigarsi della fierezza degli antichi costumi contro i giuochi gladiatorî».
Già nel 315 Costantino ordinava ad Eumelio (il quale nell’anno seguente diveniva vicario dell’Africa) di togliere l’uso di marcare in fronte con ferro rovente i gladiatori condannati a morte; e ciò, per non disonorare il volto umano, in cui si traluce sempre qualche vestigio della beltà celeste[511]. Dalla stessa Berito emana Costantino un’altra legge, vietando assolutamente ai giudici di condannare i rei alla condizione gladiatoria; e comanda che questa pena sia commutata co’ lavori forzati alle miniere, affinchè, senza spargimento di sangue, il reo subisca la pena dei suoi delitti: nell’ozio civile, e nella domestica quiete non piacciono gli spettacoli sanguinosi[512].
Ma il popolo amava troppo i vietati divertimenti! Non era prudente urtare soverchiamente la sua passione; e quindi fu mestieri tollerare ancora gli spettacoli nell’Anfiteatro Flavio. Ce n’è testimonio S. Agostino[513], il quale narra che circa l’anno 390 venne in Roma Alipio, il quale fu talmente violentato dai suoi amici a portarsi al nostro Anfiteatro, onde assistere ai ludi gladiatorî, che finalmente s’arrese. Alipio era cristiano; l’avea battezzato S. Ambrogio in Milano; e, nell’accondiscendere ai suoi amici, fè proposito di assistere ai giuochi [119] cogli occhi chiusi. Resistè per molto tempo in questa posizione; ma verso la fine dello spettacolo, il popolo, per una singolare presa di gladiatori, proruppe in una grande acclamazione; e il povero Alipio non potè più a lungo resistere: fu vinto dalla curiosità, aprì gli occhi, e alla vista dello spettacolo rimase ferito nel cuore: spectavit, clamavit, exarsit, abstulit secum insaniam, qua stimularetur redire et alias trahens.
Anche fuori di Roma si proseguì a dare qualche spettacolo gladiatorio. Labanio Antiocheno[514] afferma che, solo quattr’anni dopo la legge suddetta, il suo zio materno diede in Antiochia una meravigliosa giostra di gladiatori.
Nell’anno 357 l’Imperatore Costanzo ordinò ai munerarii, sotto multa di 6 libbre d’oro, di non adescare col danaro i soldati; e proibì, in pari tempo, a coloro che avessero una dignità palatina, di ascriversi al detestabile ceto gladiatorio. Stabilì inoltre di rimettere ai maestri dei cavalieri e dei pedoni, nonchè ai governatori di palazzo, i militi e palatini che spontaneamente si presentassero al detto munerario per divenire gladiatori[515]. Nel Lanciani[516] leggiamo: «Costanzo e Giuliano ai 16 di ottobre del 357 indirizzarono ad Orfito pr. urb. altra costituzione sullo stesso argomento[517], confermata da Arcadio e da Onorio nel 397. La mala usanza prevalse ad onta di tutti quegli editti».
Gl’Imperatori Valentiniano e Valente (a. 364) ordinarono a Simmaco, Prefetto di Roma, che nessun cristiano, per qualsivoglia delitto, venisse più condannato ai ludi gladiatorî[518].
Nell’anno 397 Arcadio ed Onorio proibirono ai Senatori di ricevere i gladiatori al loro servizio; ed ordinarono che presentandosi essi a questo scopo, si trasportassero nelle più remote solitudini[519].
Apprendiamo da Prudenzio[520] che sotto l’impero di Onorio si davano ancora spettacoli gladiatorî. Il poeta ci descrive gli spettatori di quei barbari ludi:
Respice terriferi scellerata sacraria ditis,
Cui cedit infausta fusus gladiator harena;
detesta quel crudele piacere:
Quid mortes juvenum? quid sanguine pasta voluptas?
Quid pulvis caveae semper funebris, et illa
Amphitheatralis spectacula tristia pompae?
[120] e rivolgendo la parola all’Imperatore, lo scongiura perchè voglia una buona volta abolire quelle scelleratezze:
Quid genus, ut sceleris, iam nesciat aurea Roma,
Te precor, Ausonii dux augustissimi regni,
Et iam triste sacrum jubeas, ut caetera tolli.
Onorio! prosegue Prudenzio, tuo padre (Teodosio il grande) vietò di sacrificare agli idoli, e fece bene; ma tu maggior gloria t’acquisteresti se vietassi il massacro umano, o i ludi gladiatorî, permettendo le sole venationes:
Ille urbem vetuit taurorum sanguine tingi:
Tu mortes miserorum hominum prohibeto litari.
Nullus in urbe cadat, cujus sit poena vuluptas,
Nec sua virginitas oblectet coedibus ora.
Jam solis contenta feris infamis harenae,
Nulla cruentatis homicidia ludat in armis[521].
Nel 403 o 404, in seguito alla ben nota uccisione del monaco Telemaco[522], della quale noi già trattammo nell’Introduzione, ebbero fine i giuochi gladiatorî[523].
[121]
Le venationes proseguirono a celebrarsi fino al secolo VI. Quantunque la lotta degli uomini colle belve fosse pur essa sanguinosa, nondimeno i principi e gli scrittori non la riguardarono molto dal lato umanitario. Due, a mio parere, ne furono le ragioni: 1.º, perchè era quasi impossibile l’intiera, simultanea e repentina abolizione degli spettacoli gladiatorî e venatorî, pei quali, come è noto, i popoli nutrivano tant’affetto; 2.º, perchè i bestiarî od arenarî erano quasi tutti rei di delitti capitali, e quindi doveansi sottoporre all’estremo supplizio; perciò si credè più opportuno ed umano che morissero uccisi dalle belve, piuttosto che per mano de’ loro simili.
Nel 399, per celebrare e solennizzare il consolato di Flavio Manlio Teodoro, si diedero nell’Anfiteatro delle cacce; e Claudiano, nel panegirico che pronunziò di quel console ed in quella occasione[524], passò in rassegna le fiere che in quella venatio dovean irrigare di sangue l’arena.
Essendo Imperatore Teodosio e Placido Valentiniano (a. 442), le venationes erano ancora in vigore, giacchè sappiamo che il Prefetto Rufo Cecina Felice Lampadio, restituì, come vedremo nel seguente capitolo, l’arena, il podio, ecc. A suo luogo riporteremo le lapidi che ricordano questi restauri.
Nel 519 Eutarico Cillica, sposo di Amalasunta, figlia di Teodorico, si portò in Roma per celebrare, con elargizioni e sontuose feste, il suo consolato. All’uopo si fecero venire dall’Africa belve feroci e peregrine, le quali, per le loro strane forme, eccitarono gran maraviglia negli spettatori[525].
Nell’anno 523 finalmente, assumendo il consolato Anicio Massimo, si diedero nell’Anfiteatro Flavio gli ultimi spettacoli, dei quali rimanga memoria.
Calati in Italia i Goti col loro Re Witige (a. 537), assediarono Roma. Belisario venne in soccorso dei Romani[526], e alla prigionia di S. Silverio seguirono [122] altre calamità. Roma ebbe allora ben altro a pensare; e i giuochi anfiteatrali cessarono onninamente. E molto meno si pensò ad essi in appresso, nel tempo che la capitale del mondo fu oppressa dal duro giogo dei Goti e dei Longobardi, sino ai tempi di Carlo Magno (see. VIII).
Ed ora, prima di chiudere questo capitolo mi sia lecito presentare in nota ai lettori il testo di una lettera che Teodorico inviò al console Massimo[527]. In questa lettera il re gotico raccomanda a Massimo di rimunerare con lauti premî i venatores, e di premiarli più generosamente che i lottatori, i sonatori ed i cantanti; perchè quelli (dice), ond’essere applauditi, si espongono nell’arena dell’Anfiteatro Flavio a divenire preda certa delle feroci belve, ed a provare (prima che lo spirito abbandoni le lacere membra) i più crudeli tormenti. Detesta un tale spettacolo, inventato per onorare la Scitica Diana, la quale dilettavasi [123] dell’effusione del sangue. Dopo una breve descrizione dell’Anfiteatro Flavio, Teodorico passa a narrare la maniera degli inumani ludi; quindi raccomanda di nuovo al console di mostrarsi liberale verso quegli uomini, che, per festeggiare il suo consolato, sono invitati alla morte; e conchiude: «Ahi deplorevole errore degli uomini! Se un lieve lume splendesse di ciò che richiede giustizia, di tante ricchezze si userebbe a favore della vita dei mortali, piuttosto che gittarle per procurarne la morte».
«È singolare, conchiuderò col Gori[528], il modo di ragionare di Teodorico. Giudica l’atto detestabile; ma, per non opporsi al fanatismo popolare, non solo ordina di tollerarlo, ma anche di ricompensarlo con molta liberalità!».
[125]
Capitolino, nella vita di Antonino Pio, ricorda un restauro fatto da quest’Imperatore. Tale restauro si crede comunemente occasionato dal grande incendio avvenuto in Roma sotto lo stesso imperatore, fondandosi sul passo di quell’autore[529]: Adversa eius temporibus[530] haec provenerunt.... Romae incendium quod trecentas quadraginta insulas vel domos absumpsit.... opera eius haec extant: Romae Graecostadium post incendium restitutum, instauratum amphitheatrum. Ma se al Ch. Lanciani[531] sembrò un mistero l’incendio dell’Anfiteatro Flavio, prodotto da un fulmine (il che peraltro potè avvenire a cagione delle molte parti lignee, che si trovavano internamente sulla sommità dell’Anfiteatro), a me sembra, più che un mistero, un’impossibilità fisica che un incendio avvenuto nelle vicinanze del Grecostadio, Graecostadium post incendium restitutum, ed estesosi fin presso l’Anfiteatro, avesse potuto colle sue vampe traversare un’area libera che lo circondava: area che nel punto più stretto era di circa 25 metri; ed abbia potuto danneggiare il colossale recinto esterno di travertino, il quale, del resto, noi vediamo tuttora illeso, se facciamo eccezione di tre o quattro archi del piano terreno, che, come è noto, soffrirono il fuoco nel medio evo.
Del restauro di Antonino Pio non se ne hanno documenti epigrafici, lo che indica essere stata cosa di lieve momento. Il Mezzabarba, nel suo volume delle medaglie, assicura trovarsene una coll’effigie di Faustina, moglie di Antonino Pio, coniata dal Senato, colla scritta:
PVELLAE FAVSTINIANAE S. C.
[126] e portante sul rovescio la figura di un edificio non dissimile dal nostro Anfiteatro. Questa medaglia, prosegue il Mezzabarba, fu conservata nel Museo Bassetti; e, secondo la descrizione trasmessagli dal Noris, giudica che siffatto edificio rappresenti il restauro di quest’Anfiteatro, eseguito da Antonino Pio in onore e memoria della sua moglie Faustina. «Di qual sorta però fosse, dice il Marangoni[532], non ne troviamo memoria».
Sotto il brevissimo impero di Macrino[533], l’Anfiteatro Flavio arse. Dione[534], che fu teste oculare, così parla[535]: «Il teatro venatorio[536], percosso dal fulmine nello stesso giorno dei Vulcanali, fu così incendiato, che rimasero incendiati tutti i gradini ed il recinto superiore; e tutto il resto fu dal fuoco danneggiato. Nè giovò l’aiuto umano, quantunque vi scorresse, per così dire tutta l’acqua di Roma; nè potè arrestarlo la pioggia, che in grande copia e veemenza cadeva; quasi che l’acqua che vi cadeva da ambo le parti venisse assorbita dalla forza dei lampi: e vi si aggiunse che per questo motivo lo spettacolo dei gladiatori per molti anni si diede nel circo».
Ma come mai il fulmine potè far ardere l’Anfiteatro? Il Ch. Lanciani[537] dice a tal proposito: «per me è un mistero che il Colosseo possa essere stato da un fulmine ridotto a così mal termine, d’aver avuto bisogno di non men di sei anni per ripararlo. D’altronde il fatto è provato dalla testimonianza di Dione, dalle monete di Severo Alessandro e dai grandi restauri di quell’età». Ma se si rifletta che la parte superiore dell’Anfiteatro era circondata da una grande quantità di legname; che sul terrazzo del portico v’erano attorno attorno arrotolate le voluminose tende di ciascun settore del velario e l’immenso cordame per distenderle; che v’erano inoltre 240 verricelli lignei, i quali erano necessarî per la giusta tensione dei canapi, e che, verosimilmente erano incatramati e formavano l’ossatura del velario stesso; non si rimarrà più tanto dubbiosi in ammettere che un fulmine, investendo le travi esterne verticali foderate di bronzo, abbia potuto produrre una tanto disastrosa catastrofe, [127] e danneggiare la parte marmorea del monumento. Sembra che in quell’occasione andò in fiamme pur anche il pavimento o suolo ligneo dell’arena, del quale il Lanciani[538] scrive: «L’arsione poi del pavimento o suolo dell’arena, dimostrerà a coloro che non la vogliono intendere, che, almeno fino dal principio del terzo secolo, l’arena lignea era pensile sulle proprie costruzioni».
Nell’anno stesso dell’incendio, ma prima che questo avvenisse, Macrino avea già aboliti i giuochi volcanali; ma la rovina dell’Anfiteatro, avvenuta ἐν ἀυτῆ τῶν Ἠφαιστείων ἡμέρα, cioè nel giorno stesso nel quale avrebbero dovuto aver luogo i ludi aboliti, destò nel popolo tal terrore superstizioso, che ne domandò e ne ottenne il ripristinamento[539].
Sotto l’impero di Eliogabalo, s’iniziarono i restauri del nostro edificio: Et Amphitheatri instauratio post exustionem[540]; e nell’anno 223 Severo Alessandro li proseguì[541], ordinando che le tasse sborsate dalle donne di male affare si destinassero ai restauri dell’Anfiteatro, del teatro di Marcello, del circo e dell’erario: Lenonum vectigal, et meretricum, et exoletorum in sacrum aerarium inferri vetuit, sed sumptibus publicis ad instaurationem theatri, circi, amphitheatri et aerarii deputavit[542]. Severo Alessandro condusse a termine il restauro; e di questo risarcimento fa fede quel nummo già da noi riportato al capitolo quarto, e che nel diritto presenta la protome dell’Imperatore paludata, coll’epigrafe:
IMP . CAES . M . AVR . SEV . ALEXANDER AVG .
e nel rovescio, l’Anfiteatro con combattenti, e fuori di esso persone togate, ed intorno la scritta:
PONT . MAX . TR . P . II . COS . P . P . S . C .[543]
(a. 976/223).
Il Maffei crede che l’ultima mano al restauro l’abbia data Gordiano Pio (a. 238); e lo deduce da quell’insigne medaglione che egli riporta nella tav. I [128] della sua opera sull’anfiteatro di Verona. La medaglia offre nel dritto la protome di Gordiano III, coll’epigrafe:
IMP . GORDIANVS PIVS FELIX AVG .[544]
e, nel rovescio, l’Anfiteatro avente a sinistra la Mèta ed il Colosso, a destra una specie di portichetto arcuato, sostenuto da colonne ed ornato di timpano il quale copre una statua stante; in mezzo all’arena poi presenta un toro alle prese con un elefante, e nel dintorno l’iscrizione:
MVNIFICENTIA GORDIANI AVG.
In basso si scorge l’Imperatore a cavallo, munito di scettro e preceduto da una Vittoria; e dietro il cavallo, un soldato. Questa medaglia o monumento numismatico non presenta una data positiva, ma certo appartiene al periodo fra l’anno 238 dell’êra volgare (in cui Gordiano ebbe il titolo d’Augusto) e l’anno 244, quando Gordiano rimase estinto pel nero tradimento di Filippo[545]. Anche il Canina[546] è di parere che Gordiano abbia aggiunte altre opere all’Anfiteatro. Ma il Ch. Lanciani[547] dice che questa asserzione è gratuita; imperocchè di Gordiano Giuniore opera.... Romae nulla extant praeter quaedam nymfia (sic) et balneas[548].
Circa l’anno 259 o 260 l’Anfiteatro Flavio tornò a subire un nuovo incendio; ma il danno fu lieve, e il monumento venne tosto restaurato dall’Imperatore Decio[549]. Se di questo restauro ne fu lasciata memoria in marmo, questa è perita.
Una legge[550] emanata da Costantino in Sardica il 17 Dicembre, e ricevuta gli otto marzo del 321, si riferisce alla consulta degli aruspici, in caso che un fulmine colpisse un pubblico edificio. In questa legge parlasi di un anfiteatro, e molti pensano che si alluda all’Anfiteatro Flavio. Se così fosse, il danno prodotto dal fulmine dovè essere di piccolissimo momento, giacchè nè gli storici nè i cronografi ne fanno menzione.
Nel 357 l’Anfiteatro era nella sua piena integrità. Ammiano[551] ricorda la nostra grandiosa mole con maraviglia: Inter alia, Amphitheatri molem [129] solidatam lapidis tiburtini compage, ad cuius summitatem aegre visio humana conscendit.
Paolo Diacono narra che circa l’epoca dell’irruzione degli Unni nella Tracia e nell’Illiria[552], Roma fu scossa da un violento terremoto, il quale danneggiò e fe’ crollare molti insigni edificî: Sub his fere diebus tam terribili terraemotu Roma concussa est, ut plurimae aedes eius et aedificia corruerunt[553].
Fra gli edifici danneggiati vi fu probabilmente anche l’Anfiteatro Flavio, giacchè, regnando Valentiniano III, negli anni cioè 425-455, ebbero luogo in esso importantissimi restauri. Ci porge questa notizia la epigrafe seguente:
Quest’epigrafe, pubblicata dal Fea[554] e riprodotta dal Parker[555], e incisa in un masso di «marmo pantelico.... quadrato di circa 20 palmi in lunghezza.... rotto, cadendo dall’alto, e di altezza 5 palmi, once 7.... Ha servito prima questo masso a due altri usi. In principio forse per pilastro o spalla a qualche edifizio grandioso, come quelli dell’Arco di Tito: perchè vi si vede, nella faccia sotto l’iscrizione per lungo, un festone simile di frondi e di animali, di assai buona e grandiosa maniera.... Dove è l’attuale iscrizione prima ve ne era un’altra in caratteri assai più grandi di bronzo, come si rileva dagli incavi delle lettere ancora esistenti in molti punti di tutte le linee: malgrado che siano state rasate le lettere per incidervi le nuove.... È notabile il luogo ove si è trovato il marmo. Questo è nel grande portico di mezzo.... poco avanti verso l’arena ai due piloni di travertini, sopra una selciata grande salita, fattavi nei bassi tempi.... E questa è la terza selciata che si è discoperta»[556].
Il marmoreo ricordo conservasi presso il luogo della scoperta. Le lacune dell’iscrizione sono state così supplite:
Salvis [dd] nn Theodosio et Placido V[alentiniano augg.]
Ruf[us] Caecina Felix Lampadius v. c. [et inl. praef. urbi]
ha[re]nam amphitheatri a novo una cum po[dio et portis]
p[ost]icis, sed et reparatis spectaculi gradibus [restituit]
[130]
Noi già demmo il nostro giudizio nel supplemento di quest’epigrafe e sulla frase: Portae Posticae usata in questa lapide[557].
V’ha un frammento epigrafico che dice:
SALV( d. n.... VC ET 
TASIV
VM
(C. I. L. VI, p. 860, n. 83 Addit. 32099).
Questo frammento è più oscuro dell’altro che troviamo nel C. I. L. p. 860, n. 95, il quale benchè si riferisca certamente ad un restauro, nondimeno per essere troppo meschina cosa non possiamo giudicare della qualità dei restauri stessi. Ecco il frammento:
salvIS . DD nn . theodosio et
placiDO VAlentiniano augg.
aniciVS ACilius Glabrio Faustus (?)
v . c . et inl . praef . urbi restituit (?)
«Negli anni 467-472, un Messius Phoeb..., probabilmente prefetto della città, condusse nuovi restauri nell’Anfiteatro. Ne fan fede quattro brani di epigrafe scoperti negli ultimi scavi:
[131]
«I frammenti a b sono editi nel C. I. L. VI, p. 860, 100: il frammento c è inedito: il frammento d sta pure nel C. I. L. p. 860, n. 86. Mi sembra evidente trattarsi di due versioni dell’istessa iscrizione, la quale ricorda restauri che non è possibile determinare con precisione. Il nome dell’autore dei restauri si ritroverà nell’iscrizione dei sedili. I frammenti sopra riferiti sembrano chiamarlo vir clarissimus et inlustris praefectus u(rbi) patricius co(ns) ordinarius cet.»[558].
Un altro terremoto danneggiò l’Anfiteatro Flavio, essendo Prefetto di Roma Decio Mario Venanzio Basilio; e questi lo restaurò sumptu proprio, forse nell’anno 508. Tre iscrizioni rinvenute nell’Anfiteatro ce ne fanno fede.
La prima dice:
VENANTI
VC
COS
DECIVS MARIVS VE
NANTIVS BASILIVS
VC ET INL PRAEFECTVS
VRBI PATRICIVS CONS a 508
ORDINARIVS ARENAM
ET PODIVM QVAE ABOMI
NANDI TERRAE MOTVS
RVINA PROSTRA
VIT SVMPTV PRoPRIo RESTITviT[559]
«Nel 1810, nella prima arcata in fuori della parte Nord, a sinistra dell’ingresso, sepolta da calcinacci»[560] si trovò una lapide opistografa. Nella fronte si legge:
d. n. iNVICTISSIMO
m. auRELIO.
caRINO. PIO
fel. iNVICTO. AVG a. 284/85
chreSIMVS TABVL.
suMMARVM RATIONVM
cuM PROXIMIS ET ADIVtoriB
nuMINI EIVS DICA
TISSIMI
[132]
Nel lato opposto:
DECIVS MARIUS VENAN
TIVS BASILIVS VC ET INL PRAE
FECTVS VRB PATRICIVS
CONSVL ORDINARIVS ARE
NAM ET PODIVM QVAE
ABONTINANDI TER
RAE MOTVS RVIN PROS
TRAVIT SVMPTV
PROPRIO RESTITVIT
Il 23 agosto 1813 fu trovata questa iscrizione in pessimi caratteri nell’Anfiteatro Flavio, benissimo conservata. Stava in origine sul podio dalla parte settentrionale verso il tempio di Roma e Venere, poi caduta giù nell’Arena»[561].
DECIVS MARIVS VENANTIVS (sic)
BASILIVS V C ET INL PRAEF
VRB PATRICIVS CONSVL
oRDINARIVS ARENAM ET
PODIVM qVAE ABoMI
NANDI TERRAE Mo
TVS RVINA PROS
TRAVIT SVMPTV PRO
PRIO RESTITVIT[562]
Decio Marco Venanzio Basilio visse ai tempi di Teodorico[563], ed alcuni cronografi fissano la prefettura di Basilio all’anno 508. I restauri dell’arena e del podio si praticarono probabilmente dal Prefetto della Città poco prima dei giuochi venatorî esibiti da Cillica.
Nel Marangoni[564] si legge: «Il sig. cav. Maffei[565] dice essere stato scritto che mons. Ciampini possedesse un’iscrizione, in cui facevasi memoria [133] di un risarcimento del Colosseo fatto da . . . . . Teodorico: ma che avendo egli pregato mons. Bianchini . . . . questa iscrizione non si è potuta trovare»[566].
L’iscrizione era verosimilmente uno dei soliti sigilli figulini:
✠ REG. D. N. THEODERICO. FELIX. ROMA ovvero BONO. ROME[567]
[135]
Sòrte le ostilità fra i Goti e l’Impero d’Oriente, Roma andò soggetta per venti e più anni a gravissimi mali. Non pare perciò probabile che in quel tempo il popolo romano pensasse ai giuochi ed ai pubblici divertimenti. Svanì pian piano l’uso degli spettacoli anfiteatrali; e la grande e venerabile mole dei Flavî rimase inutile e quasi abbandonata: così principiò a soffrire gli insulti degli uomini e dei tempi.
Quando nell’anno 663 l’Imperatore Costantino III venne in Roma, l’Anfiteatro Flavio conservavasi ancora intatto. Costantino depredò i bronzi dei romani monumenti: «XII dies in civitate Romana perseverans (Costantinus), omnia quae erant in aere ad ornatum civitatis deposuit; sed et ecclesiae sanctae Mariae ad Martyres quae de tigulis aereis erant discoperuit et in regia urbe cum alia diversa quas deposuerat direxit»[568].
Costantino III fu dunque causa della mancanza degli oggetti di bronzo che si è verificata in quasi tutti gli scavi praticati nel nostro Anfiteatro; e probabilmente fu pure ai tempi di quell’Imperatore che scomparvero i clipei di bronzo e le coperture delle travi esterne del velario: anzi, con ogni verosimiglianza, fu egli stesso il rapitore della famosa statua colossale ricordata da Marziale, e che noi scorgiamo raffigurata sulle medaglie di Gordiano III, posta sopra un basamento, quasi di contro alla Mèta Sudante. È vero che lì presso, come scrive Flaminio Vacca[569], fu rinvenuta una testa colossale di [136] bronzo[570], rappresentante, secondo il parere di alcuni, Commodo; ma quel rinvenimento non può fare ostacolo alla supposizione accennata, perchè quella testa, secondo il giudizio degli scultori, e come leggesi nel Venuti[571], non corrisponde alle misure del Colosso lasciateci dagli scrittori antichi.
Se la famosa profezia attribuita al Ven. Beda fosse autentica, e se l’interpretazione che ne dànno alcuni storici antico-moderni fosse giusta, noi potremmo ritenere che nel secolo VIII l’Anfiteatro Flavio si conservasse ancora integro. Ma poichè oggi si dubita dell’autenticità di quel passo[572], ed è ben diversa l’interpretazione che varî storici contemporanei ci offrono di esso; non potrà sentenziarsi sull’integrità dell’Anfiteatro nel secolo VIII, fino a che sulla profezia di Beda non si sparga nuova luce. Sappiamo nondimeno che in quel secolo la celeberrima mole dei Flavî incominciò ad esser chiamata, anche da scrittori serî, indifferentemente Amphitheatrum e Colosseum. Nell’Itinerario di Einsiedeln[573] leggiamo infatti: «Palatin traiani. Amphitheatrum»; nel Libro Pontificale invece[574] troviamo: «Colosseum».
Si disputa fra i dotti se l’Anfiteatro Flavio abbia avuto il nome di Colosseo per la grandiosità della sua mole, ovvero se questa voce abbia tratto origine dal vicino Colosso di Nerone[575]; o se finalmente tal denominazione abbia avuto principio dalla posizione topografica del monumento: vale a dire, se l’etimologia del Colosseo, il quale «trovavasi nella regione d’Iside e Serapide», provenga dalla corruzione della voce Collis Isaeum[576].
Riportiamo le ragioni dei singoli scrittori, ed esaminiamo le loro sentenze.
Il Donati, il Nardini, il Ficoroni, il Venuti e generalmente tutti i topografi di Roma fino al Nibby, opinarono che «Colosseo» derivi dal Colosso di Nerone, che sorgeva prossimo all’Anfiteatro Flavio, e che quel nome sia stato usato per la prima volta nei secoli barbari.
[137]
Questi archeologi vedevano tanto limpida detta derivazione, da crederne inutile un’opportuna dimostrazione. — Che il Colosso di Nerone fosse celebre nell’antichità, ce l’attesta il ricordo che, con segni di vera ammirazione, ce ne trasmisero gli storici ed i poeti; e più ancora lo deduciamo dalla festa annua che ai 6 di Giugno celebravasi in suo onore e che ci è stata tramandata dal Calendario Filocaliano colla frase: Colossus coronatus. Questa festa fu probabilmente istituita in memoria della dedicazione di quel Colosso al Sole, allorquando Vespasiano, damnatis sceleribus illius principis, cioè di Nerone, lo coronò con sette raggi colossali[577]. Ma non sembra credibile che quei dotti abbiano potuto opinare che l’Anfiteatro Flavio assumesse il nome di Colosseo nei secoli barbari. Essi infatti dovean sapere (o almeno dubitarne) che a quei tempi il Colosso non più esisteva. Io mi permetterei piuttosto congetturare che quegli scrittori pensassero invece che quella voce fosse un’eco di un modo volgare antico, venuto in uso ai tempi di Adriano, e precisamente allorquando quel celeberrimo Colosso Neroniano venne collocato a pochi passi dall’Anfiteatro.
Di questo trasporto, fatto dal suddetto Imperatore, ce ne trasmise la memoria Sparziano[578]; e la somma difficoltà dell’impresa e la sua felice attuazione dovettero senza dubbio lasciare nel volgo una profonda impressione, la quale potè in seguito influir tanto da far sostituire nel discorso volgare alla parola Amphitheatrum la voce Colossus. E ciò potè facilmente avvenire cambiando la frase ire ad amphitheatrum, in: ire ad colossum; cangiamento il quale avrebbe dato, in questo caso, origine alla frase (ora un po’ strana, ma forse allora semplicissima): ad Colossum eo; espressione che, per una naturale eufonia, potè divenire ad Coloss’eo; e poichè nell’Anfiteatro Flavio si davano continui spettacoli, e v’era quindi occasione frequente di usare quella frase, pian piano l’Anfiteatro Flavio divenne addirittura il Colosseo.
Un caso non simile ma uguale è avvenuto ai tempi nostri. Il teatro principale di Roma, detto di Apollo, sorse presso la Torre di Nona; e sebbene questa torre non si possa affatto paragonare al famoso Colosso di Nerone, pur nondimeno essa diè il nome al teatro; e detta denominazione fu usata da tutti indistintamente, anche dalle persone di più alto ceto, in modo, che formatasi dalle due parole un’unica voce, ognuno per dire: vado al teatro di Apollo, diceva: vado a Tordinona. Non pare adunque impossibile che anche [138] gli antichi invece di dire: ad amphitheatrum eo, dicessero: ad colossum eo e poscia, per eufonia, ad Coloss’eo[579].
Se poi si volesse ricercare nell’antichità un’origine più conforme alla gravità di quei dotti, potremmo opinare che quel vocabolo si principiasse ad usare subito dopo effettuato il trasporto del Colosso a pochi passi dell’Anfiteatro; e che, come da Isis nacque Isaeum, da Adriano Adrianeum, ecc.; così anche dal Colosso sia nata la voce Colosseum.
In ogni modo, che l’Anfiteatro Flavio sia stato chiamato dal volgo Colosseo prima del secolo VIII è un fatto certo; e una prova la troviamo negli stessi documenti del secolo VIII, nei quali la parola Colosseo è usata come nome proprio dell’Anfiteatro a tutti cognito.
Il Maffei, il Mazzocchi, il Nibby ed altri ritengono che l’Anfiteatro Flavio non abbia preso il nome di Colosseo per il Colosso, ma per la sua colossale mole. Ecco le parole del Maffei[580].
«Questa mirabil mole chiamasi in Roma per tradizione immemorabile il Coliseo; in latino si trova scritto Coliseum o Colosseum. Il comune consenso dei moderni scrittori ha già fissato da gran tempo, che così si denominasse l’Anfiteatro dal popolo, perchè in poca distanza da esso stesse il Colosso di Nerone: ma alcune considerazioni io proporrò, perchè altri giudichi se così debba continuarsi a credere. Il Colosso di Nerone[581] alto 120 piedi, opera di Zenodoro, fu collocato nel vestibolo della sua Casa aurea. Abbiamo un epigramma di Marziale[582] per cui si trova Tito d’aver restituita all’uso pubblico, e convertita in benefizio comune quella grande parte di Roma che Nerone aveva occupata con la sua casa. Vediamo in esso, come ov’era prima l’atrio, Tito fece strada, in poca distanza dalla quale era il Colosso, e vediamo come la venerabil mole dell’Anfiteatro non fu alzata nel sito dell’atrio, o sia del vestibolo, ma in quello delle peschiere (stagna Neronis erant), che dovean certamente essere dal vestibolo assai lontane. Presso all’Anfiteatro, ov’eran prima orti e passeggi, fece Terme chiamate da Marziale veloci doni (velocia munera); la ragione appar da Suetonio, che dice furono edificate in fretta (celeriter extrudis).
«Altre osservazioni ancora par che persuadano rimanesse in non piccola distanza dall’Anfiteatro il Colosso di Nerone. Fu esso poi mosso dal suo luogo, e fatto trasportare da Adriano: secondo Sparziano fu allora dedicato al Sole; [139] ma sappiam da Plinio[583], damnatis sceleribus illius principis, che ciò era fatto fin dai suoi tempi, in odio alle scelleraggini di Nerone, e però quando il fece ristorar Vespasiano, di che parla Suetonio. Commodo poi lo tramutò di nuovo, fattagli levar la testa con riporvi la sua. Ora dice Sparziano che nel sito ov’era prima il Colosso, fu poi fatto il Tempio della Dea Roma (De eo loco in quo nunc templum Urbis est), quale non sarà certamente stato a ridosso dell’Anfiteatro; anzi convien dire ne fosse assai lontano, s’è il mentovato da Vittore in region diversa (Templum urbis Romae). L’istesso autore mette pure in region diversa dall’Anfiteatro un Colosso, distinto tra gli altri, e di consimil grandezza, che per quello appunto di cui si parla, par si palesi dall’aver avuto sette raggi intorno al capo, che lo denotavano sacro al Sole. Non potè adunque denominarsi l’Anfiteatro da statua, che non gli era prossima, nè attinente per nessun conto».
La prima parte dell’argomentazione del Maffei si basa chiaramente sopra un falso supposto. Egli infatti crede che il Colosso di Nerone fosse assai lontano dall’Anfiteatro, mentre ormai nessuno dubita che il tempio di Venere e Roma, ossia il templum Urbis di Sparziano, trovavasi immediatamente di fronte al Colosseo; e quindi sappiamo di certo il posto ove Adriano collocò il Colosso.
Sicchè è cosa positiva l’opposto di quanto opinava l’illustre storico Veronese; e il Colosso di Nerone, dedicato al Sole, fu sempre vicino all’Anfiteatro, e dopo il suo traslocamento trovavasi tanto prossimo ad esso, che se avesse avute aperte le braccia, avrebbe potuto quasi toccare colla mano i travertini del Colosseo.
Ma prosegue il Maffei: «che se prossimo ancora fosse stato un colosso a così vasto e dominante edifizio, anzi che dato il nome è assai più credibile l’avesse preso: e n’abbiam chiaro l’esempio, ove riferisce Plinio[584]: vocatur Pompeianus a vicinitate theatri, che un colosso di Giove, grande come una torre, fatto porre nel Campo Marzio da Claudio, per esser vicino al teatro di Pompeo, acquistò il nome di Pompeiano».
Il Colosso di Nerone sorse pur troppo vicinissimo all’Anfiteatro, eppure non prese il nome di Flavius o Flavianus! Nessuno degli scrittori antichi ce lo ricorda infatti con questo appellativo.
Gli ultimi due argomenti del Maffei sono i seguenti:
«Che se altri mi richiede, donde adunque originata io pensi tal denominazione, dirò che da null’altro, se non dal comparir questo edifizio tra tutti gli altri, quel che era tra le statue un colosso, e dall’uso antico di [140] chiamar così tutto ciò che eccedesse in grandezza. Vennemi questo pensiero gran tempo fa nel leggere in Suetonio, come a tempo di Caligola Esio Proculo per l’insigne ampiezza e bella forma del suo corpo veniva chiamato Colossero o Colosseo; come forse in quel luogo deve scriversi: ob egregiam corporis amplitudinem et speciem Colosserus dictus[585]».
Aggiunti altri esempî consimili, così prosegue;
«Mi accertai del tutto scorrendo poi l’Istoria d’Erchemperto Monaco dell’edizione di Camillo Pellegrini, replicata ora nel tomo secondo delle Cose Italiche; perchè due volte in essa chiamasi colosso (forse è da legger Colosseo) l’anfiteatro di Capua, dove non era certamente il Colosso di Nerone. Appar però manifestamente, come si dava tal nome agli anfiteatri dal popolo, per la loro maravigliosa altezza».
Tralascio gli esempî tolti dalla straordinaria grandezza dei corpi umani, perchè appunto da questi esempî si fa manifesto che il nome colosso fu sempre proprio delle statue gigantesche, e che da queste passò a significar coso di grande mole; e vengo all’ultimo argomento.
Il monaco Erchemperto chiamò colosso e forse Colosseo l’Anfiteatro di Capua, ove non era certamente il Colosso di Nerone; ma lo chiamò così quando l’Anfiteatro Flavio già da tempo dicevasi Colosseo; e se il suddetto monaco chiamò con questo nome l’Anfiteatro di Capua, dovè così chiamarlo come appunto un contadino (che io conobbi mentre egli era al servizio di un mio amico) soleva chiamare Via Appia qualunque antica via lastricata di poligoni di lava basaltina[586].
Il Mazzocchi non aggiunge agli argomenti del Maffei che l’autorità di Esichio. È vero che gli etimologisti greci fanno derivare la parola κολοσσός dallo sforzo che fa la vista per giungere ad una grande altezza; ma è pur certo che questo vocabolo κολοσσός e dai Greci e dai Latini fu costantemente usato ad indicare le statue di straordinaria grandezza.
Il Nibby finalmente dice di non poter ammettere che l’Anfiteatro Flavio abbia preso il nome dal Colosso di Nerone, perchè nei tempi barbari questo [141] non più esisteva. L’opinione del Nibby trova una risposta nella spiegazione già da me enunciata, e che io immaginai per poterci rendere ragione del come il Donati e gli altri dotti di sopra citati abbiano potuto ritenere che l’Anfiteatro Flavio prendesse il nome di Colosseo dal Colosso di Nerone.
Rimane ad esaminare l’opinione del Corvisieri, il quale crede che la voce Coliseo abbia tratto origine da Collis Isaeum. Ecco le sue parole: «.... Nel perdere il suo nome una contrada, quello talvolta non dispariva del tutto ma rimaneva appiccato ad un monumento vicino; come avvenne dell’Anfiteatro Flavio che prese nome di Colliseo da una vicina contrada così detta dall’Iseo sulle falde del colle Esquilino.... È d’avvertirsi che sì l’una che l’altra lezione[587] conservano chiare le forme del Collis Ysaeum, vocabolo poi convertito per eufonia in Collisaeum, il quale, come da per sè suona, non potè mai appartenere in origine all’Anfiteatro Flavio; ma bensì ad un tempio della Dea Iside, detto dal colle per la sua giacitura, ed anche per distinguerlo da qualsifosse altro tempio dello stesso titolo. L’anonimo Einsidlense, che si vuol vissuto tra l’VIII e il IX secolo, ebbe occasione di nominare nel suo schema topografico di Roma l’Anfiteatro Flavio, ma lo disse Amphitheatrum e non già Collosaeum, nè Colisaeum. Ho esaminato inoltre le leggende dei SS. Martiri, utilissime a rischiarare la topografia di Roma nel medio evo, come quelle che in buona parte, secondo la sana critica, si reputano esercitazioni rettoriche della letteratura monastica di quel tempo; e non ho mai trovato abbiano detto altrimenti che Anfiteatro quel luogo, il quale, per essere stato destinato alla morte di tanti campioni del cristianesimo, ebbero spesso il bisogno di nominare. La terza regione di Roma fu appunto detta di Iside dal tempio di questa Dea, che come principal monumento vi dovea figurare prima dell’impero di Tito e di Nerone. La memoria di questo tempio fu registrata nelle Mirabilia Romae: Coloseum fuit templum Solis, mire magnitudinis et pulchritudinis, diversis camerulis adaptatum, quod totum erat cohopertum ereo celo et deaurato, ubi tonitrua, fulgura, et coruscationes fiebant, et per subtiles fistulas pluvie mittebantur. Erant preterea ibi signa supercelestia et planete Sol et Luna que quadrigiis propriis ducebantur. In medio vero Phebus etc. — Ben s’intende che il Coloseo nell’età delle Mirabilia più non esisteva, poichè se ne parla come d’un monumento che fu; e quindi la descrizione che se ne fa così impropria si deve credere basata sulla volgare tradizione del popolo, il quale, lontano dai tempi dell’idolatria, potè facilmente esser tratto a credere come indizio del tempio del Sole qualche avanzo della sua decorazione che accennava ai misteriosi simboli del culto Isiaco tra’ quali avean pur luogo il Sole, la Luna ed altri segni celesti. Dobbiamo [142] aver sempre presente che nel medio evo si giudicò assai grossamente delle nostre antichità. Rari sono que’ monumenti, anzi rarissimi, che restarono immuni da un travisamento. Rispetto al Coloseo, poco ci caglia che non si scrivesse il giusto: ma basti il vederlo indicato ben diverso dall’Anfiteatro Flavio, com’è altresì questo del Coloseo. Forse fin dai tempi di Beda era già crollato il Coliseo, secondo mi par di raccogliere dall’oscurissimo contesto delle riferite parole; nelle quali con troppa serietà s’è detto racchiudersi una giocosa predizione di quel pio scrittore.
«Il Beda parla in quel punto della vana presunzione che ha l’uomo di non errare, della facilità che ne ha, e della vergogna che gliene deriva se ne venga convinto. A rafforzare la qual sentenza pare si valesse di quel vaticinio, che, dato come infallibile e come tale creduto, egli vedeva a’ suoi tempi smentito dal fatto. Il nome di Coliseo rimase per lungo tempo attribuito alla contrada, e scomparsi gli avanzi di quel monumento, passò quindi a distinguere unicamente il vicino Anfiteatro; e fu la colossale figura di questo, per cui il popolo, ignaro della vera origine del vocabolo, lo ammodò in Colosseo. A suggellare ciò che ho detto, adduco la gravissima testimonianza di Benedetto, canonico di S. Pietro (sec. XII), dalla quale si conosce come a suo tempo fosse ancora distinto l’Anfiteatro della contrada, che, come ho detto, prese il nome di Colisseo. Descrivendo egli l’itinerario del Papa nel tornare il lunedì santo dalla Basilica Vaticana al Laterano, dice che, giunto all’arco trionfale di Costantino, divertiva a sinistra ante Amphitheatrum et per sanctam viam juxta Colliseum[588]; e queste parole c’indicano eziandio chiaramente la postura del Colliseo sulle pendici dell’Esquilino»[589].
L’argomentazione del Corvisieri si riduce a questo: A levante dell’Anfiteatro v’è una lacinia dell’Esquilino, sulla quale (secondo il ch. autore) esisteva un tempio Isiaco, creduto nel medio evo del Sole. Questo tempio dalla sua elevata posizione, per distinguerlo dagli altri d’Iside che erano in Roma, fu detto Isaeum collis, dal che collis Isaeum e finalmente Colliseum e Coliseum; termine per lungo tempo attribuito alla contrada, e che poi, dal popolo ignaro della vera origine di quel vocabolo, fu applicato all’Anfiteatro Flavio, perchè lo vedeva un colosso! La poca sodezza di questa argomentazione è palpabile: con tutto ciò è bene dimostrarla.
Ritenere che su quella parte dell’Oppio la quale guarda l’Anfiteatro Flavio, sia esistito un tempio Isiaco, è un vero abbaglio. Non v’ha infatti chi ignori che quel sito fu occupato primieramente dalla Domus aurea di Nerone, la quale estendevasi dalla somma sacra via fin oltre le Terme di Traiano, con [143] tutte le sue parti sontuose, non esclusa la termale e la magnifica piscina detta oggi le Sette Sale: posizione determinata con chiarezza da Marziale e da Suetonio, e resa certa dalle escavazioni fatte in quella zona. Poscia sorse su quell’altura la casa di Tito; ed il rinvenimento del Laocoonte ricordato da Plinio, in Titi Imperatoris domo[590], ce l’ha dimostrato fino all’evidenza. Questa casa però non fu che la parte più nobile della Domus aurea, assegnata da Vespasiano a Tito, ed estendevasi sull’Oppio. Finalmente sopra una gran parte della domus Titi furono erette le Terme di Traiano, le quali si conservano ancora in parte, ma che nel secolo XVI si trovavano in tanto eccellente stato di conservazione, che Palladio potè lasciarcene i disegni[591]. Sappiamo inoltre che [144] il tempio d’Iside e Serapide della IIIª regione fu ben lungi da questa cima dell’Oppio; e sebbene ad alcuni sembrò vederlo sull’estremo lembo orientale del colle, pur tuttavia la grande maggioranza degli archeologi lo ritiene sorto nella valle Merulana, presso la chiesa dei SS. Pietro e Marcellino, dove in ogni [145] tempo vennero in luce copiosi monumenti Isiaci. Cade così la maggiore della argomentazione del Corvisieri, e con essa la conseguenza.
Tuttavia, se piacesse considerare per poco alcune prove addotte da quell’autore a sostegno della sua tesi, si troverebbero vacillanti assai. Ed invero, che dire del vaticinio così detto di Beda, e del passo delle Mirabilia riferiti dal Corvisieri al tempio d’Iside? Per ciò che riguarda il primo, converrebbe immaginarci il tempio d’Iside della III regione qualcosa di assai più celebre e grandioso del tempio di Giove Capitolino o del Pantheon, se il profeta, chiunque si fosse, fece dipendere da quel tempio le sorti di Roma e del mondo! Relativamente poi al passo delle Mirabilia, fa di mestieri osservare che questo è preso dalle Mirabilia breviata et interpolata[592] e che nella prima edizione della Mirabilia[593] e nella Graphia[594] è scritto: ante Coleseum templum Solis, e non Coleseum fuit templum Solis. Leggendo adunque, colle prime edizioni, ante Coleseum templum Solis, si rende chiaro che il templum Solis (che per il Corvisieri sarebbe lo stesso che Isaeum) non era nè poteva essere il Coloseum. Se inoltre il passo delle Mirabilia breviata et interpolata fosse stato riportato per intero, si sarebbe veduto a colpo d’occhio che le stesse Mirabilia interpolate distinguono il Colosseo dal tempio. Il passo infatti chiude con queste parole: Ante vero Coliseum fuit templum in quo fiebant cerimoniae praedicto simulacro (al Colosso del Sole). Del resto, il rozzo e molto superficialmente [146] erudito scrittore ci dà senz’altro la descrizione dell’Anfiteatro Flavio attinta dai classici. In quel coopertum aereo celo et deaurato vi si scorge l’esametro di Calpurnio: Balteus en gemmis, en illita porticus auro. Certatim radiant....; nell’ubi tonitrua, fulgura et coruscationes fiebant, apparisce il passo di Dione: «Il teatro venatorio percosso dal fulmine.... quasi che l’acqua che vi cadeva da ambo le parti venisse assorbita dalla forza dei lampi»; in quel per subtilis fistulas pluviae mittebantur si rileggono le parole di Seneca: Numquid dubitas, quin sparsio illa, quae ex fundamentis mediae arenae crescens in summam amphitheatri altitudinem pervenit, cum intentione aquae fiat.
Ma perchè andar più oltre colle osservazioni, se l’autore si basa su di un falso supposto?
Ecco come l’Adinolfi giudicò l’opinione del Corvisieri: «Vi è qualche erudito che vorrebbe distinguere il Coliseo da Anfiteatro, dicendo che l’Anfiteatro fosse vicino al Colle Iseo, opinione che ha della sofisticheria»[595].
Di fronte a queste disparate opinioni, il sagace e prudente lettore sceglierà quella che gli parrà più verosimile.
[147]
Dalla metà circa del secolo VI al secolo XI il Colosseo, a quanto pare, rimase abbandonato. Nessuno scrittore di quel corso di secoli fa menzione di esso; e perciò qui ci è impossibile colmare tant’ampia lacuna.
Sennonchè questa lacuna non è soltanto propria dell’Anfiteatro Flavio, ma è comune a tutti i grandiosi monumenti pubblici di Roma; come, ad esempio, il Circo Massimo, le Terme di Caracalla, quelle di Diocleziano, ecc. Nè noi possiamo renderci ragione di un tal fatto, se non opinando col Nibby che questi monumenti «non ostante che più non servissero allo scopo a cui erano destinati, e per questo lasciati dallo Stato in abbandono, tuttavia rimanendo di proprietà pubblica non fosse stato permesso ai potenti privati di quei tempi di occuparli; trovando così il perchè della mancanza per tre secoli e mezzo di documenti pubblici e privati relativi a monumenti di questo genere: sicchè non ci resta che contemplarne lo stato di completo abbandono in cui si trovarono in questo periodo».
Per quanto riguarda il Colosseo, possiamo ragionevolmente supporre che fin dalla cessazione dei ludi gladiatorî la custodia dell’Anfiteatro cominciasse ad essere trascurata, e che sempre più proseguisse col rarefarsi degli spettacoli venatorî. A questa trascuranza, d’altronde legittima conseguenza delle calamitose vicende di quei tempi, e dello spopolarsi della città, attribuì Teodorico, sul finir del secolo V, la ruina dei monumenti romani, come egli stesso dice per bocca di Cassiodoro: Facilis est aedificiorum ruina incolarum subtracta custodia, et cito vetustatis decoctione resolvitur quod hominum praesentia non tuetur. La reale ruina però ebbe principio dopo l’ultimo spettacolo dato da Anicio Massimo. Il Cancellieri[596] scrisse: «Il popolo romano chiese licenza a Teodorico di ristorare le mura della città colle pietre dei gradini [148] (del Colosseo) che si trovavano smosse». Questo fatto, il quale trova un fondamento nei danni arrecati all’Anfiteatro dall’ABOMINANDO terremoto di cui parla Venanzio, e nella giusta deduzione che quel magistrato (per lo scarso numero degli abitanti di Roma a quel tempo, e per la mancanza di mezzi proporzionati) abbia restaurato quanto era allora necessario, vale a dire l’arena ed il podio[597]; questo fatto, dico, non può esser avvenuto che nell’ultimo triennio della vita di quel re, fra il 523 ed il 526, dopo la lettera di sopra riferita, nella quale Teodorico mostra la sua ripugnanza per i giuochi sanguinarî ed il desiderio di abolirli. La quale lettera, e specialmente la sua chiusa, dovè persuadere abbastanza il popolo romano del volere del re.
Del completo abbandono dell’Anfiteatro a quel tempo, ce ne fa testimonianza un cimitero cristiano sviluppatosi appunto nei primi decennî del secolo VI a pochi passi del Colosseo, di fronte all’ingresso imperatorio che guarda l’Esquilino[598]. Questo cimitero, da non confondersi coll’altro, più recente, di S. Giacomo, situato a contatto del Colosseo dalla parte del Laterano, e che ha salvato dalla distruzione i cinque cippi terminali dell’area esterna dell’Anfiteatro, venne in luce negli scavi del 1895. Esso si trovava allo stesso livello dell’Anfiteatro, ed avea le tombe coperte con tegole improntate di bolli antichi, in nove delle quali si leggevano marchi dell’età di Teodorico. Una delle tombe, che dall’iscrizione si potè giudicare del secolo VII circa, si rinvenne all’altezza di due metri dall’antico piano dell’Anfiteatro, davanti all’ultimo pilastro orientale del portico, scoperto a piè del colle. Questo cimitero, storico documento, dopo tredici secoli di esistenza scomparve sotto il piccone che sistemava l’attuale via, la quale rasenta il Colosseo.
Lasciato l’Anfiteatro a discrezione del tempo, il primo che dovè risentirne i danni fu senza dubbio il soffitto ligneo del portico superiore, il quale pian piano dovè corrompersi, lasciando libere a sè stesse le colonne che lo sostenevano; e queste, nel violento terremoto che colpì l’Italia nell’aprile dell’anno 801, e recò a Roma danni gravissimi (tra i quali la ruina della basilica di S. Paolo), dovettero precipitare giù per la cavea, e sprofondare nell’ipogeo dell’arena[599]. Dopo questa catastrofe più che mai trovarono alimento alla vegetazione piante ed arbusti, che, come scrisse vivacemente il Tournon: plantant leurs racines dans les interstices des pierres, avaient pris, sur les rampes ruinées, la place des spectateurs: fu questo senza dubbio il colmo della flora del Colosseo!
[149]
Quelle caverne e quelle boscaglie dovettero dare, con ogni verosimiglianza, comodo ricetto ad animali d’ogni sorta, non esclusi i lupi, i quali, come leggesi in una bolla di Paolo II, fin all’anno 1466, ancor s’aggiravan di notte presso la basilica Vaticana in cerca di preda. Corpora fidelium quae humabantur in coemeterio dicti campi (Teutonico) saepe numero reperta fuissent a lupis exhumata.
Finalmente l’Anfiteatro uscì da questo stato di squallido abbandono, entrando in una nuova fase.
Sul finire del secolo XI l’Anfiteatro Flavio subì le medesime vicissitudini che subirono gli altri grandiosi edifici di Roma antica. Gli Orsini occuparono la Mole Adriana — già nel 985[600], stata occupata da Crescenzio Nomentano — per molestare Papa Giovanni XVI; ed il Teatro di Marcello. I Colonnesi presero possesso del Mausoleo d’Augusto e delle Terme di Costantino sul Quirinale; ed il Settizonio di Severo e l’Anfiteatro Flavio vennero occupati dai Frangipani, discendenti della nobile famiglia Anicia, secondo alcuni, od originarî di Cori e discendenti dai de Imperio, de Imperatore, de Imperato, Imperii, secondo altri[601].
E qui cade in acconcio rivolgerci una domanda: fu un utile, ovvero fu un danno per gli antichi monumenti, l’esser passati nelle mani di nobili famiglie romane? — Se consideriamo i pubblici monumenti come cosa che dovea rimanere di pubblico dominio (dei quali, d’altronde, l’autorità legittima in nome e ad utilità del popolo potea disporre); e se osserviamo la cosa sotto l’aspetto che i monumenti, caduti nelle mani dei privati, facilmente possono venir deturpati, modificati, ed anche parzialmente distrutti; non possiamo lodare tali atti d’impadronimento. Ma se si rifletta che soltanto i monumenti posseduti dai nobili; che soltanto i materiali e le decorazioni dei monumenti distrutti, trasferiti nei musei o adoperati in pubblici usi, nelle chiese, ecc., si sono potuti sottrarre ai colpi del piccone demolitore, o agli insulti della barbarie, o alla cieca cupidigia di chi tutto sacrifica al guadagno; se si rifletta, dico, a tutto questo, dovremo riconoscere che per i monumenti non fu un vero danno, ma piuttosto un bene l’esser passati in possesso privato delle nobili famiglie. Che rimarrebbe oggi della tomba di Cecilia Metella, del teatro di Marcello, del Pantheon, ecc., se nella barbara età di mezzo non fossero stati ridotti in fortezze o in case feudali, e l’ultimo in tempio cristiano? La fine di tante statue colonne ed altri marmi, che ornarono tanti magnifici edifizî, non sarebbe stata in una fornace?..... Mi si perdoni questa digressione, e torniamo all’argomento.
[150]
Noi abbiamo notizia di un Benedetto Frangipane, che nel secolo V, essendo Patriarca d’Occidente, ebbe la sua dimora in Trastevere[602], ove possedeva palazzi, case ed il ponte senatorio: e nella bandiera del rione Trastevere campeggia ancora il leone degli Anicî. Sulla pianta del Nolli poi, pubblicata nel 1748, la via che tuttora si chiama ANICIA, viene denominata VIA FRANGIPANE.
I discendenti di questa famiglia emigrarono successivamente in varî luoghi; e quei che rimasero in Roma ebbero il loro centro principale sul Palatino, là proprio dove un tempo dimorarono i Papi, e dove nel secolo IX sorse l’episcopio di Giovanni VIII. Quest’edificio era a poca distanza dell’Arco di Tito; ed appunto fra l’Arco e l’episcopio i Frangipani innalzarono una torre, che i cronisti ricordano come il luogo più sicuro della curia e della cancelleria ecclesiastica: locus tutissimus curiae. Questa torre, detta perciò Chartularia, fu innalzata su i resti di un antico edifizio, e trovavasi a sinistra di chi dal Colosseo s’avanza verso l’Arco di Tito[603].
Oltre alla torre Chartularia, i Frangipani adoperarono a loro fortezze gli archi di Tito e di Costantino. Ma la fortezza principale dei Frangipani era presso il Colosseo; anzi era una parte stessa di questo Anfiteatro, il quale fu posseduto da questa famiglia fin dall’anno 1130; e possedevano inoltre in quel rione due corpi di case. Il primo era sulla piazza di S. Giacomo, il secondo trovavasi presso l’Arco di Tito. Il Papa Innocenzo II[604], a fine di ripararsi dalla fiera persecuzione dell’antipapa Anacleto II[605], si rifugiò nelle fortezze dei Frangipani presso il Colosseo. Il card. d’Aragona, nella vita di quel Pontefice, scrisse: Ad tutas domos Frangipanum de Laterano descendit, et apud S. Mariam novam et Chartulariam atque Colossaeum[606]. Tolomeo Lucchese dice: Recollegit in domibus Frangepaniorum quae in Coliseo erant. F. Tolomeo, vescovo di Torcello, contemporaneo, nella storia del suo tempo[607] scrive che nell’anno 1133 Innocenzo II se recollegit in domibus Frangipanensium, quae erant infra Colisaeum, quia dicta munitio fuit tota eorum. I Frangipani [151] ebbero presso il Colosseo due case. In quale di esse il Pontefice Innocenzo II si ricoverò? Qualche moderno scrittore opina che si ricoverasse in quella del Colosseo, basando la sua opinione sulle riferite parole di Tolomeo Lucchese, e dalla frase infra Colisaeum, usata da altri scrittori. L’Adinolfi è di parere che la parola «infra» possa interpretarsi abbasso od innanzi al Colosseo; sicchè il loro detto poco varrebbe a sciogliere il nodo della questione. Le parole del Lucchese sono più chiare, e sembra indicare la casa che corrispondeva alla piazza di S. Giacomo e che comunicava col Colosseo. Ciò non ostante, conchiude, non è da stimare per certissima, non essendo più case di essi addossate al Colosseo, ma una solamente.
Dalle parole del vescovo di Torcello si deduce che il Colosseo era stato cangiato in vera fortezza (munitio), difesa da genti armate e soldati, e che apparteneva alla famiglia dei Frangipani, quia dicta munitio fuit tota eorum.
La mole resistette agli attacchi della fazione parteggiante per l’antipapa, il quale, furente ed acceso di collera, andò a saccheggiare la Basilica Vaticana, il Patriarchio di S. Maria Maggiore ed altre chiese di Roma, servendosi delle usurpate ricchezze per corrompere i Romani, onde farsi da questi sostenere.
Innocenzo II passò in Francia, e vi si trattenne fino alla morte dell’ex ebreo Anacleto II. Al suo ritorno (il quale avvenne nel 1142), dovè con sommo suo dispiacere, assistere alla cerimonia della ripristinazione del Senato Romano e della Repubblica, la quale occupò il Colosseo e tutte le altre torri e fortezze dei Frangipani, nonchè quelle tenute dagli altri baroni creduti avversi al governo popolare[608].
«Spenta la persecuzione fatta da Pietro di Pier Leone (antipapa Anacleto II), si accese nel popolo romano la brama di ridurre nel proprio dominio Tivoli ed altre città del Lazio. In sulle prime rimasero vincitori i Tivolesi, ma poi ebbero la vittoria i Romani, sicchè quelli domandarono mercè al Pontefice, e l’ottennero. Dispiacque la concessione ai Romani; e, indignatisi contro Innocenzo, posero in vigore l’antico Senato. La famiglia Frangipani, che avea accolto nelle sue fortezze il Pontefice, fu tenuta dal popolo come nemica, e la torre Chartularia ed il Colosseo caddero in sue mani»[609].
Ma la Repubblica e i partiti popolari sono non di rado violente bufere che duran poco. Quando i popoli s’avveggono dell’inganno e del lucroso mestiere dei suoi corifei, dànno un passo indietro e tornano alla calma, tanto loro proficua e necessaria. Pochi anni dopo[610] Alessandro III, veduta in fiamme [152] la chiesa di S. Maria in Torre, e la Basilica di S. Pietro nelle mani di Federico I; e, per le tante insidie tesegli dall’esercito di quest’Imperatore, trovandosi nella dura necessità di abbandonare il palazzo Lateranense; insieme ai cardinali ed ai vescovi discese alle sicure case dei Frangipani presso S. Maria Nuova, la Torre Chartularia ed il Colosseo: e quivi ogni giorno s’adunavano le Congregazioni, si trattavano cause e si davano risposte[611].
«In quell’epoca, dice il Gori[612] il Colosseo divenne la fortezza tutelare della libertà (sic) pontificia»; e dal Panvinio[613] apprendiamo che in quell’epoca «il Colosseo comunicò il suo nome ad una regione di Roma della quale i Frangipani erano i capitani, ed i cui bandonarii precedevano colle insegne il Papa nel dì dell’incoronazione».
Alessandro III scomunicò Federico I, e, forse nell’Agosto del 1167, partì da Roma, per maggior sicurezza, nelle due galere o battelli armati che aveagli mandato sul Tevere il re di Sicilia, Guglielmo[614].
Verso la fine del pontificato d’Innocenzo III (1216), Pietro Annibaldi, nipote per parte di donna del suddetto papa Innocenzo III[615], volle edificare una torre nelle vicinanze dell’Anfiteatro, onde poter attaccare i Frangipani e far loro abbandonare il Colosseo. Le torri degli Annibaldi erano sulla sostruzione del tempio di Venere e Roma, e se ne trova una traccia nella pianta di Leonardo Bufalino.
Ma i Frangipani non rimasero inerti, e dalla torre di Naione[616] e dallo stesso Colosseo procurarono mandare a vuoto il disegno degli Annibaldi. Questi però non si scoraggirono, ed il desiderio d’occupare il Colosseo era il loro sogno dorato[617]; ed ecco che si presenta loro un’occasione propizia. Federico [153] II si porta in Acquapendente: si manifesta persecutore della Chiesa; rompe le relazioni con papa Gregorio IX, e mette in iscompiglio la città di Roma. L’Imperatore ebbe per un momento il sopravvento; e gli Annibaldeschi approfittarono di questa congiuntura per ottenere che Federico II forzasse i Frangipani, Enrico e Giacomo, a ceder loro la metà del Colosseo coll’annesso palazzo, e a sanzionare la cessione con giuramento[618]. Forse sull’altra metà aveva diritto il Senato Romano fin dai tempi di Corrado, allorquando fu violentemente presa; e ciò per porre nelle mani dei suoi favoreggiatori metà dell’ampio edificio.
E per giungere a tale determinazione, debbon esser sopraggiunti dei fatti che noi ignoriamo; poichè Federico II, all’epoca di Gregorio IX, quando era in possesso di quella fortezza, fu da Pietro Frangipane molto ben trattato.
I Frangipani, alla lor volta, reclamarono presso Innocenzo IV, domandandogli l’annullamento di quel trattato. Il papa annuì, e con breve del 18 marzo 1244 dichiarò nulla la cessione del Colosseo, per non essere stata opportunamente chiesta dai Frangipani l’indispensabile facoltà di poter cedere un luogo del quale essi non eran padroni, ma semplici feudatarî del sovrano Pontefice; e dichiarò pur nulla la permuta degli altri beni, perchè fatta non con libertà, ma sotto la violenza e le minacce di Federico II. Ecco il tenore della bolla: «Quum sicut lecta coram nobis vestra petitio continebat, nuper apud Aquapendentem in presentia Principis constituti, eidem ad suam instantiam ipsius timore perterriti, medietatem Colisei cum palatio exteriore sibi adiacente et omnibus iuribus ad ipsam medietatem pertinentibus dilecto filio Anibaldo civi romano titulo pignoris obligata, quae ab Ecclesia Romana tenetis in feudum de facto cum de iure nequiveretis, duxeritis concedenda, praestitis nihilominus iuramentis vos contra concessionem huiusmodi non venturos, licet ex hoc essetis non immerito puniendi, attendentes tamen, quod coacti quodammodo terrore tanti principis id fecistis, concessionem huiusmodi nullam esse penitus nuntiantes praedicta ad vestrum et Ecclesiae Romanae ius et proprietatem auctoritate praedicta revocamus: iuramentis praedictis nihilominus relaxatis, eadem auctoritate excomunicationis vinculo, ac poenae quinque millium marcharum argenti omnes qui contravenire praesumserit supponentes»[619].
Il Sommo Pontefice (per impedire che il Colosseo andasse a cadere nelle mani di Federico II, con grave danno di Roma) dichiarò formalmente esser [154] l’Anfiteatro di diretto dominio della Santa Sede; e per questa pontificia dichiarazione si vennero a far manifeste le differenti opinioni dei varî partiti; poichè alcuni credevano che il Colosseo appartenesse alla Chiesa, mentre altri ritenevano appartenesse all’Imperatore.
Annullato il contratto, gli Annibaldeschi dovettero abbandonare il Colosseo, ove in quel frattempo avevano abitato: Annibaldenses quoque Romani Proceres se munierunt, in Colossaeo, in eoque habitarunt, quemadmodum antea Frangipanes[620]; e i Frangipani tornarono nel loro primitivo possesso.
«E quanto alle abitazioni fatte dai Frangipani entro il Colosseo, si riconoscono fino al presente le muraglie che occupano e dividono fra gli archi esteriori e gli interiori sopra l’antiche scalinate, al numero di 13 verso il Laterano, onde il circuito era molto considerevole, ed è a credersi, che fossero anche similmente chiusi quelli dell’ordine inferiore corrispondenti; ed in effetto nel pavimento dei superiori si scorgono aperture fatte per poter discendere con scale alle parti inferiori; ed anche si veggono nella stessa parte superiore chiusi i pilastri dei due portici nel mezzo, e formano due ambulacri, sino ove tagliato si vede tutto l’ordine dell’elevazione esteriore»[621].
Sul declinare del secolo XIII e sugli esordî del XIV, gli Annibaldi, malgrado la bolla pontificia, approfittando dei torbidi che agitarono Roma, tornarono in possesso del Colosseo. Però nel 1312[622], dopo il solenne banchetto tenuto in Roma dall’Imperatore Enrico VII, il quale era venuto nell’alma Città per ricevere la corona imperiale dai legati spediti da Avignone dal Papa Clemente V, lo stesso Imperatore costrinse gli Annibaldi a rendere alla S. Sede i palazzi e le fortezze delle Milizie, come pure la torre di S. Marco ed il Colosseo: Annibaldumque Militiarum palatia, munitionesque, ac turrim S. Marci et Colisaeum, quorum possessor erat reddere cöegit. «Non è a credere, dice l’Adinolfi[623], che tutto l’edifizio anfiteatrale fosse da questi abitato, benchè molte sue parti fossero state o chiuse o afforzate da loro per guarentirlo dalle parti contrarie all’una od all’altra famiglia. Occuparono fino al secondo piano dell’edifizio»[624].
[155]
Verso la metà del secolo XIV i Frangipani possedevano ancora un palazzo presso il Colosseo. Nell’archivio Lateranense[625] v’è un istrumento in data 22 Ottobre 1238, per il quale Pietro Riccardo Frangipane vendè ad Orso Orsini quartam partem Palatii magni et domorum junctorum Coliseo et prope Coliseum.
I Legati Pontificî posero sotto la giurisdizione del Senato e del Popolo Romano il Colosseo, il quale, come vedremo nel prossimo capitolo, fu nuovamente destinato ai pubblici spettacoli.
[157]
Sotto il pontificato di Clemente V Roma e l’Italia trovavansi travagliate da gravi dissensioni. Il Papa, per riparare a tali mali e per il buon governo dell’una e dell’altra, inviò da Avignone tre Cardinali[626] i quali, come abbiam detto nel passato capitolo, posero sotto la giurisdizione del Senato e del Popolo Romano il Colosseo.
Ludovico Bonconte Monaldeschi, nei suoi Frammenti delle cose accadute dall’anno 1328 sino all’anno 1340, riferisce che il giorno 3 Settembre dell’anno 1332[627] il Senato Romano, in occasione della venuta di Ludovico il Bavaro, volle celebrare nell’Anfiteatro Flavio una caccia di tori. Questo racconto fu criticato e messo in dubbio da Leone Allacci, ma ritenuto come storico dal Muratori, dal Manzi, dal Nibby, dal Visconti, dall’Adinolfi, dal Lanciani, ecc. ed anche dal Gregorovius, il quale nelle due prime edizioni della sua Storia non dubita punto della storicità del fatto, ma poi nella terza e quarta edizione, benchè narri il racconto, nondimeno fa notare che la sorgente di esso porta tutti i caratteri della non autenticità.
Non v’ha dubbio che la Historia Monaldesca contiene parecchie cose che ci autorizzano a dichiararla qual lavoro di un falsario e probabilmente del noto Ceccarelli condannato a morte da Gregorio XIII per aver falsificato, come dice la sentenza, parecchi documenti precipuamente della famiglia Anguillara, ac etiam diversa Imperatorum privilegia, genealogias et historias. Ma il Fumi[628] (sostenitore della falsità della Cronaca e dell’opinione che le assegna per autore il Ceccarelli) scrive: «Egli (il Ceccarelli) razzolò lungamente negli archivî di Orvieto.... ed ebbe agio di consultare cronache e carte di casa Monaldeschi per comporre la sua Historia Monaldesca, dove seppe così bene mescolare [158] cose VERE a cose false, da non poter scorger di leggieri dove l’inganno sia nascosto». Ora, ammettendo quanto il Fumi dichiara, non potremo noi opinare coi succitati autori, che il fatto delle giostre dei tori entri fra le cose VERE inserite nel zibaldone Monaldeschiano? Ed invero, quel racconto nulla ha in sè che lo renda sospetto, anzi trovasi in esso qualcosa che ci autorizza a ritenerlo autentico; ed è, che i nomi proprî dei giostratori son tutti convenienti all’epoca assegnata al fatto, mentre in altri racconti della Cronaca Monaldesca leggiamo, come osserva lo stesso Fumi, nomi classici inusitati fino a tutto il secolo XIV.
Nè ci è lecito dire essere impossibile che una giostra di tori sia avvenuta circa la metà del secolo XIV, perchè non possiamo asserire con certezza che quel giuoco non sia stato assolutamente in uso prima del secolo XV; e quanto io affermo, si deduce pur anche da queste parole dello stesso Fumi: «(la giostra del toro) assai VEROSIMILMENTE introdotta non prima del secolo XV».
Sicchè, seguendo io l’esempio dei suddetti autori, sotto ogni aspetto rispettabili, m’accingo a narrare il fatto. Anzi reputandolo interessantissimo tanto per la storia degli spettacoli celebrati nell’Anfiteatro, quanto per la storia di Roma e delle sue famiglie celebri, lo riproduco letteralmente. Ma siccome il codice donde il Muratori ne estrasse la descrizione è poco corretto, noi trascriviamo il racconto da un codice appartenente al barone P. E. Visconti e da lui stesso pubblicato nel Giornale Arcadico[629]. Anche le annotazioni sono dello stesso ch. Visconti.
«Nello detto anno (1332) si fece il giuoco del toro al coloséo: che avevano raccomodato tutto con ordine di tavoloni[630]. Fu gettato il bando per tutto il contorno, acció ogni barone ci venisse. Racconteró quelli giovani ci furono e chi ci morio[631].
«Questa festa, primieramente fu fatta alli tre di Settembre del detto anno. Tutte le matrone di Roma stavano sopra li balconi foderati di panno rosso. Ci era la bella Savella Orsina con due altre sue parenti. Ci erano le donne Colonnesi; ma la giovane non ci poté venire, perché si era rotto un piede al giardino della torre di Nerone[632]. Ci era la bella Jacopa di Vico, alias Rovere; e tutte menarono le belle donne di Roma. Perché a quella Rovere toccarono [159] le donne di Trastevere; all’Orsina tutte quelle di piazza Navona e di S. Pietro; alla Colonnese tutte le altre che restavano, che arrivavano fino alli Monti e alla piazza Montanara, e a San Girolamo vicino al palazzo Savello. Finalmente, tutte le femmine nobili da una banda e le artigiane dall’altra[633]. Li nobili uomini da una banda: l’altri di mezza mano dall’altra, e li combattenti dall’altra. E furono cavati a sorte dal vecchio Pietro Jacopo Rosso da Sant’Angelo alla pescheria. Il primo cavato fu un forastiere da Rimini, chiamato Galeotto Malatesta[634], che comparse vestito di verde, collo spiedo in mano, e portava alla cappelletta di ferro scritto: SOLO IO COME ORAZIO. Andó incontro al toro, e lo ferì nell’occhio manco; ma il toro diede a fuggire. Allora esso ci dette una botta alla natica; e il toro tirava un calcio al ginocchio, e cascó; e il toro iva correndo ma non lo trovó.
«Uscì allora tutto carrucciato Cecco della Valle, ch’era vestito mezzo bianco e mezzo nero. Il motto che portava al cimiero era: IO SONO ENEA PER LAVINIA. E questo lo fece perché Lavinia si chiamava la figlia di messer Iunevale, ch’esso ne ardeva[635]. Combatteva valorosamente col toro, quando uscí l’altro toro, e così Meco Stallo[636], forzuto giovane, vestito di negro, che gli era morta la mogliera, e diceva il motto: SCONSOLATO VIVO: e si portó bene col toro.
«Uscì Caffarello, giovane sbarbato, che portava il colore del pelo del lione, e diceva suo motto: CHI LO PIÙ FORTE DI ME?
«Uscì un forastiero di Ravenna, figlio di messer Lodovico della Polenta, vestito di rosso e nero, e suo motto diceva: SE MORO ANNEGATO NE LO SANGUE DOLCE MORTE.
«Uscì Savello di Anagni, vestito di giallo, e diceva il suo motto: OGNUNO SI GUARDI DALLA PAZZIA D’AMORE.
«Uscì vestito di cenerino Giovanni Iacopo Capoccio, figlio di Giovanni di Marzio[637], e il motto suo diceva così: SOTTO LA CENERE ARDO.
«Poi uscì Cecco Conti, con un vestito di colore d’argento, e il motto diceva: COSÌ BIANCA HO LA FEDE[638].
[160]
«Uscì Pietro Capoccio, vestito d’incarnato, e suo motto diceva: IO DI LUCREZIA ROMANA SONO LO SCHIAVO. E voleva denotare, ch’era lo schiavo della pudicizia di Lucrezia romana.
«Uscì messer Agapito della Colonna, con un vestito di colore di ferro e certe fiamme di foco, e portava alla cappelletta una colonna. V’era scritto intorno: SE CASCO CASCATE VOI CHE VEDETE[639]. Voleva dire, che la casa Colonna era il sostegno del Campidoglio, e che le altre erano il sostegno del Papa.
«Uscì poi Alderano della Colonna, vestito bianco e verde, e portava una colonna al capo, col motto che diceva: QUANTO PIÙ GRANDE TANTO PIÙ FORTE[640].
«Uscì un altro sbarbatello, figlio di Stefano senatore; si chiamava Cola della Colonna, vestito color pardiglio, e con un motto: MALINCONICO, MA FORTE.
«Uscì un Paparese, vestito a scacchi bianchi e negri, col motto: PER UNA DONNA MATTO.
«Uscì Annibale degli Anniballi, giovanetto di prima barba, con un vestito di color marino e giallo, e suo motto era: CHI NAVIGA PER AMORE S’AMMATTISCE.
«Quel giovanotto di Stalli andava vestito di bianco ma co’ legami rossi: al cimiero il pennacchio col motto: SONO MEZZO PLACATO. E il vicino suo, cioè Iacopo Altieri, era vestito di celeste colle stelle gialle: il motto diceva: TANTO ALTO SI PUOTE. Il motto lo fece uno zio suo letterato, donde cominciò la grandezza di questa casa che aspirava alle stelle, e comprò la casa a Santa Maria de’ Stalli[641] e si chiamava Piazza d’Altieri.
«Uscì Evangelista d’Evangelista de’ Corsi, vestito di color celeste, e portava al cimiero un cane legato, e il motto diceva: LA FEDE MI TIENE E MANTIENE.
«Uscì Iacopo Cencio, con un vestito bianco e lionato, e il motto diceva: BONO COLLI BONI CATTIVO COLLI CATTIVI.
[161]
«Uscì il figlio di Fusco, con un vestito verde e brache bianche[642]: al cimiero v’era una colomba con le fronde d’oliva, e il motto era: SEMPRE PORTO VITTORIA.
«Uscì Franciotto de’ Mareri[643] vestito di verde come la donna smorta, e il motto era: EBBI SPERANZA VIVA QUA MI MUORE.
«E molti altri, che io mi stracco di raccontarli. Tutti assaltarono il toro, e ne rimasero morti diciotto, e nove feriti. Delli tori ne rimasero morti undici. Alli morti si fece grande onore, e ri portarono a seppellire a santa Maria Maggiore e a Santo Giovanni Laterano.
«Camillo Cencio, perchè il nipote ch’era un piccolino, nella folla era cascato, e fattolo cadere il figlio della sorella del conte dell’Anguillara, il Cencio gli diede in capo una stortata, che il povero giovane morse subito.
«La folla fu a santo Giovanni per vedere seppellire i morti al giuoco»[644].
Da questo racconto si deduce che il Colosseo, nei primi decennî del secolo XIV era luogo pubblico, ma già in parte rovinato e mancante di sedili, essendovisi dovuti fare per la descritta circostanza palchi di legno onde far sedere le gentildonne.
Dopo queste feste e deplorabili spettacoli dati nell’Anfiteatro Flavio, non troviamo nella storia che ve ne siano stati posteriormente celebrati altri; e lo stesso monumento non si nomina più nè come fortezza nè come luogo di spettacoli: neppure nell’anno del tribunato di Rienzo, in cui è fatta menzione di tante altre contrade di Roma.
[163]
Dalla fondazione dell’Anfiteatro Flavio alla cessazione dei giuochi, Roma andò soggetta a parecchi terremoti, fra i quali quello ABOMINANDO, ricordato nella lapide di Basilio. L’Anfiteatro, come tutti gli altri edificî, ne risentì gli effetti; ma la sua solida struttura, la forma curvilinea e gli opportuni restauri lo tennero saldo.
Nel lungo periodo di abbandono, dal secolo VI al 1349, oltre alle insidie latenti del lavorìo demolitore delle piante e degli arbusti, o, come dice il chiarissimo Lanciani[645], «le radici delle piante arborescenti, le quali agivano a maniera di cuneo e di leva sull’uno e sull’altro orlo della frattura....», il Colosseo ebbe a subire la violenza di altri non pochi terremoti, e principalmente di quelli avvenuti nei pontificati di Deodato (614-617), di Leone III (795-816), di Leone IV (847-855), di Benedetto IX (1044-1073), di Gregorio VII (1073-1085); ed anche, se si voglia, della brusca impressione dell’incendio di Roberto Guiscardo. Tuttavia fino al 1349 il nostro monumento, sebbene sconquassato, rimaneva integro. Così nel secolo VIII ce lo mostra la notissima profezia di Beda; e se, come alcuni vogliono[646], quella profezia fosse apocrifa (il che vuol dire scritta in epoca posteriore), essa ci renderebbe certi dell’integrità dell’Anfiteatro in tempi ancor posteriori al secolo VIII.
Le contese dei Frangipani e degli Annibaldi (i quali fino al 1312 si disputavano quella colossale fortezza) ci dicono pur esse che a quei tempi il Colosseo era integro, giacchè se la metà circa della muraglia esterna fosse già stata atterrata, non avrebbe certamente fatto gola a quei potenti principotti.
La prima breccia nel recinto dell’Anfiteatro fu aperta dal terremoto del 1349: ce l’assicura il Petrarca nella lettera che egli scrisse al suo Socrate[647], in cui [164] descrisse i gravissimi danni causati da quello scotimento tellurico. Compreso dall’enormità di quel flagello, il Petrarca scrive che dalla fondazione di Roma per il corso di duemila anni non era mai avvenuto un egual cataclisma: ed a prova di ciò soggiunge immediatamente e con slancio oratorio: «Cecidit aedificiorum, veterum neglecta civibus stupenda peregrinis moles; cadde il Colosseo, quella mole, che sembrava dovesse vedere l’ultimo giorno del mondo». Di qui si deduce (ed è comune deduzione degli storici) che il Colosseo, rimasto integro fino al terremoto del 1349, allora per la prima volta cominciò a rovinare.
Che con la parola moles il Petrarca abbia voluto indicare il Colosseo, non se ne può dubitare; ce lo persuade l’espressione enfatica: moles aedificiorum veterum, tra gli antichi edificî la mole per eccellenza. Espressione che farebbe cadere nel ridicolo, come vi cadde il Gori[648], colui il quale volesse intendere per quella parola moles la torre dei Conti, di cui si parla nel periodo che segue. All’epoca del Petrarca la torre dei Conti contava dalla sua fondazione 485 anni, e 135 circa dall’ampliamento fattovi da Innocenzo III, per il quale fu resa toto urbe unica. Ora chi di noi potrebbe, dico, appellare la basilica di S. Pietro (riedificata da Giulio II circa 405 anni fa) moles aedificiorum veterum?
Ciascuno dei due edificî ha inoltre il suo proprio verbo che ne afferma la subìta azione: la moles aedificiorum veterum, CECIDIT; la turris quae Comitum dicebatur, ingentibus rimis laxata, DIFFLVIT.
Finalmente l’avverbio Denique, col quale il Petrarca incomincia il periodo seguente, decide senz’altro la questione. Denique, può ben dirsi dopo il racconto della catastrofe di due o più monumenti; ma non mai dopo il racconto della catastrofe di un solo monumento.
La caduta di una parte del recinto del Colosseo, avvenuta per il terremoto del 1349, è confermata, come giustamente opina il Nibby[649], da due documenti della seconda metà del secolo XIV. Il primo di questi documenti è una lettera colla data del 1362, scritta dal Vescovo di Orvieto (allora Legato Pontificio in Roma) a papa Urbano V. In essa il Vescovo si rammarica di non aver trovato altri compratori delle pietre del Colosseo, da lui messe in vendita, che i Frangipani, i quali ne volevano usare per la fabbrica di un loro [165] palazzo[650]. — Il secondo documento è contemporaneo alla lettera del suddetto Legato Pontificio; e vi troviamo che i capi delle fazioni che allora laceravano Roma, trattarono di dividere fra loro i travertini che si sarebbero scavati dal Colosseo. «Et praeterea si omnes concordarent de faciendo tiburtinam, quod esset commune id quod foderetur[651]».
In questo secondo documento vien confermata più esplicitamente che nel primo, la caduta di una parte del recinto dell’Anfiteatro, già avvenuta agl’inizî della seconda metà del secolo XIV. Leggiamo infatti che i varî partiti si sarebbero divisi il prodotto di un’escavazione e non di una demolizione: quod FODERETUR e non quod DEMOLIRETUR; si trattava adunque di un cumulo di massi caduti, della famosa cosa Colisei.
Il Lanciani[652] crede che per cosa (espressione che troviamo in un documento del «liber brevium Martini V, Eugenii IV et aliorum», e che a suo luogo riporteremo) s’intenda la scarpata, lo sperone prodotto dalla rovina dei due baltei esteriori dalla parte che guarda il Celio. In quanto poi alle cause e al tempo di questa rovina, così parla: «È ignoto quando o come la rovina sia avvenuta, anzi è difficile trovarne una ragione soddisfaciente. La mano dell’uomo nulla ha che fare, in sul principio, con queste contingenze. Guardando il Colosseo dalla parte dell’Oppio, dove si mostra intatto e di robustezza a tutta prova, si escluderà anche il caso di caduta spontanea. Forse la prima origine dei danni rimonta al terremoto del 442, che fece crollare plurimas aedes ed aedificia, e nel Colosseo stesso l’Harena, il Podium, gli SPECTACULI GRADUS, ecc. Supponendo, prosegue, si sia manifestata una fenditura da cielo a terra, come quella che trovasi al dorso del Pantheon dalla parte della via della Palombella, soltanto con maggiore soluzione di continuità perchè si tratta di fabbrica a grossi cubi di travertino e traforata da tre ordini di archi, e da un giro di finestre, il resto è facilmente spiegabile. Una volta rotto l’equilibrio della fabbrica e aperta la via alla caduta dei massi, la rovina doveva fatalmente proseguire, tanto più che le radici delle piante arborescenti agivano a maniera di cuneo e di leva sull’uno e sull’altro orlo della frattura. Questo processo di sgretolamento, lento ma continuo, è illustrato graficamente da tutte le vedute e vignette del Colosseo anteriori agli speroni di Pio VII, di Gregorio XVI, e Pio IX, le quali mostrano i lembi del balteo anteriore fuori di equilibrio ed in pericolo imminente di caduta. Basta poi osservare lo stato della parte costruita da Pio VII verso lo stradone di S. Giovanni per riconoscere che il più lieve scuotimento del suolo ne avrebbe fatto precipitare tre o quattro arcate se non le avessero rette in piedi, a tempo, con potenti incastellature. [166] Le incastellature non poterono essere tolte di posto, ma furono investite dallo sperone di muro: tanto grave sovrastava il pericolo. — I documenti che ho raccolto su questo capitolo della Storia della rovina di Roma provano, che allo sfasciamento, masso per masso, del Colosseo si dovè aggiungere la caduta istantanea di gran parte dei portici australi, la quale produsse una montagna o coscia di pietrame, vera miniera di materiale da costruzione per il giro di quattro secoli.
«La data di quest’avvenimento è stata ristretta fra il secolo VIII (quando il Beda parla ecc.) e l’anno 1386, quando furono dipinti gli stemmi della Compagnia di S. Sanctorum. Ma si può rinchiudere fra limiti più angusti. L’anno 1332 il 3 Settembre fu celebrata la giostra; l’anno 1362, i romani, il legato pontificio, i Frangipani già si bisticciavano de faciendo tiburtinam, con le pietre del Colosseo. La rovina dovrà adunque attribuirsi al terremoto del Petrarca, avvenuto al principio del settembre dell’anno 1349».
Benchè il Colosseo fin dal 1311 non fosse più fortezza, e fosse venuto in possesso del Popolo Romano[653], libero allora di sè stesso per l’assenza dei Papi dimoranti in Avignone; nondimeno non s’ha notizia di asportazioni di travertini del recinto del Colosseo che dopo il 1349. — Nell’intervallo corso tra il 1311 ed il 1349 al più furono liberamente asportati parte dei gradini del Colosseo per adattarli alle case della Città[654].
Essendo dunque il terremoto del 1349 stretto da limiti così vicini, mi sembra non potersi negare aver esso aperto la prima breccia nel recinto del Colosseo.
Durante il tristissimo periodo dell’assenza dei Pontefici da Roma, il Colosseo ed i suoi dintorni addivennero nido di ladri e dimora di malviventi. Il Senato ed il Popolo Romano, tristemente impensieriti, cercavano il modo di far tornare l’antica quiete e libertà in quella parte di Roma. Ma quanto era lodevole il pensiero, altrettanto ne era difficile l’attuazione.
Nondimeno la Compagnia dei nobili romani, detta del Ss.mo Salvatore ad Sancta Sanctorum, ne prese l’impegno; e, mercè la diligente vigilanza dei suoi guardiani, potè snidare dal Colosseo e da’ suoi dintorni quelle bande di malviventi.
In riconoscenza ed in premio di un’opera tanto vantaggiosa per il pubblico bene, il Senato ed il Popolo Romano, nell’anno 1381 concedevano alla Confraternita suddetta ed ai suoi Guardiani l’ius del vero e misto dominio [167] sugli abitanti dell’Arco situato dietro la cappella del Sancta Sanctorum e sui dimoranti nella piazza Lateranense, via S. Clemente e dell’intiero rione Colosseo; donando ad essa in proprietà la terza parte dell’Anfiteatro. Vi fu però una restrizione, e questa riguardava qualche causa di morte la quale era di esclusiva pertinenza e diritto del Senato Romano[655].
Il Bonet ritiene invece che «il Senato di Roma prese questa risoluzione, di cedere cioè una terza parte del Colosseo e farvi un ospedale sotto il nome di S. Giacomo ad Colosseum, del quale parleremo in breve, per il fatto funesto avvenuto nelle giostre del 1332; e perchè i Romani aveano finalmente riconosciuto che quel luogo doveva venerarsi e rispettare perchè santificato dal sangue di tanti martiri cristiani[656]». Se l’arena del Flavio Anfiteatro sia stata o no bagnata dal sangue cristiano, noi lo vedremo nella PARTE IV di questo lavoro.
Il ch.º Adinolfi finalmente dice:[657] «..... la Compagnia del Salvatore fino dal 1366, stando ancora il Papa in Avignone, incominciò ad acquistare quella casa che gli Annibaldensi possedevano al Colosseo. Leggendosi in uno strumento di quell’anno che questa Compagnia comprò una casa che fu di Cola Cecco di Giovanni (degli Annibaldi) nel Coliseo pel prezzo di ducati 30, e che poco prima del trasferimento della Sedia Apostolica da Avignone in Roma, cioè nel 1369, Giovanni ed Andrea degli Annibaldi venderono alla medesima Compagnia l’intera metà della stessa casa, che conteneva sale e camere, posta nel Coliseo, unita con la metà dello spedale della prefata Compagnia ed a cui era innanzi la piazza di S. Giacomo, e negli altri lati era attorneata dall’edifizio del Coliseo pel prezzo di 30 fiorini d’oro[658]. Dal quale istromento conoscesi eziandio la forma di questa casa degli Annibaldensi riguardante colla facciata quella piazza e che per tre lati internavasi nello stesso monumento, non potendosi concepire diversamente la sua positura.
«Dagli acquisti di questa casa e dagli acquisti che avea fatto di altre lungo la via Maggiore che conduce al Colosseo, la stessa Società incominciò ad avere delle ragioni tanto sulla via medesima che su questo orrevole edifizio; e da ciò ne discorse che volgendo il 1386, nell’antico diploma del Senato, trattandosi di quella strada, fosse attribuita alli guardiani della Compagnia del Salvatore la giurisdizione sopra gli abitanti di questa via. E con quelle vendite fatte dagli Annibaldi anche il diritto sulla loro casa si aggiungesse con [168] quello sulla via Maggiore; diritto che venne esaminato meglio nel 1418, quando li guardiani della Compagnia medesima interpretarono, riordinarono ed ampliarono quell’anzidetto diploma del 1386, e determinato più apertamente da una patente spedita molti anni dopo, cioè ai 29 di aprile del 1511, dalla quale senza alcuna dubbiezza sappiamo che il Colosseo per due terze parti appartenesse alla Camera Apostolica in forza di una bolla di Pio P. P. II, e per l’altra terza parte allo spedale del Sancta Sanctorum. Determinazione presa non solamente dietro la padronanza della Compagnia sulla casa degli Annibaldi, ma eziandio perchè godeva altri diritti, siccome quello del dominio di un solio termale o conca esistente dentro il Colosseo lasciatale per donazione fra viventi da Niccolò Valentini del Rione Monti[659], ma anche di una chiesetta nominata di S. Salvatore de Rota Colisei, perchè edificata, per quanto ne è dato risapere, nell’interno circuito dell’Anfiteatro.... Fo poco conto della padronanza che ebbe, oltre alla predetta conca e chiesa di S. Salvatore anche di una grotta detta in pari tempo casa, sulla quale stavano alcuni luoghi acconci alla custodia dello strame che la prefata Società aveva dato ad affitto ad un cotal Paolo di Stefano, correndo gli anni del Signore 1435»[660].
Dal 1386 al 1510, quei capitoli, ordinazioni e privilegi furono costantemente confermati dai Conservatori del Popolo Romano. Dopo quest’ultimo anno il Pontefice avocò a sè tutti i privilegi di vero e misto governo, e commiseli ad ufficiali speciali, investendoli della stessa giurisdizione fino allora avuta dai guardiani della Confraternita. Lasciò nondimeno ad essa la terza parte del Colosseo; e il resto rimase in dominio del Senato Romano[661].
Donata che ebbe il Senato alla Confraternita la terza parte del Colosseo, fu fatto dipingere sull’ingresso che è verso S. Giovanni lo stemma del Senato Romano e quello della Confraternita. Quest’ultimo stemma consiste in un’immagine del Salvatore, su di un altare, fra due candelabri ardenti. Altri stemmi, e in pittura e in iscultura, si posero nel prospetto che guarda S. Gregorio, cioè verso la Mèta sudante: e poichè gli stemmi suddetti si trovano sulle volte della terza arcata, si ritiene generalmente che a quell’epoca le due arcate dei portici anteriori fossero state già demolite.
Che due parti del Colosseo appartenessero in quei tempi al Senato Romano e alla Camera Capitolina, ed una terza parte alla suddetta Confraternita o Arcispedale, si rileva non solo come si disse, da una bolla di Pio II, ma anche da scritture autentiche, esibite dai guardiani della stessa in occasione della vendita di alcune pietre dell’Anfiteatro; nella qual vendita due [169] parti della somma ritratta fu presa dal Senato, ed una parte dall’Arciconfraternita[662].
Il 28 Giugno 1604 la stessa Confraternita donava al Popolo Romano «il prezzo delle pietre impiegate nella fabbricazione del nuovo palazzo Capitolino». Per quest’atto di generosità, i Conservatori di Roma dichiararono novamente che la terza parte del Colosseo era di proprietà dell’Arciconfraternita[663].
[171]
Fra il 1431 ed il 1447 Poggio Fiorentino scriveva il suo trattato De varietate Fortunae. Si narra in esso che a quei tempi il Colosseo vedevasi nella sua maggior parte distrutto; e ciò, Ei dice, a motivo della stoltezza dei Romani: «Atque ob stultitiam Romanorum maiori ex parte ad calcem deletum».
Che all’epoca di quello scrittore (anzi da molto tempo prima) l’Anfiteatro Flavio fosse maiori ex parte ad calcem deletum[664], non ne dubito; ma che la causa di questa parziale distruzione sia stata la stoltezza dei Romani, non posso ammetterlo. La cessazione dei ludi, causa originale dello sfacelo, avvenne forse per la stoltezza dei Romani? I barbari vennero a travagliare ed a impoverire l’Eterna Città per la stoltezza dei Romani? E dei continui terremoti (specialmente di quello del 1349, descritto dal Petrarca) che conquassarono quella mole, ne fu causa la stoltezza dei Romani?
Riteniamo pertanto come positivo il fatto della rovina della maggior parte dell’Anfiteatro al periodo suddetto, ma rigettiamo assolutamente l’accusa lanciata ai Romani da Poggio Fiorentino. È indubitato nondimeno che i Romani (come avrebbero fatto e forse fecero i Fiorentini degli antichi monumenti delle loro contrade; e come facevasi da tutti i popoli di quell’epoca), si servirono [172] dei massi (caduti) del Colosseo. Il fatto è provato da un breve di Eugenio IV, datum Florentiae, e forse motivato dalle lagnanze dello stesso Poggio Fiorentino: lagnanze che riteniamo giuste ma soltanto nel senso dell’asportazione che da parecchi anni andavasi facendo dei massi caduti.
Ridotto l’Anfiteatro Flavio in uno stato tanto deplorevole, le sue rovine addivennero ben presto ricetto di malviventi. Scrive il Vacca[665] che nel 1431 Eugenio IV fece con muri congiungere il Colosseo al monastero di S. Maria Nuova, onde togliere l’occasione del gran male che in quello facevasi.
I monaci Olivetani ne godettero il possesso per molti anni; ma finalmente il Popolo Romano atterrò quei muri, e divise il monumento dal monastero col pretesto che una tale antichità non dovea stare chiusa e nascosta, ma aperta e alla vista di tutti i forestieri[666]. Questo fatto dovette avvenire circa il 1485, come si deduce tanto dalle parole del Vacca (il quale dice che gli Olivetani «dopo la morte di Eugenio», ossia dopo il 1446, lo godettero «per molti anni»), quanto perchè nel 1490[667] s’incominciò a rappresentare nell’Anfiteatro la passione del Gesù Cristo; e quindi era tornato in possesso del Popolo Romano. Dopo i primi crolli della parete esterna del Colosseo, avvenuti (come si disse) con tutta verosimiglianza nel terremoto del Settembre del 1349, le parti adiacenti, come succede sempre negli edifici semidiruti e non opportunamente restaurati, principiarono a sfasciarsi e a gradatamente cadere. Essendo quasi impossibile il ripristinamento, e prevedendosi che i massi di travertino andrebbero a finire, come per il passato, in qualche fornace di calcina; si credè cosa più utile usare i caduti materiali per altre fabbriche. Paolo II (a. 1416-1471) fe’ trasportare una parte di quei travertini, e gli impiegò nella fabbrica del palazzo detto di Venezia, il quale poi addivenne l’abitazione dei Papi. L’Adinolfi[668] dice che in quell’occasione il Pontefice «die’ licenza ad alcuni suoi architetti di poter demolire alquanti archi del Colosseo nella porzione spettante alla Camera, il che die’ motivo alla principale e più grande rovina della fabbrica. Ed in nota aggiunge: «Dico più grande rovina, perchè [173] all’età di Niccolò PP. V alcuni travertini del Colosseo furono adoperati per la fabbrica del palazzo apostolico al Vaticano». Ciò che l’Adinolfi afferma non pare del tutto accettabile. Varî autori, come il Nibby ecc., assicurano che Paolo II approfittò dei travertini caduti; nulla dicono nella demolizione di alquanti archi del Colosseo. Già un secolo circa avanti il pontificato di Paolo II, e molti anni prima del governo di Nicolò V, l’Anfiteatro Flavio trovavasi privo della parte che guarda il Palatino ed il Celio[669]. Il ch. Lanciani, tanto competente in questa materia, sembra essere dello stesso parere, giacchè nel suo pregevole lavoro sulle Iscrizioni dell’Anfiteatro Flavio[670] riporta letteralmente le parole del Marangoni[671], le quali sono del seguente tenore:
✠ S. P. q. R.
«Confermasi ancora che circa la rovina di questi due portici australi del Colosseo, fossero più anticamente di Paolo II atterrati, dal vedersi negli avanzi interiori rimasti in piedi dipinte le armi o stemmi del senato romano e della compagnia nobilissima del SS. Salvatore ad sancta Sanctorum, di rozzissima maniera, e con lettere gotiche espresso il titolo S. P. Q. R. nella targa, e questi, senza dubbio, furono fatti formare circa l’anno 1386, allorchè il Senato medesimo donò la terza parte del Colosseo alla stessa Compagnia.... Che se a quel tempo vi fossero stati i due portici, queste armi sarebbero state dipinte in fronte agli archi esteriori dei medesimi». L’Adinolfi si oppose, come abbiam veduto[672], all’opinione del Marangoni, e ritiene che gli stemmi non siano stati dipinti su gli archi interiori prima del 1418. Io non intendo farmi arbitro di questa questione, ma farò osservare che l’opinione dell’Adinolfi, del resto, non intacca la deduzione del Marangoni; essendochè, dato pure che gli stemmi fossero stati dipinti nel 1418 anzichè nel 1386, resta sempre vero che i due portici australi del Colosseo erano già rovinati anteriormente a Paolo II, e positivamente non meno di quarantasei anni avanti l’elezione di quel Pontefice, la quale avvenne nel 1464. E se anche fosse certo quanto l’Adinolfi afferma[673], io con lui stesso[674], concluderei: «Se molti scrittori incolpano del misfatto il solo Paolo II, io nol discolperò: imperocchè, segue, eglino non avvertono che niuno dei parecchi ARCHITETTI che li servivano osò distorlo, siccome [174] era dovere, di commettere lo sconcio, quando colle loro magistrali ragioni agevolmente avrebbero potuto persuaderlo a desistere di una faccenda assai riprovevole, trattandosi di un bellissimo monumento costruito per giuochi e spettacoli delli quali Paolo era oltremisura compiacente». Mi permetto inoltre aggiungere che se Paolo II avesse realmente data ai suoi architetti quella licenza, potè anche averlo fatto per impedire una rovina maggiore, permettendo di demolire le arcuazioni pericolanti, e lasciando con quel taglio la parete a sperone. Questo pensiero me lo suggerisce il breve di Eugenio IV[675], col quale si proibisce assolutamente «ut et MINIMUS dicti Colisei lapis seu aliorum aedificiorum antiquorum deficiatur»; non potendomi persuadere che un Papa il quale governò un trentennio appena dopo quella saggia disposizione, l’abbia potuto derogare senza un ragionevole e plausibile motivo.
Il Cancellieri (p. 311) dice che lo stesso Pontefice Paolo II fe’ abbellire coi travertini del Colosseo anche la chiesa di S. Marco, contigua al palazzo. Il Vasari, nella vita di Giuliano di Majano[676], aggiunge che una gran quantità di travertini fu scavata da lui stesso in certe vigne vicine all’Arco di Costantino, le quali venivano ad essere contrafforti ai fondamenti del Colosseo.
Nel 1480 il card. Riario approfittò degli stessi caduti travertini per la costruzione della Cancelleria Apostolica; e nel seguente secolo i Farnesi con il materiale dell’Anfiteatro e di altri antichi edifici romani, edificarono pur essi il loro palazzo. Contemporaneamente, nel periodo che corre fra il 1480 ed il 1550, s’abbellirono con quei materiali molti altri edifici romani, non esclusi come si legge nel Ricci[677], i palazzi Senatorio e dei Conservatori di Roma. Più tardi (sec. XVII), furono asportati i travertini di tre archi e mezzo (caduti nel 1644) per l’edificazione del palazzo Barberini[678]. V’ha chi da questi fatti prende pretesto per censurare i Papi; e, travisando la storia, si sforza d’ingannare [175] gli incauti e gli ignoranti, dando loro ad intendere che essi, come tali, fecero abbattere la parte mancante del Colosseo per fabbricar palazzi, ecc. Ciò è assolutamente falso.
Nel capo quarto della Parte II dimostrammo che il Colosseo, sebbene gravemente intronato, rimase sostanzialmente integro fino al terremoto dell’anno 1349. I Papi cominciarono ad adoperare i travertini del Colosseo per altre fabbriche nel principio della seconda metà del secolo XV, quando una buona parte del recinto era da quasi un centinaio d’anni precipitata; talchè sarebbe stoltezza il pensare che essi sperperassero somme considerevoli in demolire, quando una gran parte dei travertini caduti, che avean formato la famosa coxa o cosa Colisei, era ancora a loro disposizione. «La cosa o coscia dell’Anfiteatro, dice il Lanciani[679], continuò a fornire travertini per opere pubbliche fino al principio del secolo decimottavo». Aggiunge che «i documenti da lui raccolti nel capitolo della Storia della rovina di Roma, provano che allo sfasciamento, masso per masso, del Colosseo si deve aggiungere la caduta istantanea di gran parte di portici australi, la quale produsse una montagna o coscia di pietrame, vera miniera di materiali da costruzione per il giro di quattro secoli».
E finalmente: «Nei registri di conti di quei tempi non ho trovato alcun accenno a demolizioni permesse od eseguite: si parla soltanto di concessioni o di spese per cauar asproni o teuertini a Culixeo».
Anzi i Papi s’interessaron sempre di quell’insigne monumento. Trascorso il primo periodo di dieci lustri appena, dopo il ritorno di Gregorio XI da Avignone, periodo di scissioni e di turbolenze, nel quale i Papi avean ben altro a pensare che al Colosseo; trascorso, dico, quel periodo, essi rivolsero tosto le loro cure alla gigantesca opera dei Flavî. Ed ecco che vediamo Eugenio IV, il quale nel suo Pontificato (1431-1447) proibisce con un breve «ut et minimus dicti Colisei lapis seu aliorum aedificiorum antiquorum deiiciatur» arrecandone la ragione: «Nam demoliri Urbis monumenta nihil aliud est quam ipsius Urbis et totius Orbis excellentiam diminuere».
Dal Pontificato di Paolo II (1464) a quello di Giulio III (1550) si pensò al Colosseo, e si disse: o si riedifichi, o l’informe cumulo dei suoi travertini caduti risorga in monumenti novelli, che siano degni della mole che li somministra. Come più ragionevole, si scelse la seconda parte del dilemma, e sorsero i palazzi di Venezia, della Cancelleria e Farnese, ai quali non può certamente dolersi l’Anfiteatro Flavio d’aver ceduto i suoi massi.
La prima parte (riedificazione del Colosseo) che allora parve del tutto inattuabile e certamente inutile non sembrò tale a Sisto V. Quel Pontefice dalle [176] idee gigantesche ordinò al Fontana la ricostruzione del Colosseo; e se fosse vissuto ancora un anno, noi vedremmo oggi intero il grande recinto dell’Anfiteatro: «Vixisset, scrisse il Mabillon, Sixtus V, et Amphitheatrum stupendum illud opus integratum nunc haberemus». E buon davvero sarebbe stato se egli fosse vissuto; giacchè l’immenso vantaggio di veder risorto il maestoso recinto del nostro Anfiteatro avrebbe largamente compensato le interne alterazioni allora ideate; tanto più che non sarebbe stata impresa difficile il purgare poi la cavea da quelle recenti costruzioni.
Dopo la morte di Sisto V il Colosseo rimase abbandonato per due secoli circa. Io non saprei spiegare quest’abbandono, se non come un effetto del gigantesco progetto di Sisto V. I successori di questo gran Pontefice ne rimasero sbalorditi: eseguirlo era un’impresa enorme: dato pure che si volesse, li ratteneva l’idea di deturpare la cavea dell’Anfiteatro; assicurarne le parti fatiscenti con speroni era un troncare per sempre l’attuazione di quel progetto: per circa un secolo si rimase in questa continua incertezza. La mole intanto deperiva gradatamente, richiamando a sè l’attenzione dei Papi; ed ecco che nel 1675 Clemente X ridesta la venerazione dei fedeli per quel luogo consacrato dal sangue dei Martiri, mostrando con tal fatto l’animo di arrestare la rovina di quel monumento. E vi invitava i fedeli a concorrere numerosi; ed avremmo veduti certamente gli effetti di quel desiderio se i provvidi disegni di quel Pontefice non li avesse troncati la morte avvenuta in quello stesso anno.
Trascorsi cinque lustri appena dal Pontificato di Clemente X, il gravissimo terremoto del 1703 fece cadere un’altra parte ancora del Colosseo; e si cominciò a sentire il bisogno di decidersi a qualche cosa, per impedire almeno la totale rovina dell’Anfiteatro. Ne sono prova i progetti, più o meno lodevoli dal lato archeologico, che si venivano elaborando, quale quello dell’architetto Carlo Fontana; e poscia la sistemazione dell’arena e la costruzione delle edicole della Via Crucis, fatta da Benedetto XIV: cose tutte che dovean necessariamente portare, onde evitare gravi disgrazie, il consolidamento delle parti fatiscenti dell’Anfiteatro. Ma nulla si decideva ancora a tal riguardo, sino a che, minacciando imminente rovina la parte del recinto verso il Laterano, Pio VII non frappose più indugio; e non attendendo, saggiamente, all’ostacolo (attuazione del progetto di Sisto V), fece costruire il colossale sperone, opera arditissima ed ammirabile.
D’allora in poi i lavori di consolidamento si proseguirono continuamente. Leone XII consolidò il recinto dal canto del Foro; Gregorio XVI ricostruì le arcate interne verso il Celio; e finalmente Pio IX rafforzò la parte che guarda l’Esquilino. Così per la cura dei Romani Pontefici resterà ai posteri almeno un’imponente reliquia di quello stupendo monumento.
[177]
Ora i Papi, da quarant’anni, non hanno più il dominio di Roma, e quindi non han potuto più manifestare la loro sollecitudine per la conservazione dell’Anfiteatro Flavio. Se ancora avessero dominato, noi forse avremmo veduto l’opera di qualche altro Pontefice spiegarsi a pro di quel monumento, consolidandone l’ultima ala del recinto verso il tempio di Venere e Roma (la quale essendo rimasta troppo isolata, difficilmente potrà resistere ad una forte scossa tellurica), e ricostruendone i muri della cavea fino al piano del portico superiore, come già fece Pio IX quanto alla parte che guarda l’Esquilino.
Troviamo che sulla fine del secolo XV[680] o sul principio del secolo XVI, nel Colosseo si rappresentavano drammi sacri; e questi ci vengono ricordati in varî libri, stampati prima e dopo il cinquecento.
In uno spazio piano, che trovasi sopra gli archi delle antiche scalinate ristretto con un’ala di muro di forma circolare, si costruì una tribuna a guisa di teatro; ed in essa ogni anno, nel giorno del Venerdì Santo, rappresentavasi la Passione di Cristo.
Scelti i personaggi atti all’uopo, tanti di numero quanti ne ricorda il Vangelo, rappresentavano essi ciò che in questo si legge relativamente alla passione e resurrezione del Salvatore. Sulle scene v’erano effigiati i varî luoghi della Palestina, come Gerusalemme, Betania, il Cenacolo, l’orto di Getsemani, le case di Anna, di Caifa e di Erode, il tempio di Gerusalemme, ecc. Le vette dei monti Oliveto e Calvario, l’albero al quale s’impiccò Giuda, e forse il pinnaculum templi erano rappresentati al naturale. Nella scena del pretorio di Pilato eravi il tribunale, ed un seggio che costò 40 ducati.
Nella parte superiore della tribuna eravi una galleria, la quale, dice l’Adinolfi[681] «facea mostra all’occorrenza delle nuvole con angeli[682], quali nubi venivano ad oscurare nella morte del Redentore».
In quella stessa galleria v’era la musica, il coro dei Profeti, quello delle Sibille, nonchè dei pastori e dei re[683]. I fratelli della Compagnia del Gonfalone offrivano volentieri la loro opera, onde costruire i palchi e provvedere il necessario per il buon esito della rappresentazione; e poichè fra loro v’erano abili pittori, architetti, letterati e mimi, ciascun di essi concorreva col suo lavoro personale: così uno dirigeva la costruzione dei palchi, un altro dipingeva [178] le scene; chi componeva i drammi, e chi li recitava. Fra i pittori si ricordano: Iacobello di Antonazzo, Savo, Antonio da Tivoli e Maestro Francesco. Uno dei più valenti compositori di drammi fu Giuliano Dati, fiorentino; e fra gli attori o coloro che nel 1500 recitarono nel Colosseo i suddetti drammi, si conserva memoria di Gregorio orefice, Mazzagattone, Mercurio, Tommaso cartaro[684], Pietro cartaro, Tommaso libraro, Marcantonio di Caravaggio, Michelangelo linaiuolo, il fattore della Compagnia ser Agnolo, Mariotto a S. Pantaleo, Nardino e Marcello, il quale fece la parte di Erode.
Turba immensa di popolo accorreva in quella circostanza al Colosseo; e Pietro Felino Martire, il Panciroli ed altri scrittori ci asseriscono che la quantità di gente uguagliava la quantità degli spettatori dei ludi profani che vi si celebrarono ai tempi degli Imperatori.
Nella biblioteca domestica del marchese Alessandro Capponi il Marangoni[685] vide due esemplari di un opuscolo il quale aveva per titolo: Rappresentazione della Passione del N. S. Jesu Chiesto, la quale si rappresenta il Venerdì Santo nel Coliseo di Roma, nuovamente colle figure ristampata. Questo opuscolo consisteva in un componimento poetico in ottava rima; lo stile ne era rozzo e volgare; gli atti erano intermezzati da arie, che certamente venivano cantate. In ambedue gli esemplari, posseduti dal marchese Capponi, manca l’indicazione del luogo, dell’anno e della tipografia in cui vennero stampati. Nondimeno, noi, dai tipi, dal frontespizio e dalla figura di un angelo che in questo è effigiato, possiamo ragionevolmente dedurre che siano stati stampati a Firenze verso il 1550.
Altri drammi furono scritti dal lodato Giuliano Dati, da Bernardo di maestro Antonio Romano e da Mariano Particoppe. Nell’archivio della Compagnia del Gonfalone se ne conservano tuttora due copie. La prima incomincia: «Contempla la passion del Salvator, ecc.»; e termina con quest’avvertenza: «Seguita poi la Madonna, colla deposizione della croce, la musica di Joseph e Nicodemo, e la musica delle Marie».
La seconda copia è del 1531, e principia: «Quel glorioso Iddio, ecc.».
Poichè descrivemmo i varî ludi celebrati nell’Anfiteatro Flavio ai tempi dell’Impero, e parlammo della caccia dei tori ivi stesso eseguita nel 1332; ci sia pur lecito di dare una notizia sommaria degli attori e delle attrici, nonchè di fare un sunto del più antico dramma sacro, conservato nell’archivio del Gonfalone; dramma che darà al lettore, ne son certo, un’idea chiara del modo con cui si rappresentava nel Colosseo la Passione di Cristo nei secoli XV e XVI.
[179]
I principali attori di questo storico dramma erano:
1. Il Redentore; 2. la Vergine sua Madre; 3. S. Giuseppe; 4. i ss. Padri; 5. gli Apostoli; 6. Simone che invita a cena il Messia; 7. la Maddalena; 8. le tre Marie; 9. la Veronica; 10. Giuda; 11. il Capo de’ Farisei; 12. Caifa; 13. Erode[686]; 14. un Cavaliere con elmo e corazza; 15. i due Ladroni; 16. Lucifero e Satana.
Gli attori secondarî erano:
1. La Vedova di Naim col suo figliuolo difunto; 2. lo Spiritato (sic) condotto da alcuni Pontefici; 3. i Farisei coi loro ministri; 4. un uomo portante un vaso con acqua; 5. gli Angeli; 6. le due ancillae che tentarono Pietro; 7. un individuo rappresentante la Morte, la quale dovrà poi avvicinarsi all’albero donde penderà Giuda; 8. lo storpio; 9. l’adultera; 10. varie Vedove; 11. il Cieco nato; 12. la Cananea; 13. Nicodemo; 14. Giuseppe, amico di Cristo; 15. Beniamino, nemico del Messia; 16. Dottori Ebrei; 17. Farfariello (sic); 18. varî Discepoli; 19. Barabba; 20. il Centurione; 21. il Cirineo; 22. Longino; 23. Giuseppe d’Arimatea.
Non appena gli attori eran pronti per l’esecuzione del dramma, un addetto tirava il tendone, e migliaia di occhi erano fisi allo scenario.
Il dramma che siamo per brevemente riportare, trovasi, come dicemmo, nell’archivio del Gonfalone: esso è intiero, in versi, e consta di sette atti.
Esce per primo il solito nunzio, il quale esordisce ricordando compendiosamente le principali gesta di Cristo, durante gli ultimi tre anni della sua vita mortale. Dopo il prologo incomincia il
Apparisce l’anima (!) di S. Giuseppe, la quale esorta gli spettatori ad ascoltare attentamente quanto si è per dire nel dramma; e conchiude dicendo che ella in quello stesso momento discende al limbo, onde annunziare ai ss. Padri la venuta del Messia e quindi l’imminente loro redenzione.
Ciò detto, muta scena. Appare il limbo: i ss. Padri se ne stanno tranquillamente aspettando Gesù. Dopo un momento questi viene; ed appena i ss. Padri lo veggono, festosi e giulivi intonano ad alta voce il Te Deum.
Lucifero, Satana ed altri spiriti infernali, all’udire il canto di quell’inno, escono precipitosamente dall’inferno..... I primi (Satana e Lucifero) ragionano fra loro, e discutono sul modo migliore d’impedire l’opera redentrice........ La [180] discussione è breve, e tosto credono d’avere trovato il mezzo..... Risolvono di seguir Cristo al deserto..... Vi si portano effettivamente, e, trovatolo orando, lo tentano, gli offrono pane e lo menano sulla sommità del tempio. Coll’infelice esito di tutti gli inutili sforzi infernali, finisce il primo atto[687].
In quell’atto il Redentore richiama a vita il figlio della vedova di Naim. Il miracolo giunge a cognizione di Simone, il quale si fa un dovere d’invitar Cristo alla sua mensa. Quivi la Maddalena unge i piedi del Messia: e Giuda vien preso da ira e sdegno per il balsamo che quella adopera. I Farisei risanno, a lor volta, la guarigione dell’ossesso fatta da Cristo, e lo tentano colla famosa domanda relativa al tributo di Cesare: il Redentore li confonde con sagge risposte: torna poi dalla sua Madre; e coll’ordine che dà ai suoi discepoli di preparare l’ultima cena si dà fine all’atto secondo.
Torna in iscena Giuda, il quale spiega il suo odio contro Cristo: mette in esecuzione il suo tradimento: va alla casa di Caifa, onde accusare il suo Maestro presso quel Pontefice: un servo ne porge avviso a Caifa. Giuda entra nell’appartamento del Pontefice, e dice:
«Padri coscritti, Scribi e Signori,
So ben che tutti siate di buona mente;
Aver seguito Cristo assai mi duole,
Prestando troppa fede a’ sue parole».
Ciò detto, il traditore contratta col Capo dei Farisei la somma da sborsarsi per la consegna della persona di Cristo: stabilisce la maniera onde portare ad esecuzione il suo tradimento, e col mettersi che egli fa in tasca i trenta danari, si chiude il terzo atto.
Giuda, seguito dai Farisei, va in traccia di Cristo. Partiti questi, apparisce nuovamente il Redentore coi suoi discepoli; e, dopo un istante, la sua madre Maria. Gesù domanda ad Essa la benedizione, e le soggiunge che «da [181] Lei convien si parta». A queste parole, la Madonna tramortisce dal dolore; e le tre Marie intonano il canto flebile che incomincia:
«Alta Regina del celeste regno»[688].
Finito questo canto, Maria ricupera i sensi; torna a parlare col Figlio, il quale la benedice e se ne parte; e le tre Marie intonan di nuovo l’inno.
In questo punto l’atto cambia scena.
Si presenta la sala del Cenacolo: v’entra Cristo coi suoi discepoli: celebra l’ultima cena, dirigendo la sua parola ora a Pietro ora a Giuda. Poscia lava i piedi agli Apostoli: torna alla mensa: comunica i discepoli; e, dopo aver rese le dovute grazie all’Eterno Padre per la Pasqua celebrata, prende seco Pietro, Giacomo e Giovanni, e si dirige all’orto di Getsemani. Ivi si svolge quanto leggesi nel Vangelo, e l’atto termina colle parole del Maestro:
«Pietro, nella vagina riponi il coltello;
Chè chi di quel ferisce è a Dio rubello».
Cristo trovasi nella casa del Pontefice Anna, il quale si fa a parlare:
«Rispondi un poco a me, predicatore:
Con qual dottrina al popol hai insegnato?»
Cristo risponde:
«Predicato ho in palese, e ognun ha udito:
E lor ti sapran dir s’io t’ho fallito».
Non appena pronunziate queste parole, un ministro del Pontefice dà uno schiaffo al predicatore della nuova dottrina.
Frattanto Pietro, interrogato dalle ancillae, nega e rinnega di conoscere il suo Maestro: il gallo canta: finalmente Pietro si ravvede, e principia un soliloquio. — Un momento dopo ricambia la scena. Cristo vien condotto da Caifa, dalla casa di Caifa, al Pretorio di Pilato; dal pretorio vien presentato ad Erode, nella cui abitazione si dà principio al
Cristo vien ora accusato e considerato qual seduttore. Il Re gli dirige la parola, ma quegli tace. Allora Erode s’adira; lo fa vestire di bianco, e trattandolo da pazzo, lo rinvia a Pilato. — Vedendo gli Ebrei che quest’ultimo [182] rimaneva perplesso e non avea coraggio di condannarlo, schiamazzando dicono:
«Exaudi Pontio Pilato nostre voci,
Chè costui merta più di mille croci».
A queste parole Pilato si determina di interrogare il popolo se prima della Pasqua vogliono liberare Cristo o Barabba. I Farisei domandano la vita di quest’ultimo. Pilato chiama il Cavaliere, e gli ordina di flagellare Gesù. Il cavaliere compie il mandato; poi s’inginocchia innanzi a Cristo, e gli dice: «O re dei Giudei»: dopo ciò il capo di Gesù vien coronato di spine, e l’afflitto Signore esclama:
«Popolo che di spine m’hai coronato, ecc.»
Dopo ciò viene nuovamente menato innanzi a Pilato, il quale, vedendolo così maltrattato, lo presenta ai Farisei, dice loro: «Perchè volete crucifiggere il vostro re?» I Farisei, maggiormente sdegnati, domandano la morte di Cristo. Pilato si lava le mani, e gli Ebrei gridando dicono:
«Venga, Signor, su’ sangue ed aspri doli
Sopra di noi ed i nostri figliuoli!»
Giuda, dal suo canto, se ne sta triste tra i Farisei: prevede la condanna dell’innocente: proferisce parole di pentimento: restituisce i trenta danari, i quali vengono riposti in corbonam: narra le gesta della sua vita fino a che divenne discepolo di Cristo: chiama la Morte: questa non viene: apparisce invece la Vita, la quale gli favella. Ma Giuda non l’ascolta, dispera e torna a chiamar la Morte. Questa viene, e si dà principio un dialogo fra essa e Giuda: dialogo che si prosegue fino all’impiccagione del traditore. Dopo questo i Farisei dicono a Pilato che se non condanna Gesù sovverte la giustizia. Allora Pilato, vinto dal timore, fa pubblicare la seguente
SENTENZA:
«Noi Pontio Pilato per volontà delli immortali idii e delli romani principi e della senatoria autorità, presidente generale di tutta la Judea costituito, desiderando noi la predicta provincia sotto nostra fede et diligentia assegnata, quella di mali e perversi homini purgare: come allo dovere di un grave judice se conviene: et con ogni forza et industria servendo al suddetto popol romano: et volendo alla perpetua quiete e pace provvedere: essendo menato dinanzi[689] [183] al nostro cospetto Jesu Nazareno e trovandolo uomo seditioso e seduttore, il quale[690] fino al presente confidandosi nella sua temerità: habbia havuto ardire contro il dovere e le imperiali[691] leggi attribuirsi il regnio de’ Judei con denegare il tributo al grande imperatore Cesare Augusto: sedendo adunque per tribunale per questa nostra sententia Jesu Nazareno qui presente come uomo seduttore, factioso[692] et delli buoni[693] costumi et vita e pace insidiatore, giudichiamo[694] et sententiamo esser degno di morte; et acciocchè per suo esempio li altri per avvenire[695] non ardiscano nè presumano far contra le imperiali leggi, et considerando[696] che quelli che vergognosamente[697] et con seditioni et factioni vergognosamente debbano essere puniti: pertanto adunque[698] se ne commette ad voi cavalier di nostra corte che detto Jesu Nazareno come uomo quasi di ladroni et factiosi[699] auctore et principe allo loco solito dello monte calvario menar dobbiate[700] et li tanto in la croce affiso in mezzo a doi ladroni tanto star debba in fin che l’anima dal suo corpo si separi, ad esempio di ogni et qualunque altro seditioso e malfattore contra alle[701] leggi imperiali».
Pubblicata la sentenza, i Farisei ne domandano al Cavaliere l’immediata esecuzione. Cristo vien caricato della croce: intraprende il doloroso viaggio: s’imbatte nella Veronica, la quale gli porge un panno e gli domanda perdono: nel panno resta impressa una figura, che essa mostrandola al popolo, dice essere la figura del volto di Cristo. Giunto al Calvario, il Redentore si rivolge al Padre, e lo prega ad accettare il sacrifizio della sua vita: si distende sulla croce, e così si chiude il sesto atto.
Apparisce l’evangelista Giovanni, il quale, afflitto per la prossima morte del maestro, esclama:
«Ohimè, che gli occhi suoi hanno velato, ecc.»
[184]
Sopravviene la Madonna, e di fronte a quello spettacolo si sviene. Il Cavaliere ordina di alzare la croce; ed il popolo riunito nell’Anfiteatro grida: «Misericordia ecc.». Il Capo de’ Farisei dice: «Eccovi crocifisso il malfattore»: le vesti di Cristo vengono sorteggiate: il Crocifisso prega per i suoi crocifissori. Sulla croce si pone il titolo:
«I . N . R . I»
e i Farisei ripetono a Pilato che il loro re è Cesare Augusto, e non Cristo: Pilato risponde:
«Ciò che scrissi voglio che sia scritto,
Nè vo’ tornare indietro il (col) mio ditto».
Torna la Madonna, la quale dice al Cavaliere:
«O saggio cavalier, in cortesia, ecc.»
ma questo, adirato, risponde:
«Donna, se vuoi onor, non ti accostare, ecc.»;
il Cavaliere se ne parte, e Maria rimane a’ piè della Croce.
Incomincia allora il noto colloquio fra i due ladroni; finito il quale le Marie intonano il flebile canto:
«Maestro caro, vedove ci lasci, ecc.»
La Madonna dice al Figlio:
«Ad un ladron non hai prima parlato, ecc.»
Egli risponde:
«Donna, veggiomi già condotto a morte, ecc.»
E S. Giovanni segue:
«Signor, farò quanto m’hai comandato, ecc.»
Il Crocifisso dice: «Sitio Pater». Il Cavaliere gli nega la bevanda: poi muta consiglio e gli porge aceto e fiele. Cristo lo saporeggia e dice: «Consumatum est».
I Farisei lo dileggiano, lo dicono falso e rio, ecc. La Madonna si lagna colle turbe: Cristo ad alta voce esclama: «Eloi eloi lagma sabactani». I Farisei [185] credono che Ei chiami Elia, e seguono a dileggiarlo. Finalmente, giunto il momento di morire, Cristo si fa a dire:
«Altissimo mio Padre, onnipossente, ecc.»
Compariscono gli Angeli, i quali dicono reverentemente:
«Ecce Agnus Dei».
Longino canta:
«O cieca gente, o popolo perverso, ecc.
Misericordia, o sommo Creatore».
Segue la deposizione di Cristo dalla croce «con la musica di Giuseppe di Arimatea, di Nicodemo e delle Marie».
Fin qui il dramma. Non è nostro compito esaminarlo criticamente. Molte cose dovremmo osservare. Solamente coll’Adinolfi[702] diremo: «Il dramma non è tutto da lodare o degno di biasimo, ma ben poco da mettere in paragone delle antiche, semplici e maestose rappresentazioni anfiteatrali alle quali serviva tutta quanta la natura della costruzione dell’edificio, e che secondo la costumanza discesa dal greco teatro aveano nell’arenario le scene fisse ed in pieno, e non dipinte sulla tela, e ciò sia detto rispetto alla forma esteriore della tragedia o rappresentazione, che non recava noia alcuna con la lunga partizione degli atti, compatibile solamente nella storica tragedia, contenente talvolta l’intiera vita di un personaggio».
Le spese che importavano simili rappresentazioni, variavano secondo la maggiore o minore grandiosità degli scenari, palchi ecc., e la magnificenza nell’esecuzione. Nè mancarono persone pie le quali offrissero talvolta denaro a questo scopo; e nel libro Decretorum[703], leggiamo: «che si faccia la devozione della Passione nel Colosseo, essendo persona che per esse offerisce 60 ducati, acciò non si perda la detta devozione».
Il dramma da noi compendiato e già esposto, fu recitato nell’Anfiteatro Flavio fino al 1522. Il 23 Marzo dello stesso anno i fratelli della Compagnia ne sospesero l’esecuzione, pubblicando il seguente decreto:
«Non si faccia, conforme era solito, la rappresentazione della Passione nel Colosseo, attento periculo ob delationem armorum, cum esset difficile sine scandalo transire posse»[704].
[186]
A me sembra di vedere la causa di questo decreto nello stato turbolento in cui trovavasi Roma in quell’anno; giorni orribili, in cui la brutalità, i furti e gli omicidi dei soldati Còrsi, come pure la lotta di Renzo di Ceri coll’esercito dei Fiorentini e dei Sanesi, obbligavano i Romani a star continuamente in armi.
(In questo stesso tempo accadde un fatto, che non posso tralasciar di riferire, perchè avvenuto nel Colosseo. Un tal Demetrio greco percorse le vie della città con un toro da lui ammansito, come egli diceva, con arti magiche; e lo condusse al Colosseo per ivi sacrificarlo secondo il rito antico e a fine di placare i demoni avversi!)[705].
Nell’anno 1525 il surriferito decreto fu annullato, e si ordinò che si ripristinassero le rappresentazioni[706]: «Fu proposto che per fare la rappresentazione del Colosseo, secondo il disegno fatto, vi sarebbero occorsi di spesa almeno 250 ducati; e fu risoluto che per essere l’Anno Santo si faccia con ogni onorificenza».
Il 30 Luglio dell’anno 1525 fu stabilito che le sopraddette «rappresentazioni avessero luogo di quattro in quattro anni, onde evitare spese gravi»[707].
Nel 1531 si pensò a restaurare il palco, rimasto danneggiato nel sacco di Roma (a. 1527); e si stabilì che annualmente si spendessero 20 ducati allo scopo di «conservarlo e risarcirlo»[708].
Nel 1539 nel Colosseo ebbe nuovamente luogo la rappresentazione della Passione[709]; ma nel seguente anno (1540) cessò probabilmente quell’uso. Gli scrittori medioevali ed il Panciroli ci dicono infatti che quei drammi furono aboliti dal Pontefice Paolo III, il quale, malgrado tutte le pratiche fatte dal popolo onde perpetuare quella devozione, ne negò il permesso[710].
Leggiamo nel libro Decretorum della Compagnia del Gonfalone: «Anno 1517, che si faccia la cappella nel Colosseo e vi si spendano 30 ducati di oro di Camera»[711]. Questa deliberazione fu presa dietro il consenso di Raffaele De’ Casali e di Luigi De’ Mattuzzi, guardiani dell’Ospedale del Salvatore. Il [187] progetto però non si eseguì che nel 1519. Nello stesso libro Decretorum[712] si legge: «1519, 6 Febbr. Che si faccia la cappella nel Colosseo». Allora i guardiani dell’Ospedale del Salvatore rinnovarono il loro consenso, e permisero alla Compagnia del Salvatore di poter cavare qualche pietra di travertino per fare alcuni cunei e porte della stessa cappella, e questo fu il sacello detto di S. Maria della Pietà.
Come risulta dalle date, la cappella venne fatta quando ancora nel Colosseo si eseguivano le rappresentazioni della Passione del Salvatore; poichè una di queste ve ne fu, come già dicemmo, nel 1519[713], e non cessarono che nel 1540.
Cessati i sacri drammi nell’Anfiteatro, il palco scenico rimase abbandonato, come pure abbandonato dovè rimanere l’intero edificio; giacchè, non molti anni dopo, si giunse a tal eccesso da farlo divenire campo di stregonerie notturne; ed il Cellini racconta nella sua vita che una notte egli stesso vi assistette.
La cappella della Pietà cadde pur essa in oblio, e vi rimase per settanta anni circa: fino a che, nel 1622, l’Arciconfraternita del Gonfalone risolvè ripararla e ridonarla al culto. Vi aggiunse essa alcune stanze per un custode, e nell’alto del piccolo edificio collocò una campana. La chiesuola fu consacrata da Mons. Giulio Sansedonio, già vescovo di Grosseto[714]. A memoria del restauro, si pose la seguente iscrizione:
ARCHICONFRATERNITAS GONFALONIS
SACELLVM . HOC . IN . COLISEO . POSITVM . SVB
INVOCATIONE . BEATAE . MARIAE . PIETATIS
VETVSTATE . DIRVTVM . ET . COLLABENS . NE
TANTA . PIETAS. OBLIVIONI . TRADERETVR . IN
MELIOREM . FORMAM . RESTITVI . ATQVE . OR-
NARI . MANDAVIT . A . D . MDCXXII . PET . DONA-
TO . CAESIO . CVRTIO . SERGARDIO . MARIO
Q . AVRELII . MATTAEI . MAXIMO . Q . HORATII
MAXIMI . CVSTODIBVS . ET . M . ANT . PORTA
CAMERARIO .
Nell’opera del Fontana[715] sul Colosseo vi è una veduta dell’interno dell’Anfiteatro qual’era agl’inizi del secolo XVIII. In essa si vede la cappella suddetta [188] col suo piccolo campanile e l’abitazione del custode; dinanzi alla porta si scorge eretta una croce.
Questa interessante veduta ci fa conoscere il sito preciso ove sorgeva la cappella di S. Maria della Pietà: essa sorgeva presso la porta libitinense, ricavata nei vani sotto la gradinata del podio, ed ove si dispiegava il palco delle rappresentazioni della Passione, della quale si distinguono gli avanzi. Ma poichè la cappella rappresentata in quella veduta supera il piano del palco scenico, e non potendosi ammettere che quello sconcio sia stato fatto all’epoca delle rappresentazioni, dovrà dedursi che le stanze (delle quali si veggono due finestre sulla porta del sacello) siano state aggiunte nel restauro del 1622, e che prima del restauro la cappella fosse intieramente sotto il palco delle rappresentazioni.
Il ch. Armellini dice che la cappella di S. Maria della Pietà servì anteriormente da guardaroba della Compagnia che rappresentava la passione di N. S. Gesù Cristo. L’Adinolfi opina che il sacello della Pietà fosse la chiesuola di S. Salvatore de Rota Colisaei. A me sembra che ambedue abbiano ragione, e che un’opinione non escluda l’altra. L’Adinolfi fa derivare la denominazione Rota Colisaei dall’arena dell’Anfiteatro; l’Armellini dalla vasca rotonda della Mèta Sudante. Più giusta tuttavia sembra essere l’opinione dell’Adinolfi, poichè presso la Mèta Sudante v’era una chiesa dedicata a Maria SS. detta De Metrio: denominazione che lo stesso Armellini giudica «una corruttela della parola de Meta». Laonde farebbe mestieri ammettere che la Mèta Sudante fosse chiamata contemporaneamente con due nomi: cosa non facile a dimostrarsi. Che per Rota Colisaei s’intendesse invece l’arena, mi pare potersi dedurre da quel che si legge nel Catasto dei beni della Compagnia del Salvatore[716]. Troviamo infatti che nella Ruota del Coliseo, poco lungi dalla chiesa di S. Salvatore, eravi una grotta, detta anche casa, forno e luogo da conservare erbe secche. Ora, attorno all’arena si può assai bene trovare il posto per questa grotta; ma attorno alla vasca della Mèta Sudante no davvero!
Che poi su questa chiesina si fosse potuto stendere il palco scenico, e far divenire essa stessa la guardaroba della Compagnia, si può argomentare dal fatto dell’abbandono in cui cadde il detto sacello nel periodo che córse fra il pontificato di Pio II e quello d’Innocenzo VIII; abbandono reso manifesto dal decreto di Pio II, col quale egli toglieva le rendite alla chiesuola di S. Salvatore de Rota Colisei e le donava a S. Eustachio.
Nè fa ostacolo la diversità del titolo della cappella, detta prima di S. Salvatore e poi di S. Maria della Pietà, giacchè questa diversità è più apparente che reale.
[189]
La cappella fu sempre dedicata al Salvatore: probabilmente nella sua primitiva erezione (perchè più conveniente all’epoca — che io ritengo antichissima — come ora procurerò di dimostrare) vi si dipinse il Salvatore crocifisso con la Vergine a piè della croce.
Questa pietosa scena potè benissimo essere rappresentata tra il VI ed il VII secolo, e a quei tempi faccio io risalire l’origine di quella cappella. Nè mancano esempî, ed uno ne abbiamo d’epoca più antica ancora, nella scatola d’avorio, cioè, che si custodisce nel Museo britannico, e che, come dice il Kaufmann, ragionevolmente possiamo dire opera del secolo V. Nei restauri posteriori vi si potè esprimere la morte del Salvatore ed il tenero dolore della Vergine più pietosamente ancora, dipingendovi, cioè, il corpo del Salvatore deposto dalla croce e giacente sulle ginocchia della sua SS. Madre: gruppo chiamato per antonomasia la pietà. Poste queste considerazioni, le due denominazioni si fondono in una. Non mi pare fuor di proposito ricordare qui quanto scrisse il Martinelli nella sua Roma ex etnica sacra[717]: «S. Salvatoris de Pietate in Campo Martio intra monasterium S. Mariae. Antiqua Urbis mirabilia referunt hic fuisse imaginem Salvatoris quae dicebatur Pietas».
Alcuni vogliono che detta cappella si fosse appellata pur anche S. Maria de Stara. Basano il loro asserto sul Registro dei possedimenti della Basilica Lateranense[718], nel quale è menzionata la chiesuola con questo nome. Io congetturo che questa denominazione non sia altro che una piccola variante del titolo della cappella, chiamandola, cioè, «S. Maria de Salvatore;» e che trovandosi questo secondo nome scritto abbreviato «S. Maria de Store» (e forse malamente scritto), abbia potuto originarsi il titolo di S. Maria de Stara.
Comunque sia è certo che l’origine di questo sacello eretto nell’interno dell’Anfiteatro Flavio dovè essere antichissima. Prima che il papa Giovanni XXII istituisse l’Arciconfraternita del Salvatore, detta di Sancta Sanctorum (a. 1332), quella cappella già esisteva. È ricordata durante il pontificato di Bonifacio VIII (1294-1303) nel registro dei possedimenti della Basilica Lateranense; ed un secolo innanzi (1192) la troviamo nominata nel libro «De Censibus» di Cencio Camerario: «S. Salvatori de Rota Colisei VI den».
Io non conosco dati più antichi: forse ricerche accurate potrebbero somministrarli. Tuttavia, l’esser certo che l’arena dell’Anfiteatro Flavio, fu bagnata dal sangue dei Martiri[719], e lo esistere un cimitero cristiano addossato all’Anfiteatro fra il VI e il VII secolo, appunto in quella parte ove internamente sorgeva la cappella del Salvatore; ed il veder questa cappella ricavata in uno [190] dei fornici del piano terreno presso l’arena, e quindi allo stesso livello del cimitero suddetto, (livello che nell’alto medio evo andò gradatamente sollevandosi, come risultò dagli scavi del 1895)[720]; ed il trovarla finalmente registrata tra i possedimenti dell’Arcibasilica Papale, tutto ciò mi fa ragionevolmente opinare che, cessati del tutto i ludi fra il VI ed il VII secolo, presso l’arena del Flavio Anfiteatro, in prossimità della porta libitinense, donde uscirono trionfanti le spoglie insanguinate dei Martiri, si dedicasse un sacello al Re dei Martiri. E questo fu probabilmente il nucleo del cimitero, la cui necessaria esistenza fu giustamente accennata dal ch. P. Grisar[721].
Nella sua primitiva origine, probabilmente s’accedeva alla cappella dalla parte del cimitero e non dell’arena, perchè a quei tempi il muro del podio non poteva essere ancora distrutto; più tardi vi si accedette dalla parte interna: e questo fino a che rimase in essere il palco delle rappresentazioni della Passione, sotto il quale trovavasi la cappella. La porta perciò, che vediamo nella tavola del Fontana, e che dà sull’arena, fu aperta nel restauro del 1622; e ciò vien confermato nel permesso, dato dai guardiani dell’Arciconfraternita del Salvatore, di poter cavare qualche travertino per far cunei e per le porte.
Lo studio di questa cappella, che può dirsi il centro della sacra zona formata dalle chiese che attorniarono l’Anfiteatro Flavio, ci ha condotto a riconoscere, con grandissima probabilità, la massima antichità possibile della venerazione verso quel luogo consacrato dal sangue dei martiri; venerazione che i moderni ipercritici[722] vorrebbero far credere un parto del pietoso zelo di Clemente X e di Benedetto XIV. Almeno dicessero col Grisar[723]: «Furono i secoli decimo settimo e decimo ottavo che per primi (?) cercarono di AVVIVARE il ricordo dei martiri della fede cristiana fra queste solenni ruine!»
Fuori dell’Anfiteatro, dalla parte che guarda verso la via dei Santi Quattro, vi era una piazza chiamata di S. Giacomo, a causa di una chiesa ivi prossima dedicata a questo santo: «S. Giacomo de Coloseo». Ecco le parole colle quali il Mellini[724] tratta di questo sacello: «Vicino al Colosseo si vede un fenile il quale era prima la chiesa di S. Giacomo detta de Colosseo profanata quasi ai nostri giorni. A questa chiesa la vigilia dell’Assunta s’incontravano il clero lateranense e gli ufficiali del popolo romano, e quivi si risolveva il modo di fare la processione dell’immagine del Salvatore....» Era [191] adorna di pitture, che furono copiate da Ferdinando Baudard e poi dal Guattani. Fra quelle v’era una figura colossale di S. Giacomo apostolo sedente, col bordone e un libro nelle mani[725].
Ivi sorgeva eziandio la casa dei Frangipani, la quale poi venne in dominio degli Annibaldi. Relativamente alle case degli Annibaldi de Coliseo, che dalla piazza di S. Giacomo corrispondevano entro l’Anfiteatro Flavio, ci rimangono le seguenti notizie:
Nel 1365 l’ospedale del Ss.mo Salvatore comperò per trenta ducati la metà di una casa appartenente a Cola di Cecco di Giovanni Annibaldi. «Questa casa, dice l’Adinolfi[726], era o per se sola congiunta all’Anfiteatro Flavio, o con altri suoi membri entrava perfin nel medesimo, giacchè contenendo delle sale e delle camere, allorquando Giovanni di Branca e Mario Sebastiani, guardiani della Compagnia del Gonfalone ebbero ottenuto da Innocenzo Papa VIII la licenza di poter rappresentare entro il Colosseo la sacra ed istorica tragedia della passione di nostro Signore, addimandarono questa casa alli guardiani dello spedale suddetto Ludovico de’ Margani ed Alto de Nigris, e assentendo anche i conservatori di Roma per questo unico e devoto fine glie la concedettero».
Nel 1462 la parte della casa che guardava la piazza di S. Giacomo, era diruta; la parte invece che internavasi nel Colosseo, era ancora in buono stato di conservazione[727].
[192]
La suddetta chiesa di S. Giacomo de Coliseo profanata e ridotta a fienile, come dice il Mellini e come pur si ricava dal Martinelli[728], il quale scrive: S. Iacobi apud Colosseum erat ibi ubi est foenile cum imagine B. Mariae V. in eius angulo; habebatque hospitale, quod ad Lateranum traslatum est, et nunc dicitur ad Sancta Santorum, venne finalmente abbattuta nel 1815.
Il Marangoni[729] aggiunge che l’amministrazione e la cura di questa chiesa e di questo ospedale l’ebbe l’Arciconfraternita de’ Raccomandati del Ssmo Salvatore ad Sancta Sanctorum fino all’anno 1470. Lo deduce dagli statuti rinnovati in quell’anno e confermati nel 1513, nei quali i guardiani dell’Arciconfraternita s’obbligavano, sub juramento, di visitare una o due volte alla settimana quell’ospedale. Lo stesso autore[730] assicura di aver letto, ma non ricorda dove, che l’ospedale trovavasi negli archi superiori dell’Anfiteatro, [193] già chiusi dai Frangipani. «In effetto, dice, tutti i sei archi chiusi della elevazione esteriore, sono anche murati al di dentro fra i pilastri del secondo portico, sicchè formansi e si dividono due lunghi corridoi quanti portano i sei archi, luogo attissimo per l’ospedale».
Il celebre letterato Francesco Valesio, senza però accennare alle fonti, comunicò ad alcuni suoi amici che nei suddetti archi chiusi del Colosseo vi era anticamente un monastero di monache[731].
Questo stesso asserisce il Bonet. Noi riportiamo la notizia soltanto in ossequio alla ch. memoria del suddetto Valesio, ma siamo affatto incerti della verità di essa.
L’Adinolfi[732] combatte energicamente queste opinioni. «È veramente triviale (dice), e non pertanto meno curiosa l’opinione del Marangoni, che la Società del Salvatore avesse governo non pur di questo tempietto ma eziandio dello spedale che li era ammesso fra gli archi stessi del Colosseo, il quale spedale dopo molti anni fusse trasportato al Laterano ove esiste; e dell’istessa natura è quella di Francesco Valesio quando pretende nell’Anfiteatro Flavio anticamente venisse aperto un monastero di monache. Rincrescendomi d’involgermi in certe quistioni tra perchè la brevità del lavoro le rifiuta, e perchè si concerta con scrittori di molto credito, non posso nondimeno tralasciarle per la loro necessità e pel superchio rispetto all’altrui sentenza, sapendo per prova che tutti gli uomini qualche fiata rimangono in inganno.
«A me dunque, che posi in disamina l’archivio della detta compagnia anche coll’intendimento di veder meglio questa materia, pare la cosa assai diversa e massime per due ragioni. La prima è che nell’archivio suddetto non trovi menzionato alcun luogo dell’Anfiteatro rivolto all’uno e all’altro uso. La seconda che questi pareri discendono dalla falsa congiunzione di due idee, tra loro ben distinte. Nel trovar scritto spedale e monistero del Colisseo s’intesero due fabbriche non già vicine ma entro quella orrevole dell’Anfiteatro Flavio. Ora partendo da un principio stabile e certo dirò che avanti e alquanto dopo il mille come è sconosciuta la chiesa di S. Giacomo, così al pari il suo spedale di donne, l’edificamento del quale non sembra più antico di quello di S. Angelo, ma piuttosto da esso originato, ed a lui assoggettato e dipendente[733]. Per avventura venne aperto dai Raccomandati per maggior [194] comodo degli infermi[734], come meno lontana dalla parte più popolata di Roma, e prova ne sia fra le altre quella, che, ingrandito lo spedale al Laterano non fu chiuso nè quello, nè l’altro assai più picciolo di S. Pietro e Marcellino chiamato lo spedaletto, ma tutti e tre correndo gli anni di Cristo 1383, a benefizio del comune ricettavano malati[735].... Ma siccome lo spedale.... fu aperto principalmente per donne[736], che ebbero bisogno nelle loro malattie di essere servite da altre femmine, queste incominciarono prima a nominarsi offerte, e costrette da necessità a dimorare e convivere in quel luogo, tennero vita a seconda di qualche regola; da queste dunque o da altre povere donne ivi raccolte, o come par meglio, e dalle una e dalle altre, venne a formarsi una di quelle devote unioni ne’ secoli di mezzo appellate case sante.
«Le abitazioni di cotali donne, conchiude l’Adinolfi, erano contigue alla chiesa di S. Giacomo che col suo spedale dispiccato dal Colosseo erano separate affatto da questo edifizio. Conciossiacchè venendo ampliamente dai guardiani Bernardo de’ Ricci e Paluzzo di Giovanni Mattei negli anni cristiani 1472, costoro chiesero licenza ai maestri delle strade di chiudere un luogo intraposto a quella chiesa e ad alcune possessioni dello spedale[737], ed in questa concessione per verun modo si fa ricordanza di quell’edifizio del Colosseo, nel quale secondo Valesio, era contenuto il loro monastero».
***
Oltre alla chiesa di S. Giacomo de Coliseo, erano molto prossime all’Anfiteatro Flavio altre chiese, delle quali oggi non rimane alcun vestigio.
«Nell’andar direttamente per la via Maggiore seguitava, dopo il titolo Clementino, la favolosa casa di Giovanni Papa VII; e verso l’Anfiteatro Flavio per lo meno quattro altre chiesette»[738].
Il Lanciani[739] opina, e saggiamente, malgrado l’ipercritica dei moderni Bollandisti[740], che nelle vicinanze del Colosseo, oltre a varie cappelle vi [195] fossero pur’anche sette chiese. L’opinione dell’illustre archeologo vien confermata dalle scoperte e dai documenti; le prime ci hanno rivelato la esistenza di alcuni oratorî o cappelle nelle vicinanze del Colosseo; i secondi ci hanno conservato memoria di almeno otto chiese in quel dintorno.
Fra gli oratorî che circondavano il Colosseo, merita il posto d’onore quello sacro a S. Felicita, martire romana, ed ai suoi figli. Quest’oratorio fu scoperto nel 1812.
Il primo a parlarne fu il Morcelli nel 1812, poi il Piale nel 1817; anche il Mai più volte nei suoi scritti parla di quest’oratorio; e poscia il Canova, il Nibby, il Garrucci, il De Rossi, l’Armellini, il Marucchi, il Grisar, ecc. Non è questo il luogo di descrivere ed illustrare quell’antichissimo oratorio: tanto più che le sue pitture e le scoperte ivi fatte sono state già illustrate e pubblicate da molti scrittori. Solo mi sia permesso intrattenermi alquanto sul motivo della erezione di un oratorio sacro a S. Felicita, celeberrima martire romana, in questo luogo; motivo che ha dato occasione a varie congetture.
Il De Rossi[741] propose la congettura che qui fosse la casa del marito di Felicita, di nome Alessandro; argomentando l’ignoto nome del marito da quello di uno dei figli, chiamato appunto Alessandro: e ciò lo ricava dalla greca iscrizione a graffito in una parete laterale della stanza, dove, nonostante l’incertezza della lettura, quello che al ch. archeologo sembra certo è, che vi si legga: «Alexandri olim domus erat».
Il Grisar[742], benchè dica che in mancanza di sorgenti non ci è permesso sciogliere la questione, pure a lui sembra che l’affermativa spiegherebbe meglio la venerazione delle dame Romane per questo santuario: venerazione, che viene espressa in un graffito del muro. Questa congettura però, a mio modo di vedere, incontra non poche difficoltà; e tralasciatane per brevità ogni altra, è certo che qui non potè essere la casa di una nobile matrona, quale fu Felicita, nè del suo marito, nobile anch’esso; perchè non può dubitarsi essere quest’oratorio parte dei sotterranei delle Terme di Traiano, che altro non sono se non gli avanzi della casa aurea di Nerone[743].
Altri congetturano che questo sia il luogo immediato ove la Santa ed i figli furono trattenuti per esser da quello condotti al martirio. Ma anche quest’opinione incontra difficoltà. Se la sepoltura di Felicita e dei figli fosse stata fatta sulla via Labicana o sulla Latina, non si avrebbe tanta difficoltà ad accettare il parere di quegli scrittori. Ma è certo che la sepoltura di Felicita e di sei dei suoi figli fu sulla via Salaria, e quella di Gennaro sull’Appia. Sembra adunque troppo lontano il luogo della esecuzione della sentenza capitale [196] (che l’esperienza insegna prossimo al luogo della sepoltura) da quello ove quei Santi sarebbero stati detenuti per esser condotti al martirio.
Altri opinano finalmente che questo luogo fosse la custodia privata, ove la Santa ed i figli furono trattenuti nel tempo del processo. Ma gli atti c’indicano il luogo preciso ove il processo si svolse, e questo è il Foro di Marte: «Postera namque die, dicono gli atti, Publius sedit in Foro Martis et iussit eam adduci», e dopo essa ad uno ad uno i figli. La distanza del luogo di cui si parla dal Foro di Marte fa abbandonar la proposta congettura, senza notare che, come ogni Foro ebbe la sua privata custodia, così l’ebbe pur anche il Foro di Marte.
In questo stato di cose, sia lecito anche a me proporre una congettura, che ricavo dalle circostanze di luogo, di tempo e di costumi.
È certo che all’Anfiteatro Flavio furono non poche volte condotti i rei per esser puniti, e che anche i cristiani[744] furono là condotti, e non di rado, più per provare la loro costanza nella Fede ed indurli a rinnegarla, che per ultimo supplicio[745].
È certo eziandio che prossimo all’Anfiteatro vi dovè essere un luogo di custodia per i rei destinati a subire il supplicio nell’arena dell’Anfiteatro stesso. Ora quell’oratorio così prossimo all’Anfiteatro, nei sotterranei delle Terme, sulla strada che menava all’Anfiteatro[746], e precisamente da quella parte ove trovasi la porta Libitinense, per la quale s’introducevano i rei nell’arena, non può negarsi essere stato luogo molto adatto allo scopo. E che questo fosse veramente un luogo di custodia, lo dimostra, come nota il De Rossi[747], la pittura stessa della Martire, ove le due figure effigiate in proporzioni piccole per rispetto ai Santi, sono di carcerieri «Clavicularius carceris».
Posto ciò, non sarebbe, credo, azzardato il supporre che S. Felicita e figli fossero ivi condotti per esser poi presentati alle belve nell’Anfiteatro, almeno a provare ancora una volta la loro costanza. S. Felicita fu martire nel principio dell’impero di Marco Aurelio, quando, cioè, la plebe gridava: «Christianos ad leones!». Dopo la morte di Antonino le incursioni barbariche minacciavano l’Impero; il Tevere uscì dal suo letto, e recò gravissimi danni; Roma era in preda alla fame; la peste poco dopo devastò regioni: conveniva cercar vittime a placar l’ira degli dèi; e queste vittime furono i Cristiani. Era il grido del momento: «Christianos ad leones!»[748]. Felicita ed i figli furono tra le vittime designate.
[197]
È vero che gli atti tacciano su ciò; ma conviene osservare che questi atti sono brevissimi e semplicissimi. Essi altro non ci ricordano che l’esame e la morte dei Santi; e se questo episodio dell’Anfiteatro non lo ricordano, fu forse perchè non ebbe seguito. Dico forse non ebbe seguito, giacchè le Matrone Romane perorarono presso l’Imperatore per la loro compagna, matrona anch’essa «Inlustris»; e l’Imperatore M. Aurelio che, al dire di Dione[749], di Capitolino[750] e di Erodiano[751], aveva orrore per i ludi cruenti dell’Anfiteatro, accolse la domanda; e Felicita ed i figli furono liberati da questa prova. La scritta che leggesi sul capo di Felicita nel dipinto del nostro oratorio: «Felicitas cultrix Romanarum (matronarum)», come tutti convengono, ce ne è una conferma. Quel cultrix, numero singolare, non si può riferire alle matrone, come senza badarvi si è fatto; perchè queste sono in numero plurale. Il Garrucci vide la difficoltà, e riferì quel cultrix ad una qualunque Felicitas, devota della Santa omonima; costretto però ad aggiungervi: «votum solvit», che non gli appartiene, come anche notò il De Rossi. Secondo la mia opinione, quel cultrix esprime la gratitudine di S. Felicita verso le Matrone Romane.
Sennonchè, come nota l’Allard[752], l’Imperatore, di fronte alla grande agitazione popolare causata dal terrore superstizioso, liberando Felicita ed i figli dalle zanne dei leoni, non potè a meno di rassicurar la plebe, ordinando che il sangue destinato a placare l’ira degli dèi, invece che nell’Anfiteatro fosse sparso in punti diversi di Roma. «Leur immolation, scrisse l’Allard[753] parlando dell’iscrizione trovata nel 1732 nel cimitero di Processo e Martiniano, POSTERA DIE MARTVRORVM, eut quelque chose d’exceptionnel: ils furent les martyrs proprement dits, c’est-a-dire les victimes choisies entre tous les chrétiens pour être sacrifiées à la colère des dieux, un jour où le fanatisme, la superstition, la peur, voulurent à tout prix arroser d’un sang illustre divers points de la ville de Rome».
Il De Rossi[754] scrive che il graffito greco, ricordante un Alexandri δόμος, era scritto sull’intonaco primitivo anteriormente alle pitture cristiane; e che nel medesimo intonaco si leggevano pure in graffito: «Achillis vivas» ed altri nomi, come: «Cassidi, Maxi..., Saeculari....»; e sotto: «in de», che il De Rossi lesse: «in Deo». Da questo Egli dedusse che nei graffiti del primo intonaco si ha indizio del culto del luogo, anteriore alle pitture cristiane. E giustamente; [198] poichè tutti sanno che la parola domus nel linguaggio cristiano ordinariamente significa oratorio, e le acclamazioni Vivas in Deo sono cristiane.
Conchiudo:
Fra gli oratori che circondavano il Colosseo, quello sacro a S. Felicita è il più antico; e se (come assai bene lo dimostrò il De Rossi) le pitture cristiane, rappresentanti la nostra Santa e i suoi figli, non sono posteriori alla metà del secolo V (443), ed il culto di quel luogo è anteriore alle pitture, dobbiam conchiudere che l’oratorio di S. Felicita e figli risale al IV secolo dell’êra volgare.
E bene a ragione fu esso il primo; giacchè quel luogo era, come si disse, la custodia per coloro che dovean essere esposti alle fiere nell’Anfiteatro: supplizio che subirono non pochi cristiani. Difatti noi troviamo qui una domus Alexandri; ed il vescovo Alessandro, sepolto ad Baccanas, fu (secondo gli atti interpolati bensì ma in sostanza veritieri)[755] esposto alle fiere nell’Anfiteatro; e così, chi sa che anche i nomi di Achille, Cassidio, Massimo e Secolare, uniti a quelle cristiane acclamazioni, non siano anch’essi, nomi di Cristiani damnati ad bestias nel Colosseo?....
Un altro oratorio fu scoperto negli scavi del 1895, fra residui di fabbriche antiche, presso la nuova via dei Serpenti. Riporterò le parole del ch. Gatti, che allora descrisse la scoperta[756]. «Sopra un muro curvilineo che trovasi alla distanza di m. 44 del Colosseo in corrispondenza delle arcate XXXXIIII e XXXXV, e costituiva l’abside di una piccola chiesa, si conserva la parte destra di una pittura a fresco, onde quella parte era decorata. Nel mezzo della composizione era rappresentata una figura seduta su ricco trono marmoreo, certamente la Vergine Maria col Bambino Gesù nel seno. Non ne rimane che una piccola parte della veste, e la fiancata sinistra del trono; il quale apparisce adorno di musaici, secondo lo stile così detto cosmatesco. Genuflessa al lato del trono medesimo è una piccola figura colle braccia sollevate in atto di preghiera. Ha il capo tonsurato, e veste una casula di color rosso puro. È il ritratto di colui che fece eseguire la pittura ad ornamento dell’oratorio. Segue l’imagine poco minore del vero, di un santo barbato, in piedi, con tunica di color cenere, stretta alla vita con una correggia di cuoio, e con corto mantello rossastro. L’abito è monastico; ed è probabile che in questa figura sia effigiato S. Benedetto. Ad essa doveva corrispondere un’altra simile figura dal lato destro del trono, ove siede la Vergine. Il dipinto è contornato da riquadrature [199] in rosso: sulla fascia inferiore si veggono tracce di scrittura, con lettere di color bianco. La composizione e lo stile del dipinto sembrano doversi attribuire al secolo XIII o XIV.
«Nel campo della pittura si leggono i seguenti nomi di visitatori graffiti con una punta:
Il Lanciani, pur dubitando, opina che questi avanzi di oratorio si debbano attribuire alla chiesa di S. Maria de Ferrariis[757]; ma questa chiesa, come vedremo quando di essa si parlerà, per documenti certi conviene collocarla altrove. E poi, essendo la composizione e lo stile del dipinto del secolo XIII o XIV, e non esistendo altri documenti che dimostrino la preesistenza della chiesa (come tale) alle pitture suddette, l’opinante ben fece a dubitare di quella congettura. È dunque per me un incerto oratorio. La pittura è stata trasportata al Museo Nazionale.
Le chiese poi più vicine all’Anfiteatro Flavio, delle quali si ha memoria, sono:
I moderni Bollandisti[758] saltano a piè pari la questione intorno a queste chiese, che, come vedremo, sono certamente esistite nelle vicinanze del Colosseo; come pure tacciono degli oratorî, dei quali parlammo di sopra, benchè quando essi scrissero fossero già scoperti. Rivolgono le loro armi contro S. Salvatore in Ludo od in Tellure, e, contro S. Maria de arcu aureo, che nulla hanno a vedere col Colosseo; e, costretti a parlare della chiesa dei Ss. Abdon [200] e Sennen, e non potendone negare resistenza, conchiudono con un «il est probable» che la lettura degli atti abbia suggerito l’idea di erigere una chiesa in loro onore in questo luogo.
Del resto, la esistenza di queste otto chiese e di questi oratorî attorno al Colosseo serve a dimostrare la venerazione che, da secoli e secoli, prima dell’epoca fissata dai Bollandisti per il culto di questo monumento — secolo XVII — era prestata all’Anfiteatro, benchè le chiese e gli oratorî niuna relazione diretta avessero coi martiri che in esso patirono: giacchè appunto attorno a centri indubitabili di grande venerazione noi vediamo verificarsi il fatto dell’aggruppamento di chiese ed oratorî di vario titolo; come, ad esempio, attorno alle basiliche Lateranense e Vaticana, ed a quella Apostolorum sulla Via Appia. Anzi questo fatto non solo si è verificato attorno a luoghi sacri fin dalla loro origine, ma eziandio attorno a monumenti destinati per loro natura ad uso profano, e divenuti poscia venerabili, presso i cristiani, per qualche motivo speciale. Così attorno al grandioso edifizio delle Terme di Diocleziano, sorsero le chiese di S. Salvatore in Thermis, dei Ss. Papia e Mauro, e l’oratorio cristiano scoperto nel 1876 sul Monte della Giustizia (ove è ora la dogana); e ciò, perchè gli altissimi muri di quella immensa mole erano stati cementati, dirò così, dal venerando sudore di migliaia di confessori della fede.
Cinque furono in Roma le chiese sacre ai Quaranta Martiri di Sebaste. Presso la chiesa di S. Maria Antiqua, scoperta a’ nostri giorni, v’ha una cappella che il Wilpert considera come faciente parte della chiesa stessa, per essere a questa assai vicina[760]. Nell’abside di questa cappella sono dipinti i Ss. Quaranta Martiri; e la pittura è giudicata dallo stesso ch.º autore[761] non posteriore al secolo VII. Nella stessa cappella Adriano I fece dipingere nel secolo seguente gli stessi Santi in gloria.
Altra chiesa dedicata a questi Martiri fu sull’Esquilino, e propriamente al Castro Pretorio. — Una terza ve n’era a breve distanza dal luogo ove ora è la chiesa delle Stimmate, e si disse Ss. Quadraginta de Calcarario, e poi de Leis. Un’altra ve ne fu, e v’è tuttora, nel Trastevere, e finalmente viene la nostra. Da quest’elenco mi sembra potersi ricavare l’origine e la posizione della nostra chiesa.
[201]
I Quaranta Martiri furono soldati, e noi troviamo che le chiese ricordate sono presso le caserme militari. La cappella di S. Maria antiqua fu eretta per la Coorte Palatina; la chiesa dell’Esquilino, per i soldati Pretoriani; quella di Trastevere, nella celebre Urbs Ravennatium, per i marinaî di Ravenna, quella situata a pochi passi dal luogo ove ora sorge la chiesa delle Stimmate, per i militi dei Castra dedicati da Aureliano in Campo Agrippae[762]. La nostra dunque, [202] per i marinai di Miseno. Questo quanto all’origine: quanto alla posizione poi, il quartiere dei marinai di Miseno fu tra S. Clemente ed il Colosseo; ivi dunque dovremmo collocare la chiesa. E così è di fatto.
[203]
Il Lonigo la dice posta «lì attorno al Colosseo», fra la chiesa di S. Giacomo e quella di S. Clemente. Dalla bolla di Eugenio IV[763], per la quale questa chiesa e l’altra di S. Maria furono unite all’ospedale di S. Giacomo, risulta, [204] che era prossima a questo ospedale: «Sanctorum Quadraginta.... nec non S. Mariae prope dictum hospitale consistentes». Nel Catasto dei beni dell’ospedale di Sancta Sanctorum del 1462[764] si legge: «Item ecclesia Sanctorum Quadraginta prope dictam ecclesiam (di S. Giacomo) que remansit unita hospitali post cessum et recessum domi Johannis de Cancellariis». Ora il fabbricato della chiesa e dell’ospedale di S. Giacomo si estendeva fino al principio della via di San Giovanni. Qui dunque fu la chiesa dei Ss. Quaranta: vale a dire, di fronte al quartiere dei Misenati.
Questa chiesa alla metà del secolo XV era in istato di totale deperimento, e lo ricavo dalla citata bolla d’Eugenio IV (1433), nella quale, parlandosi delle due chiese, di S. Maria de Ferrariis e dei Ss. Quadraginta, leggiamo: «Etiam ruine deformitati supposite et fere prorsus destructa». Però sotto il Pontificato di Pio IV (1559-1565) esisteva ancora perchè è ricordata nel catalogo delle chiese, redatto sotto questo Pontefice. L’Adinolfi[765] opina che «vivo Sisto IV fosse fatto titolo di Cardinale ed avesselo Pietro Foscari; e Pontefice Alessandro VI il Cardinale Domenico Grimano e mantennesi tale trapassata anche l’età fra li due». Che questa chiesa esistesse, trapassata anche l’età fra li due, è certo; perchè, come ho detto, si trova ricordata nel catalogo di Pio IV; ma che fosse elevata a Titolo ed assegnata ai Cardinali Foscari prima e poi Grimano, non so come l’Adinolfi l’abbia potuto affermare: sappiamo infatti che i due Cardinali suddetti ebbero a titolo S. Nicolò de Colosso o Colisaei, che è lo stesso che S. Nicolo inter imagines[766]. Dalla seconda metà del secolo XVI in poi, non si ha più memoria di questa chiesa[767].
Parlando dell’oratorio scoperto negli scavi del 1895, dissi esservi alcuni i quali opinano, pur dubitando, che la chiesa di S. Maria de Ferrariis fosse situata nel luogo di quel rinvenimento. Non ci è possibile accettare la loro [205] opinione, giacchè la posizione di questa chiesa viene esattamente indicata dall’Ordo Romanus di Cencio Camerario[768], e dalla bolla di Eugenio IV, più volte ricordata. Nel primo si legge: «Et dehinc usque ad S. Nicolaum de Colosseo,.... deinde usque ad domum Johannis Papae VII.... deinde usque ad angulum Sancti Clementis». — Nella seconda, come già vedemmo, è scritto: «Nec non S. Marie prope dictum hospitale S. Jacobi consistentis». La chiesa di S. Maria de Ferrariis era dunque situata presso l’ospedale di S. Giacomo, il quale terminava al principio della via attuale di S. Giovanni; era prima della casa della favolosa Papessa Giovanna[769], che trovavasi, per chi va al Laterano, prima di S. Clemente; era a sinistra della via suddetta, perchè ricordata con fabbriche che sono da questa parte: in conclusione la chiesa di S. Maria de Ferrariis era situata al principio della moderna via di S. Giovanni, e a sinistra di chi va al Laterano.
Il Lonigo la pone fra S. Giacomo e S. Clemente.
La chiesa di cui parliamo è ricordata nel Catalogo del Camerario, nel Codice di Torino e nel Catalogo del Signorili; poi scomparisce.
Di questa chiesa già s’è parlato abbastanza: solamente qui aggiungerò che negli scavi del 1895 venne a luce il cimitero dipendente da questa chiesa. Ecco le parole che scrisse il ch.º Lanciani all’epoca della scoperta: «Sembra che questo sepolcreto dipendente dalla chiesa ed ospedale di S. Giacomo del Colosseo si estendesse per considerevole spazio, almeno sino al n. 2 in via di S. Giovanni, dinanzi al quale, il giorno 5 aprile, si trovarono altri avelli addossati a muri di bella cortina[770]. Stavano a soli due metri di profondità». In nota poi aggiunge: «Una parte delle fondamenta della chiesa di S. Giacomo è stata troncata dagli odierni scavi: e corrisponde nei particolari architettonici al prezioso disegno dell’anonimo di Stuttgart f. 88, n. 237[771]. Ad essa ed al camposanto si deve la conservazione dei cippi che chiudevano il marciapiede e balteo del Colosseo, largo ben diecisette metri e mezzo».
Questa chiesa è ricordata dal Camerario col nome di «Salvatoris Insule et Colosei»; nel Codice di Torino è detta: «S. Salvatoris de Insula, habet 1. sacerdotem»; e così pure vien chiamata nel Catalogo del Signorili.
[206]
L’Armellini[772] dice che non si trova altra menzione di essa, e la crede addossata all’Anfiteatro: «Tracce infatti (egli scrive) di costruzione del medio evo restano ancora presso uno degli archi del medesimo, dal canto della via che conduce alla basilica Lateranense». Io però non posso convenire col ch.º scrittore: l’aggiunto «Insule» del Camerario, e il «de Insula» del Codice di Torino esclude l’idea di un addossamento della chiesa ad un edifizio. O fu dunque la chiesa medesima per se isolata, e quindi «Insule» o «de Insula»; ovvero fu inchiusa in uno di quei fabbricati, che, per essere affittato a più famiglie nell’antichità, e forse anche nell’età di mezzo, eran detti Insulae.
Con tal titolo è ricordata questa chiesa nel Codice di Torino; il Signorili poi la dice: «ad Arcum Trasi». Non può cader dubbio sulla posizione di questa chiesa: essa fu presso l’Arco di Costantino, se non forse a questo addossata. L’anonimo Magliabecchiano[773] dice: «Arcus triumphalis marmoreus qui dicitur de Trasi coram colosso in via per quam itur ad sanctum Gregorium, fuit factus Costantino... et dicitur de Trasi quia in transitu viae est». Nella Mesticanza di Paolo Liello Petnene[774] si legge: «Voglio scrivere la vita di alcuno vostro Romano, a quali si vorria fare un simil arco trionfale, che fu fatto a Costantino... il quale si chiama Arco de Trasi appresso a Coliseo». Poggio Bracciolini, nella sua silloge, scrive: «De arcu Costantini, qui hodie dicitur de Traxo».
L’Armellini, piuttosto che dal transito sotto ai fornici dell’Arco, opina si debba derivare il vocabolo Trasi dalle statue dei Traci che ne adornano l’attico[775].
La memoria di questa chiesa scomparse dopo il secolo XV.
La chiesa di S. Nicolò, scrive l’Adinolfi[776], dicesi da qualche moderno «esser stata demolita ed essere stata nell’aia sulla quale è un locale, forse fabbrica dell’Arciconfraternita di Sancta Sanctorum, lasciando sospesa la curiosità del ricercatore di essa se questo locale stesse a destra o a sinistra della via Maggiore». Però Cencio Camerario, nel ricordare i luoghi ove si facevano gli archi sotto ai quali passava il Papa nella solennità del presbiterio, c’indica [207] il sito ove sorgeva questa chiesa. Dice infatti: «Et dehinc usque ad S. Nicolaum de Colisaeo.... deinde usque ad S. Mariam de Ferrariis.... deinde usque ad domum Johannis Papae VII.... deinde usque ad angulum Sancti Clementis»[777]. La chiesa di S. Nicolò stava dunque prima di quella di S. Maria de Ferrariis; ed essendo, per quel che si è detto sopra, noto il posto di quest’ultima chiesa, potremo con facilità stabilire il sito della chiesa di S. Nicolò. Questa fu certamente vicina al Colosseo, da cui tolse il nome; e perciò la collocherei a sinistra della via attuale del Colosseo, dove verso il Laterano ha termine l’edificio dell’Anfiteatro. Qui infatti, negli scavi del 1895, si rinvenne un lungo tratto di strada medievale, la quale, come nota il Gatti, era la via per cui si passava nelle solenni processioni papali, e dove appunto si facevano gli archi ricordati dal Camerario.
In questo luogo stesso e negli stessi scavi praticati nel 1895 si rinvenne un grande masso rettangolare di travertino, sul quale era in parte conservato l’intonaco primitivo dipinto. «Lo stile dell’affresco, scrive il Gatti[778] conviene al secolo VIII in circa. Vi sono rappresentati due santi, in piedi col nimbo circolare attorno al capo, vestiti di lunga tunica adorna di croci quadrilatere, e coperti col pallio. Ambedue tengono la mano destra sollevata all’altezza del petto; e mentre la figura a dritta sostiene una corona, l’altro regge un libro aperto, sul quale è scritto:
INITIV SAPIENTI.......
«Si volle ripetere la sentenza: Initium sapientiae, timor Domini; mancato però lo spazio per le ultime parole, queste furono rappresentate con piccole linee ondulate. La pittura è molto deperita; e verso ambedue i margini laterali della pietra manca quasi la metà delle due figure. In mezzo a queste è dipinta, nascente dal terreno, una pianta con fiori simili a rose».
Questa scoperta mi sembra sia una conferma della mia supposizione: che qui, cioè, fosse la chiesa di S. Nicolò de Colisaeo. Fu chiesa titolare; ed i due Cardinali Foscari e Grimano (i quali furono insigniti di questo titolo) ce ne sono la prova.
L’Armellini[779] afferma che questa chiesa era ancora in piedi sotto S. Pio V.
Il Camerario, il Codice di Torino ed il Signorili ricordano questa chiesa; ma dal secolo XVI in poi non se ne ha più memoria. Il Codice di Torino la [208] chiama «Sellaria de Metrio»; in una bolla di Urbano V è detta S. Maria de Metrio[780]. I topografi non hanno saputo indicare il luogo preciso di questa chiesa, e vi fu chi la collocò lontanissimo dal Colosseo; il Codice di Torino però ce ne dà l’indicazione precisa, e la pone fra S. Salvatore de Arcu Trasi e la chiesa dei Ss. Abdon e Sennen. Ora, conoscendosi il sito preciso della prima — Arco di Costantino — e dell’ultima — Colosso di Nerone, — è chiaro che S. Maria de Metrio fu alla Mèta Sudante o lì presso; e la voce Metrio (corruzione evidente di Mèta) ce ne è la conferma.
Questa chiesa fu eretta sul luogo ove furono gettate, dopo il martirio, le salme dei gloriosi Martiri Persiani: vale a dire, ante simulacrum Solis, ossia davanti al famoso Colosso Neroniano. Difatti, tra il basamento del Colosso ed il tempio di Venere e Roma, al cadere del secolo scorso, si trovò una gran quantità di ossa umane, le quali vengono a dimostrarci la presenza di un cimitero svoltosi attorno a questa chiesa. Essa è ricordata dal Camerario, dal Codice di Torino (il quale, come dicemmo, la nomina dopo la chiesa di S. Maria de Metrio), dal catalogo del Signorili e da quello di Pio V, ritrovato dall’Armellini negli archivi secreti del Vaticano. Da questo catalogo egli argomenta, e giustamente, che la nostra chiesa durante il pontificato di Pio V non solo era intatta, ma vi si compievano ancora gli atti di culto; poichè l’estensore del suddetto catalogo nota esattamente lo stato materiale di ciascuna chiesa, e di quella dei Ss. Abdon e Sennen nulla osserva[781]. Lo stesso chiarissimo scrittore la suppone distrutta alla fine del secolo XVI o sugli inizî del XVII secolo.
Ed ora, chiusa questa lunga parentesi, alla quale mi hanno condotto le questioni sulle chiese di S. Salvatore de Rota e S. Giacomo, torniamo all’argomento.
I Pontefici, nel prender possesso della loro suprema dignità colla famosa e solenne cavalcata alla basilica Lateranense, solevano ascendere il Campidoglio; poscia, attraversato il Foro, passavano innanzi il Colosseo, e proseguivano per la via che conduce al Laterano. Gli Ebrei erano in dovere di preparare i soliti apparati e di ornare la strada dall’Arco di Tito fino all’Anfiteatro. S. Pio V, nel possesso che prese il 23 Gennaio 1566, volle, con tutta la cavalcata, passare per entro lo stesso Colosseo, come pure fece nella sua presa di possesso Gregorio XIII[782].
[209]
Nel libro dei decreti del 1574 si trova il seguente decreto del Consiglio secreto del 15 Ottobre (f. 548):
«Giovanni Battista Cecchini primo Conservatore propose: Perchè tutte le opere cominciate deuono hauere il suo debito fine, però ce par necessario che mancando ancora molta quantità di Trauertini per finire la restaurazione del Ponte Santa Maria, et per adesso non se ne possono far venire et per questo essendone detto che nel Coliseo ue ne è gran quantità sotto le ruine dò sonno cascati et non sono in opera quali si potrebbero far cauare per questo bisogno. Però l’habbiamo uoluto esporre alle S.S. V.V. acciò possino sopra di ciò fare quelle risoluzioni che gli parrà».
«Decretum extitit omnium Patrum astantium assensu quod capiantur et fodiantur expensis Po. Ro. omnes lapides mormorei et Tiburtini existentes in ruinis amphitheatri Domitiani vulgo detto il Coliseo, diruti et nullo pacto coniuncti et applicati dicto Amphitheatro, sed etiam effodi possint in omnibus aliis locis publicis pro supplemento operis Pontis Sanctae Mariae sine tamen praeiudicio aedificiorum antiquorum pro quibus exequendis curam habere debeat magister Mathaeus architectus. Quoque omnes statuae et antiquitates quae in dictis locis reperiantur sint ipsius Populi romani».
Il Sommo Pontefice Sisto V, fu uno dei Papi che più ricordi lasciò nell’alma Città. «Costruì più Egli solo in cinque anni di pontificato, dice giustamente il prof. R. Corsetti[783], che in più secoli la maggior parte dei suoi successori» — Poteva dunque l’operosissimo Sisto V trascurare l’Anfiteatro Flavio? Non era possibile: egli pensò ben tosto di far ivi grandiosi lavori, onde conservarlo e renderlo nuovamente, in pari tempo, di pubblica utilità; benchè con non lieve danno dell’integrità archeologica di quelle monumentali reliquie, se tali lavori fossero stati eseguiti.
Ai tempi di Sisto V molti poveri di Roma non avean modo di vivere colle loro fatiche: il lavoro scarseggiava; ed il provvido Pontefice escogitò la maniera di sovvenire agli indigenti ed evitare che andassero mendicando per la Città. Sul finire del secolo XVI, Sisto V dava incarico a Domenico Fontana, perchè riducesse il Colosseo ad abitazione e lanificio; giacchè l’arte di lavorare la lana era allora in Roma molto negletta. Il suddetto architetto fece il disegno dell’edificio restituito nella sua originaria circonferenza: quattro porte od ingressi con altrettante scale immettevano al monumento. Nel mezzo dell’antica arena dovea sorgere una fonte: altre fonti dovean servire per il lavoro; e per le abitazioni degli operai si destinavano i portici esterni, dando a ciascuno di quelli, gratuitamente, due stanze. Gli altri portici dovean adattarsi [210] a stanze e a laboratorî. Già erasi intrapreso il lavoro: i commercianti di lana avevano già ricevuto da Sisto V la somma di 15,000 scudi per la provvista della materia da lavorarsi nel nuovo lanificio; quando la morte del Pontefice venne a troncare l’attuazione di quell’opera[784]. «Se vivea un altr’anno solo, dice il Fontana, il progetto sarebbe stato una realtà, con immensa utilità pubblica e specialmente dei poveri». E il Mabillon[785] aggiunge: «Vixisset Syxtus V et amphitheatrum, stupendum illud opus, integratum nunc haberemus!» — Ma ascoltiamo le parole dello stesso Fontana[786]: «Acciò, iui si facesse l’arte della lana, per utile della città di Roma, volendo che á torno per la parte di dentro al piano di terra vi fossero le loggie couerte, et disopra scouerte, con le botteghe, e stanze per abitatione per li lavoratori di detta arte, e che ogn’vno dovesse hauer vna bottegha con due camere e loggia scouerta avanti à torno tutto il teatro, hauendo già dato ad alcuni mercatanti scudi quindicimila acciò cominciassero ad introdur detta arte, volendoci di più far condurre l’acqua per far fontane per comodità di detta arte et per vso degli habitatori, e di già haueua cominciato a far leuare tutta la terra che ni staua à torno et a spianar la strada che viene da torre de Conti, et và al Coliseo, acciò fosse tutta piana, come hoggi dì si vedono li vestigj di detto cauamento, et vi si lauoraua con sessanta carrette di caualli, et con cento huomini, di modo che se il Pontefice uiueva anco un anno, il Coliseo sarìa stato ridotto in habitatione. La qual opera si faceva principalmente da N. S. acciò tutti li poveri di Roma hauessero hauuto da trauagliare, et da viuere senza andare per le strade mendicando; poi che non aueriano pagato pigione alcuna di casa qual voleva fosse franca, il saria stato di grand’vtile alla pouertà, et anco ai mercatanti di lana, che haueriano smaltita la loro mercatantia in Roma, senza hauerla da mandar fuori della città, con animo di fare che detta città fosse tutta piena di artegiani di tutte le sorti».
Nell’archivio Capitolino[787], negli atti di Girolamo Arconio, notaro dei Conservatori, troviamo: «A dì 21 di marzo 1594 — hauendo (i Conservatori) inteso che certi di questi che lavorano di carniccia per fare la colla ceruona haueuano occupato alcuni archi di sopra del teatro del Colosseo uerso Santo Clemente.... li mandarono a farli mettere imprigioni, quali mostrarono che li Guardiani... della compagnia del Confalone l’aueuano loro data licentia et affittato per una libbra di cera l’anno».
Termineremo questo capitolo col riferire alcune scoperte fatte presso il Colosseo verso l’anno 1594, delle quali ci dà notizia il Vacca[788]: «Accanto [211] il Coliseo, dice quest’autore, verso SS. Gio. e Paolo vi è una vigna, mi ricordo (circa l’anno 1594) vi fu trovata una gran platea di grossissimi quadri di travertini, e due capitelli Corintii; e quando Pio IV le Terme Diocletiane restaurò, e dedicolle alla Madonna degli Angeli, mancandogli un capitello nella nave principale, che per antichità vi mancava, vi mise uno di quelli: e vi fu trovata una barca di marmo da 40 palmi longa, et una Fontana molto adorna di marmi, e credetemi, che aueua hauto più fuoco che acqua; et ancora molti condotti di piombo».
[213]
Nell’archivio capitolino[789] troviamo che il 5 Agosto del 1639 «fu data da’ ss. Conservatori licenza a Bramante Bassi di poter far cavare e ricercare nel circuito del Colosseo ed altri antichi edifizî, colla condizione ivi apposta, sopra la porzione tangente di quello che vi si fosse trovato». Il risultato delle indagini fatte dal Bramante noi l’ignoriamo: sappiamo invece[790] che circa cinque anni dopo (la notte seguente al 21 Maggio dell’anno 1644) crollarono e caddero tre archi e mezzo dell’Anfiteatro, e che coi materiali caduti Urbano VIII fece edificare il famoso palazzo Barberini.
Nell’anno 1671 si tornò all’idea di nuovamente servirsi dell’Anfiteatro per darvi spettacoli pubblici, e specialmente la caccia di tori. Ad ottenere lo scopo, faceva d’uopo il permesso del Card. Altieri ed il consenso del Senato Romano. I signori Giuseppe Guicciardi e Giambattista Galante si rivolsero officialmente a quegli e a questo, e l’ottennero. Ecco quanto si legge in un Memoriale dell’archivio Capitolino[791]: «Anno 1671. Giugno. Registro di memoriale per la concessione della facoltà richiesta da Giuseppe Guicciardi e Gio. Battista Galante, di potere fare la caccia del toro dentro il Colosseo. Fu dato da questi due il memoriale all’Eminentissimo Cardinale Altieri padrone, da cui fu rimessa l’informazione a Monsignor Governatore di Roma, dopo la quale ne seguì, che il Cardinale concedette la facoltà; indi esposero altro memoriale ai ss. Conservatori del Popolo Romano per l’esecuzione della grazia di far giuochi di tori ed altri animali nell’Anfiteatro, promettendo di farvi risarcimento notabile e di grande spesa, quando i detti signori avessero prestato il loro consenso. Quindi l’Eccellenze loro, in conformità dell’esposta concessione impetrata, e non altrimenti, concedettero agli oratori, che potessero valersi per [214] sei anni delle parti del Colosseo spettanti al Popolo Romano, per potervi fare i giuochi espressi, con condizione però, che non fosse impedito il transito, eccettuandone solo il tempo de’ giuochi: e che per l’Eccellentissimo sig. Senatore, Conservatori, Priore ed Ufficiali di Campidoglio, restasse palco e luogo capace di 20 persone, del quale potessero valersi senza pagamento alcuno; qual decreto fu fatto e sottoscritto a’ 23 di Giugno del medesimo mese ed anno».
Era già per mettersi in esecuzione il decreto, quando Clemente X, ad istanza del P. D. Carlo Tomassi, credè bene annullarlo. Ecco in qual modo.
Il lodato Tomassi pubblicò successivamente due opuscoli sull’Anfiteatro Flavio. In essi l’autore cercò di dimostrare la santità del luogo, la venerazione in cui dovea tenersi, ed il rispetto che i fedeli dovean nutrire per quell’Arena, già santificata dal sangue cristiano. Gli opuscoli del Tomassi produssero il loro effetto: l’Anfiteatro fu tosto recinto da muri; s’allontanarono le profanazioni; si mise nella maggior devozione possibile, e si principiarono gli opportuni preparativi per solennizzare in esso la prossima ricorrenza dell’Anno Santo (1675). In quella circostanza Clemente X fe’ dipingere nel Colosseo varî quadri rappresentanti il martirio di alcuni eroi della Chiesa nascente.
Terminate le feste giubilari, il sullodato Tomassi pubblicò un altro opuscoletto col titolo: Breve relazione dell’Anfiteatro, consacrato col sangue prezioso d’innumerabili Martiri, serrato e dedicato ad onore de’ medesimi l’anno del giubileo 1675. In questo opuscolo, l’autore, dopo aver trattato dell’uso che erasi fatto dell’Anfiteatro nei passati tempi, riferisce quanto si progettò e si fece nel Colosseo durante l’Anno Santo (1675). Ecco le sue testuali parole: «È stato poi questo luogo in grandissima venerazione, e vi si rappresentava ogni anno la passione del Signore: qual uso durò sino al tempo di Paolo III. Ed il b. Pio V soleva dire, che chi voleva reliquie andasse a prendere la terra del Colosseo, ch’era impastata col sangue de’ Martiri. Ed ai tempi nostri, sono io testimonio, che ogni qualvolta sono ivi passato col signor cardinale Ulderico Carpegna, questo piissimo signore ha sempre fatto fermare la carrozza con fare la commemorazione de’ ss. Martiri, che ivi gloriosamente trionfarono: e perciò sono stato sempre divotissimo di questo santo luogo: e gli anni addietro con certa occasione feci una scrittura simile a questa, colla quale ancora persuadevo i devoti volerlo serrare, per togliere molti abusi che vi si facevano, e sacrarlo totalmente a’ ss. Martiri. Ebbe allora la scrittura per divina misericordia il suo primario inteso effetto: ed ora ultimamente il secondo, con modo affatto totale della Divina Provvidenza, essendosi esibito a fare ciò spontaneamente il signor principe Panfilio (fu questo il principe D. Gio. Battista Panfilio, signore piissimo e liberalissimo in fare elemosine ed opere di pietà) cosa da me non aspettata, sapendo che questo signore teneva tanti impieghi ed impegni di elemosine giornaliere....... Consultatone dunque [215] il negozio col sig. cavalier Bernino, egli, colla sua somma perizia e pari pietà, stimando che questa era un’opera degnissima e necessaria, non solo per la devozione a’ ss. Martiri, ma anche per la conservazione di una macchina, che come mostrava la grandezza di Roma, così era anche l’idea dell’architettura di questa; e che perciò non solo bisognava non toccare niente del vecchio, ma neanche nasconderlo, deliberò che si serrassero solamente gli Archi con alcuni muri forati, per potersi godere anco di fuori la parte interiore: e per renderlo a tutti venerabile e santo si accomodassero due facciate, la maggiore verso Roma di tre arcate, le prime tre inferiori per l’ingresso con tre ferrate, e sopra quella di mezzo un’iscrizione, e ne’ tre archi superiori si ergesse una gran croce, vessillo e trofeo de’ ss. Martiri; e che una simil facciata si facesse anco d’una sola arcata, verso s. Giov. in Laterano, designando parimenti nel centro del Colosseo, ove prima era l’ara, o altare ove si sacrificava a Giove, un piccolo tempio, per non impedire la gran macchina, in onore dei ss. Martiri. Si diede conto di tutto al sig. Cardinale Altieri, il quale ne ricevè contento grandissimo; e per la buona spedizione dell’opera, assegnò al sig. Giacinto del Bufalo, signore per la gran pietà e prudenza ragguardevole a tutta la città, e con effetto ed affetto grandissimo ha ridotta l’opera quasi al fine con applauso e devozione di tutta Roma; e molti non han lasciato, nè lasciano di trascrivere le iscrizioni che sono le seguenti:
Nella facciata verso Occidente:
AMPHITHEATRVM FLAVIVM
NON . TAM . OPERIS . MOLE . ET ARTIFICIO
AC . VETERVM . SPECTACVLORVM . MEMORIA
QVAM . SACRO . INNVMERABILIVM . MARTYRVM
CRVORE . ILLUSTRE
VENERABVNDVS . HOSPES . INGREDERE
ET . IN . AVGVSTO . MAGNITVDINIS . ROMANAE . MONVMENTO
EXECRATA . CAESARVM . SAEVITIA
HEROES . FORTITVDINIS . CHRISTIANAE . SVSCIPE
ANNO JVBILARI . ET . EXORA . MDCLXXV.
Nella facciata verso san Gio. in Laterano:
AMPHITEATRVM . VVLGO . COLOSSAEVM
OB . NERONIS . COLOSSVM . ILLI . APPOSITVM
VERIVS . OB . INNVMERABILIVM . SS. MARTYRVM
IN . EO . CRVCIATORVM . MEMORIAM
CRVCIS . TROPHEVM
ANNO . JVBILARI . MDCLXXV.
Fin qui il devoto Tomassi.
[216]
Il progetto di erigere nel Colosseo un tempietto[792] non venne attuato, sia per non ingombrare il centro dell’arena, sia perchè la chiesuola, detta della Pietà (e della quale già parlammo), trovavasi ancora in istato di discreta conservazione.
I cancelli di ferro, che dovean chiudere i due ingressi, furono suppliti con porte di legno; e sopra le iscrizioni ed i dipinti esterni, raffiguranti i Martiri, furono erette due grandi croci. Tutti gli archi del primo ordine vennero murati, lasciando in essi piccole feritoie, onde dai portici si potesse vedere l’interno dell’edificio; e questa chiusura, attesa la grandezza dell’Anfiteatro, importò una spesa non lieve. Sulla sommità dell’Anfiteatro venne eretta una grande croce di legno, la quale varie volte fu atterrata dall’impeto dei venti e successivamente rinnovata.
Con questi progetti e con questi lavori finirono le vicende del Colosseo nel secolo XVII.
[217]
Abbiam visto nel precedente capitolo che in occasione dell’Anno Santo (1675) furono murati tutti gli archi interni dell’ordine inferiore dell’Anfiteatro Flavio. Gli archi esterni però rimasero aperti, ed i portici seguivano ad essere il ricettacolo dei malviventi. Onde impedire un tanto male, il Papa Clemente XI[793] li fe’ chiudere: i portici furono ridotti a deposito di letame, collo scopo di trarne il salnitro per la vicina fabbrica di polvere; ed a questo ignobile uso servirono fino all’anno 1811.
Il 3 Febbraio del 1703 «per effetto del terremoto»[794] cadde un arco dell’Anfiteatro[795]; e coi materiali caduti e con quelli rinvenuti nella fondamenta delle case dei Serlupi, si costruì la scalinata del porto di Ripetta. Il Valesio[796], il Fea[797], ed il Cancellieri[798] descrivono la caduta di quest’arco; anzi quest’ultimo scrive che, essendo caduti tre archi del secondo recinto del lato del monte Celio, e trattandosi di mettere in vendita i caduti travertini, il Papa credè più espediente assegnarli per la scalinata di detto porto. Il ch. Lanciani[799] dice che «nei rogiti originali dei notarî della Camera Apostolica[800] esiste un’apoca di appalto pel risarcimento della strada carrozzabile che dall’arco di Settimio saliva alle stalle del Senatore ed alla piazza del Campidoglio; nel qual contratto si permette a mastro Domenico Pontiano che debba valersi delli massicci o mura cadute del Colosseo».
[218]
L’anno 1714 l’erudito mons. Bianchini domandava ed otteneva dal papa Clemente XI il permesso di praticare uno scavo nell’arena dell’Anfiteatro, onde rinvenire il piano o livello primitivo di essa arena. Il lavoro non fu ingente, giacchè alla profondità di 25 palmi tornò in luce l’antico pavimento formato di grosse ed ampie lastre di travertino.
Nonostante la chiusura degli archi, fatta nel 1675, e la diligenza spiegata onde conservare le reliquie del nostro insigne monumento e delle sue memorie; pur nondimeno, e per l’ingiuria dei tempi e per la malizia degli uomini, pochi anni dopo, gran parte di quei muri di chiusura erano a terra. La vastità dell’edificio ed i suoi nascondigli furono nuovamente il richiamo della gente immorale e ladra; e non v’ha chi ignori quanti e quanto gravi disordini, specialmente di notte, vi si tornassero a perpetrare.
Non lungi dal Colosseo eravi un ospizio eretto dal ven. P. Angelo Paoli, carmelitano. Questi, fin dalla sua celletta, osservava attentamente gli eccessi ed i disordini che si commettevano nell’Anfiteatro, ed escogitava ogni mezzo onde eliminare tanto scandalo. Si decise finalmente di darne relazione particolareggiata al Pontefice Clemente XI, nella speranza che questi volesse rimediarvi. Il desiderio del P. Paoli venne soddisfatto; verso l’anno 1714 ottenne un sussidio pontificio; raggranellò anche altre elemosine; e con questo danaro fe’ riparare i muri che chiudevano gli archi esterni; rinnovò i cancelli degli ingressi secondarî, e ai due ingressi principali fece mettere solidi portoni di legno[801]. Restaurò parimenti i muri di chiusura degli archi interni, i quali erano stati danneggiati dalla caduta di alcuni archi. Circa quest’epoca nella parte interna del primo arco, presso l’ingresso occidentale dell’Anfiteatro, fu dipinto un rozzo quadro della città di Gerusalemme e della crocifissione di Cristo; ed intorno all’arena, in varî punti del podio, vennero erette 14 edicolette, sormontate da croci e con pitture rappresentanti i notissimi misteri della Via-Crucis[802].
Il detestabile abuso che i malviventi facevano di un santo venerando edificio, stimolò l’architetto Carlo Fontana[803] ad elaborare un progetto il quale tendeva a rendere l’Anfiteatro un luogo assolutamente sacro, edificandovi un tempio dedicato ai SS. Martiri. Il progetto fu pubblicato all’Aia nel 1725, ma non fu messo in attuazione. Fra le tavole dimostrative dell’opera del Fontana, [219] ve n’è una (la V) che rappresenta l’interno del Colosseo nello stato in cui trovavasi a quei tempi. Nel fondo dell’arena, verso il Laterano, si vede una rozza chiesuola innanzi alla quale sorge una croce[804].
Nel 1741 la custodia della piccola chiesa della Pietà era affidata a Francesco Boufort (di Parigi), il quale se ne vivea tranquillamente nell’attigua casetta. I dediti alla malavita ed i ladri non vedevano nè potevano vedere di buon animo il Colosseo ben chiuso; e presto tornarono a far pertugi sui muri di chiusura. La notte dell’11 Febbraio dell’anno 1742 il disgraziato Boufort fu vittima degli audaci malfattori. Varî di questi penetrarono nella sua abitazione: gli assestarono sette pugnalate, e gli rubarono i suoi modesti risparmi. Lo sventurato romito sopravvisse miracolosamente alle ferite, ma rimase impedito nella mano destra.
Onde evitare la continuazione di simili eccessi, il generoso papa Benedetto XIV sborsò nell’anno 1743 una vistosa somma; e con questa furono restaurati (ancora una volta) i muri che chiudevano gli archi, e fortificati gli ingressi principali e secondarî; e si restaurò inoltre il piano superiore, sopra ed intorno alla chiesuola.
Il sullodato Pontefice ordinò in pari tempo a Mons. Simonetti, Governatore di Roma, la pubblicazione del seguente
EDITTO.
RANIERO SIMONETTI ARCIVESCOVO DI NICOSIA, DI ROMA E SUO DISTRETTO GENERALE GOVERNATORE, E VICE-CAMERLENGO.
«Invigilando sempre più con pia sollecitudine la Santità di N. S. Benedetto XIV felicemente regnante a fare, che da quest’alma città di Roma, che con il buon esempio deve servire di norma e di regola a tutte le altre del mondo cristiano, venga rimossa ogni occasione di offesa di Sua Divina Maestà e di pubblico grave scandalo, ha considerato essere molto indecente, che l’antico Anfiteatro, volgarmente detto il Colosseo, luogo degno di tutta la venerazione per la memoria di tanti ss. Martiri, che in difesa della fede cattolica, spargendo il proprio sangue, vi hanno gloriosamente riportata la palma del martirio, venga profanato da taluni figli d’iniquità, che prevalendosi dell’opportuno [220] comodo che a lor presentano e la solitudine del luogo e i molti nascondigli che in esso sono, vi commettono gravi eccessi. Quindi è che, con ordine datoci a bocca, ci ha comandato di pubblicare il presente Editto, da durare a beneplacito suo e della Santa Sede Apostolica, con cui, inerendo alle pie pontificie e supreme determinazioni, ordiniamo e comandiamo, che in avvenire niuna persona di qualsivoglia stato, condizione, grado e sesso, benchè Ecclesiastica, Claustrale e Regolare, abbia ardire di trattenersi, sì di giorno che di notte, a mal fine in detto Colosseo, sotto pena, se sarà uomo, di tre tratti di corda da darglisi in pubblico: e se sarà donna, della pubblica frusta, oltre le pene pecuniarie da imporsi all’uno ed all’altra a nostro arbitrio; dichiarando, che per l’incorso di tali pene, sarà sufficiente che siansi portati in tal luogo a mal fine, e così possa legalmente presumersi da altre congetture, e dall’escludersi, che vi siano portati per altra causa.
«Ma se poi questo mal fine avrà avuto il suo pieno effetto, e vi avranno commesso qualche eccesso e delitto, vogliamo che le suddette pene possano estendersi a nostro arbitrio; rispetto agli uomini, alla galera ad tempus, o perpetua, ed in quanto alle donne, alla rilegazione a tempo, o perpetua, ed anche agli uni ed alle altre a quella della vita, secondo la qualità e circostanze de’ casi e dei delitti che avranno commessi.
«E siccome per ovviare a simili inconvenienti, la San. Mem. di Clemente XI fece cinger di muri li primi archi di detto Anfiteatro, e munir di cancelli, quelli, che servir doveano per l’ingresso delle carrette e bestiami che vi portano il letame per servizio della fabbrica de’ salnitri, così la Santità di Nostro Signore, dopo aver fatto riattare detti muri in quelle parti, ove o per l’ingiuria dei tempi o per colpa di chi ha desiderato avervi l’ingresso, erano devastati, ci ha ordinato di dover proibire, come facciamo con il presente Editto, che in avvenire niuna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione e sesso, come sopra, abbia ardire di rompere, disfare, anche in piccola parte, per qualunque causa e fine detti muri, e che li carrettieri, stabiaroli, conduttori di bestie, o qualunque altra persona, a cui spetti l’aprire e richiudere i cancelli che vi sono, non possano in alcun tempo, sì di giorno come di notte, tanto nell’entrare che nell’uscire, lasciarli aperti, sotto pena in ambedue li casi di tre tratti di corda, da darglisi in pubblico irremissibilmente, ed altre pene, anche corporali più gravi a nostro arbitrio, secondo la qualità e circostanze de’ casi che potessero darsi, o per causa delle rotture di detti muri, o per li cancelli suddetti lasciati aperti.
«Avverta pertanto di prontamente ubbidire ciascuno a quanto si dispone nel presente Editto, mentre contro li trasgressori si procederà irremissibilmente alle imposizioni delle pene, ancorchè non fossero presi in fragranti dalla corte, ma per inquisitionem, ex officio, ed in ogni altro modo; volendo, che il presente [221] Editto, pubblicato ed affisso ne’ luoghi soliti, obblighi subito ciascuno, come se gli fosse stato personalmente intimato».
Dato dal Palazzo della nostra solita residenza questo dì 8 Febbraio 1744.
R. Simonetti, Arciv. di Nicosia
Governatore e Vice-Camarlengo.
Bernardino Rossetti
Notaro per la Carità.
Il 1750 non era già lontano; e i fedeli, volendo solennizzare con qualche novità l’Anno Santo, stabilirono di fondare nel Colosseo una Congregazione o Compagnia laicale, composta di soggetti civili. Progettarono quindi di erigere sul piano restaurato da Benedetto XIV un grandioso tempio, di rinnovare le 14 edicole della Via Crucis, e restaurare le parti fatiscenti dei portici e delle scalinate dell’Anfiteatro. Non tutti questi progetti si attuarono, ma la devozione verso quel luogo andava nondimeno ogni dì più crescendo. Nell’anno 1749 il Papa Benedetto XIV consacrò l’arena anfiteatrale alla memoria della Passione di Cristo e dei suoi martiri. A perenne ricordo dell’Anno Santo, fe’ incidere su marmo quell’iscrizione che già il papa Clemente X aveva fatta imprimere sul bianco intonaco[805], e che dice:
✠
ANPHITHEATRVM . FLAVIVM
TRIVMPHIS . SPECTACVLISQVE . INSIGNE
DIIS . GENTIVM . IMPIO . CVLTV . DICATVM
MARTYRVM . CRVORE . AB . IMPVRA . SVPERSTITIONE
EXPIATVM
NE . FORTITVDINIS . EORVM . EXCIDERET . MEMORIA
MONVMENTVM
A . CLEMENTE . X . P . M .
ANNO . IVB . MDCLXXV
PARIETINIS . DEALBATIS . DEPICTVM
TEMPORVM . INIVRIA . DELETVM
BENEDICTVS . XIV . P . M .
MARMOREVM . REDDI . CVRAVIT
ANNO . IVB . M . DCCL . PONT . X[806].
Rinnovate le 14 edicole della Via-Crucis su i disegni di Paolo Posi, senese; il Vicegerente mons. Ferdinando M. De Rossi, il 27 Dicembre del 1749, [222] fece la benedizione dei quadri, e nel centro dell’arena si eresse una croce. S. Leonardo da Porto Maurizio, dell’Ordine dei Minori, dimorante nel convento di S. Bonaventura al Palatino, diè tosto principio all’esercizio della Via-Crucis. Il popolo accorse numeroso al pio appello di S. Leonardo, e Benedetto XIV, con chirografo del dì 8 Gennaio 1752, donò al Sodalizio degli Amanti di Gesù e Maria, le edicole suddette.
In certi giorni stabiliti, l’Arciconfraternita recavasi processionalmente al Colosseo per praticare l’esercizio della Via-Crucis: la processione era preceduta dalla croce, la quale veniva portata dal direttore del Sodalizio, che era sempre un Cardinale.
Il 19 Settembre dell’anno 1756 il card. Guadagni, Vicario di Sua Santità, celebrò la messa con comunione generale nell’Anfiteatro. Un numero straordinario di sodali d’ambo i sessi e di altri fedeli si accostò ai sacramenti: a tutti si diè una medaglia benedetta.
Le comunioni così dette generali, si seguirono a fare nel Colosseo (ed anche con maggior solennità) negli anni seguenti; e i Sommi Pontefici Benedetto XIV e Clemente XIII annessero a quella pratica l’indulgenza plenaria.
Ridotto il Colosseo a luogo sacro, potè meglio conservarsi; e a questo fatto si deve se si salvarono dalla completa distruzione almeno le reliquie di un edifizio che fu mai sempre l’oggetto dell’ammirazione universale, ed un soggetto fecondo di profondi studî e ricerche di famosi archeologi ed architetti, i quali, come è noto, ci lasciarono interessanti lavori e saggi commenti.
[223]
Nell’anno 1805, il ch. Guattani[807] scriveva: «Qual’altra mole teatrale vi potè essere più machinosa dell’Anfiteatro Flavio? E qual vi è ora più superba ed imponente rovina? Basta vederla per non iscordarla mai più. Il pittoresco che il tempo nel distruggerlo vi ha insensibilmente introdotto, l’ha resa poi sì vaga ed interessante, che si giunge da molti a non desiderarne il restauro. Potrebbero contentarsi l’età future di vederlo nello stato presente; ma lo sfacelo si avanza a gran passi: di qua ad un secolo se ne anderà il resto dell’interior tessitura, e farà d’uopo ai curiosi di ricorrere al Serlio, al Desgodetz, al Fontana, al Overbek, al Piranesi, al Marangoni, al Maffei, al Morcelli, al Carli, ecc.».
Le previsioni del Guattani sarebbero oggi una triste realtà, se il Colosseo non fosse stato diligentemente ed opportunamente restaurato dai Papi del secolo XIX. Ai tempi infatti in cui egli scriveva (a. 1805), la venerabile mole dei Flavî trovavasi in uno stato lamentevole. Non v’era chi non prevedesse la sua prossima rovina. La caduta poi dell’intera fascia esterna dell’angolo verso il Laterano era inevitabile ed imminente.
Pio VII, amante qual fu degli antichi monumenti, non potè trascurare la più grandiosa reliquia della grandezza romana; e sollecitamente ordinò l’edificazione del solido e grandioso contrafforte, il quale, fino ad oggi, noi ammiriamo. Il portentoso ed opportuno lavoro reca giusta maraviglia ad ogni intelligente visitatore, sia per la sua solidezza, sia per l’indiscutibile difficoltà dell’impresa. Il colossale contrafforte, tutto in opera laterizia, fu infatti costruito quando le pietre ed i massi dell’edificio eran già slegati e prossimi a cadere. Il lavoro riuscì, ripeto, solidissimo, ma l’urgenza impedì all’illustre [224] architetto di dargli (come più tardi si fece in un altro contrafforte o sperone) la forma primitiva dell’edificio.
Poco dopo il ritorno di Pio VII dal triste esilio, e precisamente nell’anno 1815, il pacifico Pontefice rivolse di nuovo i suoi sguardi verso il Colosseo, ed ordinò che si restaurasse la sua parte interna. Le cure avute dall’operoso Pontefice per le parti superstiti del nostro Anfiteatro, ci vengono ricordate dalla seguente iscrizione marmorea:
PIUS VII P. M.
ANNO VII[808]
L’esempio generoso di Pio VII fu imitato dal suo successore, il quale nell’anno 1828 fe’ edificare un contrafforte verso la Mèta Sudante. Leone XII affidò la direzione di questo lavoro all’illustre architetto romano Giuseppe Valadier, il quale fece ricostruire in opera laterizia la metà dell’arco LV ed i due archi seguenti, dando ad essi, in pari tempo, la forma e lo stile originale del monumento (V. Fig. 7ª). A perpetua memoria di questo grandioso ed utile lavoro, fu affissa l’epigrafe marmorea che dice:
LEO XII PONT. MAX.
ANN. III
Anche il Sommo Pontefice Gregorio XVI ebbe cura dell’insigne monumento dei Flavî. A questo Papa deve Roma la ricostruzione di sette arcate ed il restauro del terzo portico (originariamente interno ed oggi esterno) dell’Anfiteatro[809]. Il ricordo di quest’opera l’abbiamo nella seguente iscrizione:
GREGORIUS XVI
PONT. MAX.
ANNO XIV
[225]
***
A pag. 22 dell’operetta intitolata «L’Arcicofraternita di S. Maria dell’Orazione e Morte e le sue rappresentanze sacre»[810], scritta dal sig. Augusto Bevignani, leggo: «Un caratteristico progetto ventilato allora (nel 1832) e degno di essere ricordato fu d’adibire nientemeno il Colosseo a cimitero provvisorio! Il card. Bernetti, segretario di Stato, con lettera particolare e riservata in data 22 Aprile 1832, al segretario di Consulta ne caldeggiò la proposta perchè molto economica la sepoltura in quell’arena ed adiacenti ambulacri per essere il monumento appartato e sacro alla religione[811]. Ma la sacra Consulta prescindendo da tutte le viste in linea d’arte rispose in data 2 Maggio non potersi adibire quel monumento a tale scopo per i sotterranei continuamente inondati dalle acque disperse o fluenti dai colli circostanti, perciò d’ostacolo alla pronta decomposizione dei cadaveri, e per la mancanza di ventilazione essendo circondato da cinque colli i quali avrebbero impedito la dissipazione degli effluvî che si sarebbero riversati sulla città attesi i venti meridionali che vi dominano».
[226]
***
Fortificata e resa sicura la parte superstite del vetusto edificio, i Romani ed i visitatori nazionali e stranieri poterono tranquilli aggirarsi a lor agio tra quegli imponenti avanzi; ed i fedeli accorsero più copiosi a seguire i confratelli del Sodalizio dei devoti di Gesù Cristo al Calvario, i quali praticavano ancora il pio esercizio della Via Crucis nell’interno del Colosseo. Questa commovente funzione ci fu elegantemente descritta dal marchese Luigi Biondi[812], Presidente della Pontificia Accademia Romana di archeologia. Incomincia così:
«Ne l’arena del Flavio Anfiteatro,
Ove ai feri spettacoli frequente
Correva un tempo il popolo idolatro,
Adunata vid’io turba dolente
D’entrambi i sessi e di ciascuna etade,
La verde, la matura e la cadente».
E chiude:
«Santa Religïon! gli aspri costumi
Tu raddolcisci, e fai stille di pianto
Versar, dove correan di sangue fiumi.
Ed or, vestita in bianchissimo ammanto,
Del sacro loco sei fatta custode,
E mite siedi alla gran croce accanto.
E par che il guardo tuo quasi rannode
Le smosse pietre, e la gran mole i danni
Sprezza del tempo, ch’ogni cosa rode.
Da l’alta cima sua s’affaccian gli anni,
E in lustri uniti, e in più secoli accolti
Batton le pietre co’ lor ferrei vanni.
Ma son da la tua voce in fuga volti,
Che imperïosa questi accenti move:
Fino ai vostri odi, che già furon molti,
Ite, ch’or sacro è il loco, itene altrove».
Mercè questi grandiosi restauri, poterono pei lor fini servirsi del Colosseo i demagoghi della rivoluzione romana. L’Anfiteatro Flavio, che nel corso di tanti secoli n’avea vedute d’ogni sorta entro il suo recinto: lotte feroci e sanguinarie, vittime innocenti immolate, assalti guerreschi, dolenti e devote rappresentazioni, infami gesta di malviventi; una sola cosa non avea ancor veduta.... una scena comica... e la vide.
[227]
Il 23 di Marzo dell’anno 1848 il Colosseo fu teatro di una frenetica adunanza popolare; ed ecco come la descrive Alfonso Balleydier[813]. «Avvertito (il Popolo Romano) sino dal giorno innanzi che avrebbe luogo al Coliseo una grande riunione popolare onde deliberare sui mezzi di salvare la patria in pericolo, si reca in massa nell’arena dei gladiatori e dei martiri. Era il 23 di Marzo. Sul cielo di Roma rischiarato da bellissimo sole di primavera, non appariva un sol nuvolo; sul volto dei Romani brillante d’entusiasmo non si vedeva segno di mestizia; i soldati della guardia civica, i membri dei circoli, la nobiltà, la borghesia, i principi, gli artigiani e i proletarî, erano colà tutti in un gruppo disposto coll’istinto artistico degli Italiani: qui il domenicano colla veste bianca e il lungo mantello nero; lì il cappuccino colla barba lunga rinchiusa nel cappuccio di lana scura; di quà l’abate col piccolo manto corto ed elegante; di là gli alunni dei collegi colle sottane turchine, rosse, violette, scarlatte e bianche, formavano un mosaico umano, e accanto il militare, la cui splendente uniforme facea contrasto col semplice e pittoresco abbigliamento Trasteverino, e le donne di ogni ceto completavano il quadro somigliante ad una decorazione o comparsa teatrale. Teatro magnifico era infatti il Coliseo con le sue ruine, le grandi sue rimembranze e folto uditorio ritto sotto alle bandiere. Superbo spettacolo, momento solenne! Allora un uomo di alta statura, un prete vestito da Barnabita si avanza tra la folla che gli apre libero il passo, e in atto drammatico si dirige verso il pulpito sacro, ove due volte per settimana un povero frate di S. Bonaventura viene a narrare con lagrime e singulti alla gente del volgo i patimenti dell’Uomo-Dio. Questo prete, di andatura fiera è il principale personaggio del dramma che si prepara, è un frate ambizioso, una meschina copia di Pietro l’Eremita, è il P. Gavazzi. La parte che ha da fare gli addice e l’abito che indossa accresce l’illusione della scena. Un lungo manto nero, in cui si avvolge in atteggiamento artistico, gli copre la toga nera, stretta alla vita da una larga cintura dello stesso colore. Una croce verde, rossa e bianca gli appare sul petto; l’ampia fronte è scoperta; ha sul viso tutti i segni di un’espressione maschile e robusta; i lunghi capelli neri disciolti gli scendono sul collo; ha uno sguardo da ispirato, gesto armonioso, voce sonora. Eccolo a predicare la crociata dell’indipendenza italiana»......
Terminata l’entusiastica arringa del P. Gavazzi, sale il sacro pulpito, divenuto tribuna politica, un contadino di nome Rosi; dopo il quale parlarono il Masi, segretario del principe di Canino, poi un giovane prete, il general Durando, un frate Conventuale francese, di nome Stefano Dumaine, il general Ferrari e finalmente lo Sterbini. Non è qui il luogo di narrare tutti i colpi di [228] scena che in quella giornata vide svolgersi nella sua arena l’Anfiteatro Flavio. Bastami aver accennato il fatto.
Dopo il proprio consolidamento, il Colosseo incominciò ad offrire grato spettacolo ai Romani ed ai forestieri colla fantastica illuminazione delle sue rovine a fuochi di bengala. La prima volta, per quanto io sappia, fu nel 1849, allorchè il 21 di Aprile, la Repubblica Romana, per festeggiare il Natale di Roma, fece illuminare a bengala tutti i monumenti, dal Campidoglio al Colosseo[814]. Questa festa fu descritta dal cav. Pompili-Olivieri nell’opera «Il Senato Romano nelle sette epoche di svariato governo, da Romolo fino a noi»[815], in questa guisa: «Il governo fece illuminare il Foro Romano, gli archi trionfali che vi esistono e tutti gli avanzi della basilica di Costantino (creduta da alcuni il tempio della Pace) e dell’Anfiteatro Flavio. Vi furono ancora copiosi fuochi di bengala, che ne’ magnifici archi, specialmente del Colosseo, facevano un effetto veramente magnifico. Nel mezzo dell’arena del Colosseo rallegravano la moltitudine i concerti musicali, ed il canto degli inni patrî riscaldava mirabilmente lo spirito del partito liberale, il cui grido di Viva la Repubblica eccheggiava sonoro nelle grandiose vôlte dell’immensa mole. Non mancarono fra gli applausi oratori estemporanei che rammentavano al popolo le vetuste glorie di Roma ed infervoravano al suo governo repubblicano».
La fantasmagorica scena del Colosseo, rischiarato da quella luce variopinta, piacque tanto, che da allora invalse l’uso, e si conserva tuttavia, di ripeterla in fauste circostanze, come, ad esempio, per la venuta in Roma di Principi esteri o per una straordinaria affluenza di forestieri nell’alma Città: talchè può dirsi non passi anno che il Colosseo non venga illuminato a bengala. L’effetto dell’illuminazione, contemplata specialmente dalla cavea, è mirabile: sembra di assistere all’accensione di un cratere vulcanico. Molti però a questa viva luce, preferiscono il pallido chiaror della luna, alternato dalle nere ombre delle rotte vôlte e degli sfondi delle grandi arcate.
«Nel 1852 Pio IX riparò l’ingresso (imperatorio) verso l’Esquilino[816], davanti il quale vi fu in origine un portichetto sorretto da colonne scanalate di marmo frigio; e restaurò in quella stessa parte varie arcate del portico interno»[817], spingendo i lavori fino al piano del porticale alla sommità della cavea. Di questi grandi restauri parlò il Canina, che ne fu il direttore, nella tornata della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, il 7 Aprile 1853; [229] ed in questa occasione, scrive il Segretario P. E. Visconti, il Canina rinnovò all’Accademia l’invito di voler accedere sul luogo per osservarli, siccome fu in effetto deliberato che seguisse»[818].
Anche questo lavoro ci viene ricordato da una lapide, che dice:
PIVS IX PONT. MAX.
ANN. VII
e dalla seguente epigrafe[819]:
PIVS . IX . PONT . MAX .
QVVM . PARTEM . MEDIAM . AD . ESQVILIAS . CONVERSAM
VETVSTATE . FATISCENTEM
RESTITVENDVAM . ET . MVNIENDAM . CVRASSET
MEMORIAM . RENOVAVIT
ANNO . MDCCCLII . PONT . VII
Dopo la breccia di Porta Pia (20 Settembre 1870) nell’interno del Colosseo ebbe luogo un meeting, nel quale si scelsero i rappresentanti della Giunta provvisoria di governo.
Venuti i monumenti di Roma nelle mani della R. Sopraintendenza agli scavi delle Antichità, il Comm. Pietro Rosa (a. 1871) fe’ togliere dalle mura del Colosseo «il pittoresco (?) ammanto di verdura, con 420 specie di piante, che da secoli lo ricopriva»[820], e che formerà il soggetto della prima Appendice di questo nostro lavoro.
Nel carnevale del 1874 una società di buontemponi ideò di rappresentare o meglio parodiare nel Colosseo gli antichi giuochi. Ma il Senatore Scialoja, Ministro di Pubblica Istruzione, non ne diè il permesso.
Dopo i restauri fatti dall’immortale Pio IX, il Colosseo non è stato più riparato. Eppure la parte alta della muraglia esterna[821] è molto meno sicura di quanto si creda!....
[231]
Prima d’incominciare la narrazione degli scavi regolarmente eseguiti nell’Anfiteatro Flavio a fin di studiarlo e conoscerlo in tutte e singole le sue parti, mi si permetta di ricordare un tentativo, quasi direi preistorico, fatto nel secolo XV.
Nell’«Excerpta a Pomponio, dum inter ambulandum cuidam domino ultramontano reliquias ac ruinas urbis ostenderet», il cui testo genuino fu rinvenuto dal De Rossi nel codice Marciano latino[822], e divulgato negli Studi e Documenti di Storia e Diritto[823]; al f. 25º si accenna «a scavi, nel corso dei quali furono scoperte le cloache che solcano in vario senso il substrato dell’Anfiteatro, come pure il largo marciapiede che lo attorniava, scoperto nuovamente nel 1895»[824].
Gli scavi intrapresi nel Colosseo dal Governo Francese, rappresentato dal barone Daru, Intendente della Corona, furono fecondi di buoni successi. Si lavorò indefessamente per lo spazio di quattro anni circa: la direzione degli scavi fu affidata al famoso architetto romano Valadier, e lo sterro dell’arena si eseguì con inappuntabile regolarità. Fu allora che si rinvenne il podio, il passaggio di Commodo, gli ipogei dell’arena, ecc. Questi ultimi consistevano in tre pareti concentriche al podio, delle quali la più vicina a questo era formata da una serie di pilastri egualmente distanti fra loro; in due ambulacri racchiusi dalle dette pareti, ed in altri cinque ambulacri centrali, tre rettilinei e due mistilinei, i quali fiancheggiavano quattro serie di bottini o pozzi, come più piace chiamarli, che, per la loro uniforme regolarità, indicavano d’essere stati fatti per uno scopo determinato (V. Fig. 8ª).
[232]
[233]
La costruzione di questi muri appartiene evidentemente ad epoche diverse; giacchè mentre alcune parti sono d’opera quadrata di massi regolari di travertino e tufo, nell’insieme presentano quella costruzione irregolare (formata di pietre e laterizio), che apparisce sovente negli edificî dei tempi della decadenza. La varietà di costruzione e la promiscuità di materiali usati in una stessa opera, furono l’origine di vivaci dispute e di disparate opinioni fra i dotti, le quali noi per ragion di storia riporteremo in succinto, ed esporremo in fine il nostro parere.
Vi fu chi opinò che quelle costruzioni fossero coeve all’Anfiteatro o del tempo di Tito, e che poscia fossero state risarcite da Basilio. Altri le giudicarono dell’epoca dei Frangipani. Altri finalmente opinano nè esser quelle contemporanee all’edificazione dell’anfiteatro nè dell’età di mezzo, ma della fine del secolo II o degl’inizî del III. La prima opinione fu difesa dal Bianchi, coadiuvato nella parte archeologica dal Prof. Lorenzo Re, i quali basarono la loro tesi:
1º Sulle regolarità dei pozzi, donde, dissero, uscivano le gabbie che racchiudevano le belve.
2º Sul fatto che il podio era munito di «macchine versatili, reti e denti lunghissimi sporgenti sull’arena»[825].
3º Sul passo di Erodiano[826], nel quale leggesi: ἀναῤῥιπτέιν (sursum mittere, sursum iacere).
Il Bianchi prevenne l’obiezione che gli si potea facilmente rivolgere, ricordandogli le naumachie narrateci da Suetonio e da Dione; e, disprezzando soverchiamente e con poca equità la fama storica del secondo, asserì che una sola naumachia ebbe luogo nell’Anfiteatro Flavio; quella cioè che si diè ai tempi di Domiziano; ed aggiunse che, anche ammettendo altri combattimenti navali, questi non osterebbero alla sua opinione, imperocchè, dice, quattro piedi d’acqua possono sostenere qualunque barca; e con ripari provvisori si potè impedire che l’acqua penetrasse negli ambulacri e nei portici.
Il difensore della seconda opinione fu l’avv. Fea[827], il quale asserì ostinatamente che l’arena del Colosseo non fu giammai sostrutta, e che le sostruzioni che noi vediamo son opera dei bassi tempi, e precisamente dell’epoca dei Frangipani. Il Fea procurò provare il suo asserto coi seguenti argomenti:
[234]
1º Il podio, ammessa l’arena sostrutta, sarebbe stato alto appena dieci piedi. Malgrado dunque le rotule, i denti e le reti, la sua altezza era insufficiente a salvare gl’Imperatori, i Pretori, ecc. dai salti delle tigri e dalla proboscide degli elefanti.
2º Un’arena sostrutta è affatto inadatta per le naumachie.
3º Finalmente il piano rinvenuto, disse, non può essere il vero e primitivo livello dell’arena; ma questo devesi ricercare in maggiore profondità.
Il Masdeu[828] tentò di conciliare le due opposte opinioni: scrisse a questo scopo 21 lettere, ma ricevè ai suoi scritti un’acre risposta dall’avvocato Fea[829].
Il Nibby, nelle Aggiunte al Nardini[830], propendè per l’opinione difesa dal Fea; ma nella sua pregievolissima opera Roma nell’Anno MDCCCXXXVIII cambiò d’opinione, e scrisse:
«Le testimonianze di Suetonio e di Dione apertamente dichiarano che nell’Anfiteatro Flavio vi si diedero combattimenti navali sotto Tito e sotto Domiziano. Stando.... ai fatti riconosciuti, e dando il peso dovuto all’autorità degli antichi scrittori, parmi doversi stabilire, che da principio, sotto Tito e Domiziano, quando vi si diedero giuochi navali, l’arena era di livello più basso e non sostrutta; che Traiano nel restauro fatto nell’Anfiteatro comprese ancora il lavoro di alzare l’arena al piano attuale, per mezzo di sostruzioni regolari essendo crollate pe’ terremoti avvenuti sotto Teodosio II e Valentiniano III nel quinto secolo, e sotto Teodorico sul principio del sesto furono risarcite secondo lo stile di quei tempi da Lampadio e da Basilio prefetti di Roma; così si dà ragione della diversità delle costruzioni, così pure si comprende HARENAM AMPHITHEATRI . . . . RESTITUIT, e quella della lapide di Basilio: ARENAM ET PODIVM QVAE ABOMINANDI TERRAEMOTVS RVINA PROSTRAVIT . . . . RESTITVIT: così chiaramente s’intendono i passi di Petronio, Erodiano e Calpurnio. Il primo nel Satyric. c. IX dice: non taces gladiator obscoene quem de RVINA ARENA DIMISIT. Erodiano raccontando le cacce date da Commodo appunto in quest’Anfiteatro, così si esprime: λεοντων δε ποτε εξ ὑπογαιων ἑκατον αναρρ’ ιφδεντων, ισαριδμοις ακοντιοις παντας απεκτεινεν: ed una volta essendo stati lanciati su dai SOTTERRANEI cento leoni con altrettanti strali tutti li uccise: finalmente Calpurnio, ecl. VII, v, 69, esclama:
Ah trepidi quoties nos Descendentis arenae
Vidimus in partes ruptaque voragine terrae
Emersisse feras!
[235]
Il Lanciani, come altrove dicemmo, opina che, almeno fino dal principio del secolo III, l’arena lignea fosse pensile sulle proprie sostruzioni; ed aggiunge[831] che «Pausania nel cap. 12 delle ΗΛΙΑΚΩΝ § 4, registra fra le grandi opere di Traiano in Roma, καὶ Θέατρον μέγα κυκλοτερὲς πανταχόθεν[832], cioè l’Anfiteatro Flavio. Dalla quale inesatta asserzione del geografo alcuni hanno voluto trarre indizio di restauri avvenuti sotto l’impero dell’ottimo Principe, dei quali non si ha altrimenti notizia. Il Nibby R. A. I, 421, suppone che Traiano abbia costruito gli ipogei dell’arena, ma questa è supposizione gratuita[833]. Sul piano dell’abaco di un capitello a foglie d’acqua, caduto dal vertice dell’Anfiteatro in fondo all’arena, rimangono le casse di nove lettere di metallo, alte m. 0,37 spettanti ad iscrizioni monumentali:
«Il capitello, prosegue, è dei tempi bassi: e non reca maraviglia il vederlo scolpito con masso di marmo appartenente a più antico edifizio, forse all’arcus divi Traiani della region prima, le spoglie del quale servirono ad abbellire il vicino Arco di Costantino»[834].
Il Canina, finalmente, congettura che la costruzione dei muri degli ipogei suddetti sia dell’epoca di Severo Alessandro.
Alle varie opinioni già esposte mi sia lecito aggiunger la mia.
La sostruzione dell’arena è talmente necessaria ad un anfiteatro, che se questo ne fosse privo, perderebbe, quasi direi, la sua speciale caratteristica. Immaginare infatti un edificio anfiteatrale senza gl’ipogei dell’arena, sarebbe lo stesso che immaginar un corpo animato senza gli organi interni. La vita, dirò così, dell’anfiteatro si svolgeva negl’ipogei, e si manifestava sull’arena; e non mi sembra plausibile l’opinione o la supposizione che Vespasiano abbia voluto erigere il suo celeberrimo Anfiteatro senza l’arena sostrutta. Poteva per avventura mancare nell’Anfiteatro per eccellenza, costruito in pietra, e, giusta l’idea d’Augusto, media urbe, ciò che ebbero fino i temporanei che lo precedettero? Petronio, scrittore dei tempi Neroniani, dice: «non taces gladiator obscoene, quem de ruina arena dimisit?» e poco dopo: «ergo [236] me non ruina terra potuit haurire . . . . . . . . aufugi iudicium, arenae imposui»[835].
Io opino adunque che l’arena fosse sostrutta fin dal principio, e che avesse un livello più basso di quello a cui fu poi elevata.
Sennonchè, a cagione delle naumachie (le quali positivamente si rappresentarono due volte nel nostro Anfiteatro), l’arena fu da prima sostrutta stabilmente con muri, oppure con un’armatura lignea da potersi rimuovere all’occorrenza? La seconda ipotesi è inammissibile per molte ragioni, che credo qui inutile addurre perchè gli scavi decisero la questione.
Nei muri degl’ipogei si sono rinvenuti avanzi tuttora al posto di massi regolari di travertino e tufo, che sono la materia adoperata in grandissima copia nella costruzione dell’Anfiteatro, e specialmente nei siti ove richiedevasi maggior solidità. I due portici esterni sono stati costruiti di pietra tiburtina, ed i muri che nel piano terreno formano i cunei delle scale e dei passaggi, sono composti d’intelaiature di massi di travertino, racchiudenti specchi in parallelopipedi di tufo. Di questo parere fu eziandio Lorenzo Re, il quale, nelle sua Illustrazione e difesa delle Osservazioni dell’architetto Pietro Bianchi sull’arena e sul podio dell’Anfiteatro Flavio, dice: «Fig. 8, 9, 10. Porzioni delle sostruzioni dell’arena in bellissima costruzione di grandi pietre rettangolari uniforme perfettamente alla generale costruzione dell’Anfiteatro»[836].
Se le sostruzioni dell’arena avessero potuto o no impedire l’esecuzione delle naumachie, lo vedremo allorquando si parlerà di queste.
Gli scavi, oltre all’averci indicato negli avanzi dei muri primitivi l’originaria sostruzione stabile dell’arena, ci hanno pur anche manifestato l’antico suo livello.
Il muro di perimetro dell’ipogeo ha in ogni quadrante dell’ovale una serie di otto grandi nicchie arcuate, a fondo piano, larghe m. 3 e profonde oltre un metro[837]. Dalla fronte di ciascuno dei trentasei piloni che sostengono gli archi, sporgono due mensoloni di travertino, i quali si trovano 3 metri circa sotto il livello attuale dell’arena: tra una mensola e l’altra, nella fronte del pilone, v’è un’incavatura verticale, a piè della quale è murato un masso di travertino, lungo quanto è grosso il pilone; l’incavatura poi sarebbe atta a ricevere una trave (V. Fig. 9ª).
Dall’imposta degli archi in su, per tutto il giro dell’ovale, vedesi un taglio praticato nella fronte delle nicchie: taglio, che riduce alla metà circa la [237] profondità delle vôlte, la sommità delle quali è ripresa (dove più dove meno, secondo che occorreva) con archi di mattoni. Nel fondo di ciascuna nicchia, dal piano superiore delle mensole in giù, v’è un’apertura rettangolare, a guisa di piccola finestra, addossata al pilone, larga m. 0,70 circa, la quale ha un grosso architrave di pietra tiburtina.
[238]
Nella parte inferiore delle nicchie si vedono addossate ai piloni per tutta la loro profondità due piccole spalle, sulle quali son gettate volticelle a sesto scemo, terminate in fronte da archi. Le vôlte, l’estradosso delle quali trovasi ora al piano inferiore delle mensole, otturano, per la metà circa, l’altezza delle aperture ora descritte nel fondo delle nicchie. La costruzione laterizia dei piloni e del fondo delle nicchie è dell’epoca di Vespasiano, e quindi contemporanea all’edificazione del monumento; mentre la costruzione degli archi scemi, delle piccole spalle e della ripresa delle vôlte è discreta anch’essa, ma d’epoca posteriore a quella dei Flavî.
Sarei di parere che il taglio nella parte superiore delle nicchie e le volticelle sceme con le loro spalle riportate, sia un lavoro eseguito contemporaneamente ai pilastri di opera quadrata di tufo, per formare dietro di essi un passaggio.
Che le trentadue nicchie appartengano alla primitiva disposizione della parte infima dell’Anfiteatro, oltre alla costruzione dei muri, ce lo manifesta quella serie di pilastri che noi vediamo costruiti di massi di tufo, collegati fra loro con architravi della stessa materia, i quali, a breve distanza dalle mensole, si ergono fin quasi al piano attuale dell’arena, disposti con regolarità fra loro, ma con nessuna rispetto alle mensole stesse ed ai piloni retrostanti; dichiarandoci quei pilastri, col complesso di tutte le circostanze concomitanti, che essi furono costruiti posteriormente ai piloni, e che questi e le mensole avevano a quel tempo perduto il loro scopo.
Io congetturo pertanto che, ai tempi di Vespasiano, sopra i mensoloni fossero collocate orizzontalmente attorno attorno delle grosse travi, sulle quali e sui muri di opera quadrata degli ipogei riposassero altre travi che sostenevano il tavolato dell’arena. Posta la mia supposizione, detratte dal dislivello che v’è tra il piano delle mensole e quello dell’arena attuale (che è il medesimo dell’antica rialzata) le grossezze delle travi e del tavolato, ne segue che il livello dell’arena primitiva era più basso di quello dell’arena posteriormente rialzata, di circa due metri, e che l’ipogeo ebbe in origine un’altezza di circa tre metri e mezzo[838]. E siccome il podio nella sua primitiva costruzione non fu più basso di quello che ora lo vediamo (poichè i muri che sostengono la gradinata del podio suddetto e le scale che conducevano al ripiano dei senatori, sono di assoluta costruzione Vespasianea); così dovrà concludersi che il ciglio superiore del parapetto del podio all’epoca dei Flavî distava dal piano dell’arena di circa sette metri.
Disposte le cose in tal maniera, risulta pure che gli archi impostati su i piloni rimanevano quasi del tutto fuori del livello dell’arena; ed io credo che [239] questi, muniti di grate, servissero verosimilmente a doppio scopo: tanto, cioè, per dar luce all’ipogeo, quanto, e principalmente, nell’esecuzione delle naumachie come a suo luogo vedremo.
Le incavature poi, che appariscono nella fronte dei piloni fra le mensole dovettero servire, come giustamente osservò il Gori, a ricevere le travi che sostenevano la grande rete.
Un rozzo graffito antico (V. Fig. 10ª) rinvenuto negli scavi eseguiti nel 1874 dal Comm. Rosa negl’ipogei dell’arena, ha tutto l’aspetto di una rappresentazione della fronte primitiva del podio. Così anche parve al Gori[839], e corrisponde, quasi direi, a capello col risultato dei miei ragionamenti. È questo un frammento di lastra marmorea su cui si veggono in graffito, una presso l’altra, cinque arcate di un sesto poco inferiore al semicircolo, munite d’inferriate; sopra queste vi sono pure in graffito linee che formano una transenna enorme relativamente agli archi sottoposti; e sembra che in essa si sia voluto rappresentare, in modo rozzamente convenzionale, la grande rete del podio. Al di sotto delle arcate poi rimane la parte superiore di due figure, le quali ci ricordano probabilmente i bestiarî. La riproduzione che presento a Fig. 10ª è tratta dall’opera del Gori.
[240]
Per ciò che riguarda il piano dell’arena, esso fu evidentemente rialzato. Noi non sapremmo precisare l’epoca; ma possiamo con ogni certezza affermare che ciò avvenne dopo il regno di Domiziano. Pausania, nell’elenco delle opere fatte da Traiano, dice: «theatrum magnum undequaque rotundum», ossia l’Anfiteatro Flavio. Varî scrittori, basandosi su questo passo, opinarono che l’arena fosse stata rialzata da quell’Imperatore. Ed invero, la serie di pilastri di opera quadrata di pietra tufacea, che noi vediamo disposti regolarmente a brevissima distanza dal primitivo muro di perimetro dell’ipogeo (la cui costruzione ben s’addice ai tempi Traianei), e la riflessione che, abbandonata dopo la morte di Domiziano l’idea della naumachia nell’Anfiteatro, si fosse ben presto pensato a sollevare il piano dell’arena, troppo profondo, affinchè gli spettatori potessero godere completamente le rappresentazioni gladiatorie e venatorie, sembrano favorire l’opinione di quei dotti.
L’espressione di Pausania però è troppo ampia, e fuor di questa, come osserva il Lanciani, non se ne ha altrimenti notizia. Comunque sia, dal complesso delle cose a me pare che l’arena prima dell’incendio avvenuto nel regno di Macrino già fosse rialzata.
Molte parti dei muri dell’ipogeo si vedono risarcite in opera laterizia di un carattere conveniente agl’inizî del secolo III. Questi restauri furono fatti probabilmente da Eliogabalo e da Severo Alessandro, dopo l’incendio. Vi si ravvisano poi evidentemente le riparazioni eseguite nel secolo V da Teodosio II e Valentiniano III, ed i restauri fatti da Teodorico sul principio del secolo VI.
L’idea finalmente proposta da alcuni, i quali vorrebbero che anche i Frangipani abbiano fatto dei lavori nell’ipogeo, non mi pare possa avere fondamento. All’epoca dei Frangipani l’arena era la piazza del castello: ora perchè questa piazza fosse ben livellata non occorreva altro che interrar gl’ipogei!...
Scoperta l’arena, si volle ricercare l’antica cloaca che dall’Anfiteatro portava le acque al Tevere, passando per la valle del Circo Massimo. Il lodato Fea[840] oppugnò questo progetto per essere, dice, «in esecuzione difficilissimo e costosissimo per tanto tratto di strada». Ideò invece di ripristinare la Mèta Sudante, e rendere con quell’acqua e relativa costruzione di fontane un vantaggio ai cittadini di quel rione. La spesa, secondo i calcoli del Fea e del muratore Lezzani, sarebbero state tenuissime; grande invece l’utilità pubblica.
[241]
Nessuno di questi progetti fu messo in esecuzione; anzi nel 1814 il Governo ordinò di ricoprire gl’ipogei, eccettuandone il passaggio di Commodo.
Nel 1874, ad istanza del Comm. Rosa, si ripristinarono gli scavi nel Colosseo[841].
A settentrione, sotto il podio, tornarono in luce i tre ambulacri circolari, già scoperti dal Valadier; ed il Gori[842] s’affrettò anch’egli a dare il suo giudizio sull’epoca di quei muri. «Questa costruzione, dice, che poco si adatta colla regolarità usata nelle fabbriche del primo impero, dimostra che gli ambulacri vennero edificati dopo il terremoto del VI secolo (?), in un’epoca cioè in cui erano in decadenza, per la irruzione dei barbari, tutte le belle arti» (V. Fig. 8ª).
Da quel che sopra si è detto giudicherà il lettore quanto sia giusto il parere del Gori!...
Alla profondità di circa tre metri apparvero 32 delle 72 mensole di travertino, sporgenti dai piloni delle nicchie poc’anzi descritte (V. Fig. 9ª).
In questo stesso scavo tornarono in luce i cripto-portici, il pavimento, le bocchette[843], le scale, ecc., di cui già parlammo nel capit. III, Parte I, ed i residui seguenti:
1º Varî rocchi marmorei, due dei quali di giallo antico.
2º Fusti di colonne, basi e capitelli.
3º Frammenti d’iscrizione, i quali riporteremo all’App. II di questo lavoro[844].
4º Lucerne fittili, tra le quali una cristiana. L’Armellini[845] così la descrive; «Fra la varia suppellettile tornata alla luce degli sterri dell’arena nell’Anfiteatro Flavio, merita particolar attenzione una lucernina cristiana adorna di storiche e pregevoli rappresentanze. La lucerna, di cui io parlo, manca di circa una metà rimanendone abbastanza conservato il disco sul quale si vedono effigiati i tre giovani ebrei in atto di negare l’adorazione alla statua aurea di Nabucco. Il concetto artistico è identico a quello che trovasi ripetuto frequentemente nei sarcofagi cristiani ed anche in taluna delle pitture delle romane catacombe. Più raro a trovarsi un tal soggetto è nelle lucerne cristiane, ed è per questo che propongo all’attenzione dei dotti cotesto [242] non dispregevole cimelio, il quale può aggiungere alcun lustro benchè assai tenue alle grandiose memorie cristiane del Colosseo».
5º Sei basi di statue ed un bassorilievo rappresentante un coniglio agguantato da una zampa di leone scherzante.
6º Nove teste di statue e sette lastre di marmo[846], le quali ultime hanno uno speciale interesse per i graffiti che in esse scorgiamo. Nella prima di queste lastre si vedono a graffito le cinque arcate, le inferriate e la transenna, ecc., di cui sopra parlammo (V. Fig. 10ª).
Nel secondo graffito vi sono tracciati due gladiatori; l’uno è munito di scudo quadrilatero, l’altro armato di coltello e rete, ed ambedue sono galeati. In questa scena è forse rappresentata la lotta fra un Trace od un Mirmillone con un Reziario, giacchè si scorgono assai chiaramente il tridente ed il balteus[847]. V’è poi una lepre inseguita da un cane; e più in basso un toro avente sul dorso una specie di sella: scena che ci ricorda il sarcofago rinvenuto nel palazzo Fiano, negli scavi eseguiti nel 1874-75.
In un terzo graffito è delineata la figura di un bestiario, avente nella mano destra il venabulo e nella sinistra la mappa.
Il quarto graffito[848] rappresenta l’arena divisa in due parti. Nella prima parte scorgesi un bestiario armato di lancia e lottante con due orsi. Nella seconda, una fiera che trascina una corda, porta un palo al petto e s’azzuffa con un’altra belva sciolta; mentre l’arenario, appoggiando il piede destro sul dorso di una fiera, è per colpire con la lancia un’altra belva fuggente.
Il quinto graffito, fatto in un masso di cipollino, rappresenta un atleta, il quale colla destra stringe una palma, simbolo della vittoria[849], e sul petto gli scende una doppia collana[850], torques gladatoria, da cui pende un ciondolo[851] simile a quello che vedesi nel cippo di Batone. Al sommo della pietra è scritto [FELICI] TER. L’atleta è del tutto nudo, tranne il subligaculum, i calzari, ed alcune fasce alle ginocchia. La figura fu incisa con grosso chiodo: [243] ricordando il PINGIT ZOZZO della Domus Gelatiana, direi, col Prof. Correra[852] che questa figura e le altre sono scariphatae.
Nel sesto marmo v’è disegnata la testa di Diana, adorna di diadema e con frecce in mano.
I diversi sterri ci restituirono finalmente una pietra, in cui è incisa «una
grossa palma, ed altrove, fra alcune palme, leggonsi dei nomi di gladiatori
od atleti come: HONORVS, QVINTIVS, sormontati dal busto, e vi si scorge
l’avanzo di una cartella ansata con le sigle  che potrebbesi leggere PALMA
VICTORI FELICITER; e finalmente il nome di VINDICOMVS»[853].
che potrebbesi leggere PALMA
VICTORI FELICITER; e finalmente il nome di VINDICOMVS»[853].
«Il Comm. Rosa, onde meglio far vedere le vesti, i calzari, le armi, le fisonomie dei gladiatori, ecc., dipinse a nero l’incavo dei singoli rilievi»[854].
Più tardi si scavarono le cavee delle fiere, e vennero scoperti gli ambulacri della parte meridionale degl’ipogei dell’Anfiteatro; e si misero a nudo le costruzioni laterizie e di tufo, nonchè le mensole di travertino, simile a quelle del lato opposto. Oltre a ciò si rinvennero altri capitelli e rocchi di colonne; nello stanzone poi che trovasi a destra del cripto-portico orientale, e in due ambulacri dell’arena furono trovate varie tavole di legno, le quali «o sono residui di macchine o vi furono poste per togliere l’umidità del pavimento»[855].
Nell’ambulacro centrale, finalmente, si rinvennero grosse e lunghe travi, rafforzate da travicelli messi a traverso, ora del tutto scomparse.
Nell’Iconografia del suddetto Gori vediamo disegnate alcune costruzioni che attualmente non esistono. Questa mancanza si deve al direttore di quegli scavi, il quale «troncò quei muri, credendoli più recenti; spezzò i massi di tufo che trovò rovesciati al suolo, e li asportò dall’Anfiteatro»[856].
Essendo Ministro della Pubblica Istruzione il Prof. Guido Baccelli, s’intrapresero, di concerto coll’amministrazione comunale di Roma, grandiosi lavori di sterro[857], onde la parte esterna e più conservata dell’Anfiteatro Flavio possa essere ammirata in tutta la grandezza delle sue proporzioni e nella magnificenza della sua architettura.
Gli scavi s’incominciarono sulla piazza che guarda la via di S. Giovanni in Laterano, e precisamente dal punto corrispondente all’estremità dell’asse maggiore [244] dell’Anfiteatro; e furono continuati, per una zona larga circa trenta metri, tutt’attorno al monumento. Questi lavori diedero risultati di non lieve importanza; giacchè tornarono in luce cinque degli antichi cippi terminali, dei quali già parlammo nella PARTE I, cap. III; il lastricato di pietra tiburtina, che girava intorno all’Anfiteatro e che costituiva una zona annessa al lastricato stesso; nonchè il primitivo pavimento stradale, formato di poligoni di lava basaltina.
«A Nord dello stesso Anfiteatro, sul declivio dell’Oppio, avvenne poi un’altra importante scoperta. Alla distanza di m. 18 dal Colosseo e allo stesso livello di questo, tornò in luce la strada che dalle Carine dirigevasi al Celio, seguendo il corso della moderna via Labicana. A Nord della strada rimane una serie di pilastri, costruiti in buon laterizio, le cui basi poggiano sopra un grande masso rettangolare di travertino. Sono decorati da mezze colonne, parimenti costruite con cortina laterizia; ed in origine erano collegati da arcuazioni delle cui imposte restano tuttora alcuni avanzi. Cotesto porticato, la cui costruzione presenta i caratteri propri delle fabbriche della seconda metà del primo secolo, trovasi sopra una linea parallela all’asse maggiore dell’Anfiteatro, ed il suo punto medio corrisponde (quasi) all’ingresso dall’estremità settentrionale dell’asse minore»[858].
Dopo gli scavi testè descritti, nessuna importante esplorazione, che mi sappia, è stata intrapresa nel Colosseo.
[245]
Prima di rispondere a questo quesito e di presentare al lettore le varie opinioni su questa scabrosa questione, mi sia lecito premettere che ai tempi di Domiziano, fratello e successore di Tito, l’Anfiteatro Flavio fu positivamente inondato, vi si fecero giuochi nell’acqua, e vi si diedero indiscutibilmente battaglie navali. Gli epigrammi XXIV, XXV, XXVI e XXVIII del libro Spectaculorum di Marziale, e le parole di Suetonio[859] non ammettono obiezioni di sorta[860]. Ciò premesso, diciamo:
Nelle solenni feste augurali date da Tito in occasione della dedicazione della venerabile mole dei Flavî, l’arena anfiteatrale fu inondata, e vi si eseguirono naumachie. Il fatto lo deduco dalla narrazione di Dione[861] il quale scrisse: «E dedicando il teatro venatorio ed il bagno che porta il suo nome, diè (Tito) molti spettacoli e straordinarî. E molti gladiatori pugnarono a duello, molti in truppa in battaglie terrestri e navali: conciossiachè avendo fatto riempire all’improvviso quello stesso teatro di acqua, v’introdusse cavalli e tori, ed altri animali mansueti ammaestrati a fare entro l’acqua tutto ciò che erano assuefatti a fare sulla terra e v’introdusse sopra barche anche uomini, e questi ivi combatterono divisi in Corintî e Corciresi»[862].
La testimonianza di Dione trova un’eco nell’epigramma XXVIII di Marziale[863]. Qui il poeta cesareo esalta enfaticamente l’Anfiteatro-naumachia dei [246] Flavî, dicendoci che in questa Mole si fecero tali giuochi in acqua che nè nella naumachia d’Augusto nè nel Fucino nè negli stagni neroniani si sarebbero potuti eseguire. Oltre alla corsa di carri e alle battaglie navali, egli novera il manovrar dei quadrupedi entro l’acqua, ed aggiunge che le dee marine Teti e Galatea avean veduto fra le onde della Flavia naumachia, bestie a loro ignote:
. . . . vidit in undis
Et Thetis ignotas et Galatea feras;
le quali altre non furono che «i cavalli e tori ed altri animali mansueti, ammaestrati a fare entro l’acqua tutto ciò che erano assuefatti a fare sulla terra», come appunto ci dice Dione.
Sebbene i citati autori siano sufficientemente chiari nei loro scritti, nondimeno alcuni, ad es., il Marangoni ed il Gori, basandosi sul silenzio di Suetonio relativamente ai giuochi navali dati da Tito nell’Anfiteatro in occasione delle feste inaugurali di quel monumento, han dubitato dell’asserzione di Dione. Il primo[864] sostiene che la battaglia navale rappresentata in Roma nella dedicazione del Colosseo ebbe luogo unicamente nella vecchia naumachia; che l’inondamento dell’Anfiteatro ed i giuochi, ivi dati nell’acqua e narrati da Dione, furono eseguiti in altro tempo; e termina (vedremo con quanta poca saggezza) rinnegando l’autorità del greco storico. Nè è facile comprendere come egli (il Marangoni) abbia potuto riferire l’ibidem di Suetonio[865] all’Anfiteatro, quando lo stesso Dione ci attesta che, per dar nella vecchia naumachia ludi gladiatorî e cacce, una parte del lago[866] fu coperta con tavolato e circoscritta da steccati di legno.
Il Gori[867] s’oppone parimenti al passo di Dione, ed asserisce che Tito non fè eseguire i giuochi navali nell’Anfiteatro, sibbene e solamente nella vecchia naumachia. Impressionatosi egli della piccolezza dell’arena inondata; pensando non esser possibile che in essa vi si potesse rappresentare il famoso combattimento navale descritto da Tucidide, il quale ebbe luogo nel golfo di Ambracia tra le flotte dei Corintî e dei Corciresi; e credendo che nel nostro Anfiteatro vi si fosse dovuta non imitare ma rappresentare assolutamente al vero la summenzionata battaglia, viene a questa conclusione: «È dunque assai più probabile il racconto di Suetonio: che, cioè, Tito facesse eseguire tutti i [247] combattimenti navali nella vecchia naumachia alimentata dall’acqua alsitina nella valle di S. Cosimato in Trastevere».
Il dubbio mosso dai citati scrittori non mi pare fondato; primieramente, perchè il loro argomento è negativo, e quindi non ha valore; secondariamente poi, perchè nel passo di Suetonio quell’aggettivo applicato a munus in grado superlativo — largissimumque — ha tale estensione da poter abbracciare i ludi gladiatorî, navali e molto più. Che poi Tito abbia data in quella solennità una battaglia navale nel Nemus Caesarum, ossia nella vecchia naumachia, non esclude che quel Cesare l’abbia pur data nell’Anfiteatro: anzi da quell’ET (etiam) navale praelium in veteri naumachia potremmo forse dedurre che la mente di Suetonio sia stata appunto quella di volerci indicare che, oltre alla battaglia navale eseguitasi nella vecchia naumachia, ne fosse stata data un’altra nell’Anfiteatro Flavio, benchè in proporzioni tanto piccole da lasciarla sottintesa. Ed invero: le lotte gladiatorie e le cacce di belve, date nella suddetta naumachia di Augusto, adattate all’uopo in quella circostanza, escludono forse il munus apparatissimum (almeno gladiatorio e venatorio), che, per testimonianza dello stesso Suetonio, si diè nell’Anfiteatro?
Il parere del Nibby[868] conferma la mia opinione. Ecco quanto egli scrive a questo riguardo: «Dione serve di chiosa e dilucidamento a Suetonio, e fa conoscere che questo scrittore non tenendo conto del combattimento navale dato nell’Anfiteatro alluse a quello dato nel Nemus Caesarum colla frase in veteri naumachia, giacchè ivi come notossi fu la naumachia scavata primieramente da Augusto...... Quanto poi al combattimento navale dell’Anfiteatro fu una vera parodia di quella de’ Corintii e Corciresi, descritta da Tucidide»[869].
In conclusione: l’esplicita testimonianza di Dione, l’allusione di Marziale[870] e lo stesso silenzio di Suetonio, il quale con ogni verisimiglianza può contenere un velato accenno, ci costringono a ritenere che nelle feste d’inaugurazione date da Tito, l’Anfiteatro Flavio fu inondato e vi si celebrarono naumachie.
Che nella naumachia di Augusto si eseguissero in quella stessa circostanza battaglie navali, non v’ha dubbio. Gli storici antichi ce l’attestano concordemente. Nella dedicazione dell’Anfiteatro, dunque, si celebrarono giuochi in acqua tanto nella vecchia naumachia quanto nell’Anfiteatro; anzi quelli celebrati in quest’ultimo superarono, se non nella grandiosità nella singolarità, quelli eseguiti nella naumachia di Augusto; tanto che Marziale potè esclamare dell’Anfiteatro Flavio: «hanc unam norint saecula Naumachiam».
[248]
Sennonchè, se è vera la narrazione di Dione e quanto si deduce da Marziale, l’Anfiteatro dovette fin dall’origine essere stato costruito in modo da potervi dare all’occorrenza giuochi in acqua!.... Interroghiamo il monumento, e la sua risposta o smentirà Dione o lo sosterrà.
Abbiam veduto nella Parte III, cap. V, come l’arena dell’Anfiteatro Flavio fu stabilmente sostrutta fin da principio, e che il suo livello, in origine più basso, fu poscia[871] sollevato. Abbiam veduto che il tavolato dell’arena primitiva con la sua armatura in legname poggiava sulle mensole di travertino che sporgono dai piloni, dei quali è fornito il muro di perimetro dell’ipogeo, rimanendo perciò il suo piano ad un livello più basso di circa due metri da quello dell’arena rialzata; e deducemmo, per legittima conseguenza, che dalla soglia delle due porte[872] vi dovette essere un piano inclinato per discendere nell’arena.
Abbiam veduto che gli archi[873] impostati su quei piloni rimanevano fuori del piano dell’arena poco meno della lunghezza del raggio. Osservammo che nella parete di fondo di ciascuna di quelle nicchie, dal piano superiore delle mensole in giù, v’era un’apertura rettangolare a guisa di piccola finestra. Riscontrammo che le volticelle a sesto ribassato, le quali tagliano a metà le nicchie, furono costruite posteriormente, e che, in origine, eran queste vuote dal piano dell’ipogeo alla loro cima (V. Fig. 9ª).
Nello studio del sotterraneo dell’arena osservammo uno speco (V. Fig. 11ª)[874], il quale è situato sotto il pavimento del cripto-portico (Tav. V, lett. K), e si eleva al di sopra del piano dell’ipogeo; si vide che il sistema di cloache per lo smaltimento delle acque e delle immondezze si trova sotto il piano dello stesso ipogeo; e che tutte quelle cloache vanno a far capo ad una di maggiori dimensioni, la quale gira attorno all’Anfiteatro[875]. Da questa cloaca dovette certamente partire un braccio che andava a scaricare le acque nel grandioso collettore emulo della cloaca Massima, il quale corre a piè del Palatino, lungo la via che dall’Arco di Costantino conduce a S. Gregorio[876].
La semplice esposizione della struttura della parte infima dell’Anfiteatro mi sembra renda più che manifesto il pensiero di Vespasiano: d’aver voluto, cioè, costruire la sua mole in modo che si potesse a piacimento inondare. Lo speco anzidetto, come lo persuade la sua orientazione e la sua elevazione rispetto [249] al piano degl’ipogei, fu con tutta probabilità destinato ad introdurre in questi un grosso volume d’acqua, a tale scopo derivando dal castello di divisione, situato sulla piazza della Navicella (per intero od in parte), la quantità della Claudia condotta dal ramo celimontano, il cui speco è largo m. 0,716, alto m. 1,633 fino all’imposta della volticella, che ha m. 0,445 di freccia[877].
[250]
Sul sito preciso di questo castello non può cader dubbio, avendolo il Cassio individuato matematicamente con due coordinate — 90 passi dal portone di S. Stefano Rotondo, e 30 dall’arco di Dolabella. — Questo dotto scrittore ragiona diffusamente del castello suddetto nella sua opera Corso delle acque antiche[878]. Ecco le parole con cui intitola il capitolo: «Degli archi, sui quali condusse Nerone la Claudia sul Celio diramandone un rivo allo stagno dell’aurea sua casa. Questi non furono opra di Claudio. Delli bassi; si mostra il Castello non osservato da moderni antiquari». Di questo lungo capitolo recherò in NOTA i tratti che più c’interessano[879].
[251]
Se il Cassio avesse potuto vedere quello che fortunatamente abbiam veduto noi, lo sbocco, cioè, di quel sotterraneo condotto all’estremità dell’asse maggiore dell’Anfiteatro dalla parte del Laterano, ad un livello superiore al piano dell’ipogeo dell’arena; si sarebbe risparmiato l’improbo lavoro della ricerca di pozzi e conserve nell’altipiano artificiale dell’orto dei religiosi del convento de’ Ss. Giovanni e Paolo, per l’inondazione dell’Anfiteatro Flavio; ed avrebbe senza dubbio ritenuto con noi che Vespasiano, il quale risarcì appunto il condotto della Claudia, si servì dello speco neroniano, che prima conduceva quell’acqua allo stagno, per l’inondazione della sua magnifica mole.
Il Lanciani[880] giustamente nega che questo speco fosse (come si credè quando apparve negli scavi del 1874) l’emissario dei sotterranei dell’arena; ed io convengo pienamente con lui, ed ammetto che le acque vi dovettero correre «dal Celio verso il bacino del Colosseo». Convengo eziandio col ch. archeologo che quello speco abbia servito per uso dello stagno neroniano; ma credo in pari tempo che servisse ancora alla condotta delle acque per l’inondazione dell’Anfiteatro; imperocchè nell’edificazione della Mole Vespasianea lo speco non venne distrutto: ciò che si sarebbe fatto, se più non serviva, a fine di evitare il considerevole ed incomodo dislivello tra il piano del criptoportico e quello delle due lunghe stanze adiacenti e del rimanente degli ipogei.
Quel che più poi mi conferma in questa opinione, si è l’orientamento simmetrico di questo speco rispetto all’Anfiteatro; la qual cosa ci costringe a ritenere o che Vespasiano orientasse l’Anfiteatro relativamente allo speco, o che, con un nuovo braccio, torcesse l’antico andamento di questo per farlo riuscire come ora lo vediamo, vale a dire all’estremità orientale dell’asse maggiore; restando sempre comprovato da quel fatto che Vespasiano si servì dell’antico speco per l’inondazione dell’Anfiteatro. Anzi sarei di parere che appunto lo speco che conduceva la Claudia allo stagno di Nerone, dove si designò d’erigere [252] l’immensa mole, sia stato ii movente nella mente di Vespasiano di un teatro-naumachia.
Il piano del nostro speco è alquanto più basso di quello degl’ipogei. Penso che ciò sia stato fatto perchè con quel battente venisse moderato l’impeto della corrente, impedendo così un urto violento della corrente stessa contro le sostruzioni dell’arena che le si paravan innanzi.
In un tempo più o meno lungo[881] potevansi in tal guisa inondare tutte le cavità dell’ipogeo e far giungere il livello dell’acqua fin quasi a toccare il pavimento dell’arena, sul quale potevansi eseguire liberamente i ludi, senza che gli spettatori s’accorgessero punto del sotterraneo inondamento e potessero prevenire la sorpresa che era loro preparata. Giunto il momento di cambiare scena, cessavano i ludi; s’apriva di nuovo la saracinesca; l’acqua scendea precipitosamente dal castello, e, non potendo salire sull’arena, perchè impedita dal pavimento solidamente assicurato alle sostruzioni, rigurgitava dai trentadue archi delle nicchie, riversandosi sull’arena ed allagandola con un primo strato quasi in un attimo: Amphitheatro de repente aqua impleto[882].
L’acqua andava man mano crescendo; e non s’arrestava il suo sollevamento, se non quando era giunta all’altezza necessaria a sostenere le rates.
Le aperture poi che si vedono nel fondo di ciascuna delle trentadue nicchie, (V. Fig. 9ª), furono evidentemente emissarî per far tornar in secco, in breve tempo, il pavimento dell’arena. Marziale cantò:
Non credis? spectes, dum laxent aequora Martem
Parva mora est, dices hic modo pontus erat.
Il grosso volume di acqua che inondava gl’ipogei veniva, per mezzo di gore sotterranee, scaricato a comodo nella principale. Con tal sistema potevasi far salire e discendere a piacimento il livello dell’acqua sul piano dell’arena; il quale livello poteva variare da zero a pressochè due metri.
L’inondazione di tutte le cavità dell’ipogeo rimuoveva il pericolo dell’abbassamento del voluto livello dell’acqua sull’arena: abbassamento che poteva probabilissimamente avvenire, se, come opinò Lorenzo Re[883], si fosse introdotta l’acqua solamente sopra il pavimento, non giovando certo nè le saracinesche alle porte nè il catrame alle moltissime commessure del tavolato ad impedire il filtramento dell’acqua.
Potrebbesi pur anche immaginare con qualche fondamento che l’inondazione sotterranea fosse stata limitata al solo primo ambulacro curvilineo, nel [253] quale si trovavano le nicchie; chiudendo allo scopo sigillatamente le quattro porte, che da quest’ambulacro mettevano al secondo. La cosa sarebbe stata molto più semplice, meno dannosa; e l’inondazione sotterranea si sarebbe eseguita in più breve tempo. Ma in tal caso rimaneva il pericolo d’accidentale filtrazione dell’acqua nella parte centrale del pavimento. Io ho preferito l’allagamento totale, ma non posso asserire con certezza a qual dei due partiti si saranno attenuti gli antichi.
Un indizio dell’allagamento della parte infima dell’Anfiteatro l’abbiamo nell’incastro che si vede negli stipiti di travertino della porta che dall’ipogeo introduce nel cripto-portico meridionale. Anche gli accessi degli altri tre cripto-portici dovettero avere avuto i loro incastri, a fine d’impedire l’inondazione di quelle vie sotterranee.
E qui è bene avvertire che nell’ingegnoso ritrovato per l’inondazione dell’Anfiteatro, chiaramente manifestatoci dall’esame del monumento, non occorreva munir d’incastri e saracinesche le due grandi porte che immettevano nell’arena; poichè l’acqua saliva dolcemente su i piani inclinati già ricordati, e, giunta al massimo livello, appena lambiva la soglia delle due porte: donde si potevano con agio far discendere nell’acqua bestie e i cocchî, e varare comodamente le barche.
All’allagamento totale degl’ipogei e dell’arena potrebbesi obiettare il danno che ne veniva alle parti lignee ed ai meccanismi; nonchè il tempo e la spesa che occorreva per rimettere ogni cosa allo stato normale.
Obiezione giustissima, ma che per altro conferma il fatto risultato dallo studio del monumento e degli antichi scrittori. Io opino che questa appunto sia stata la causa, se non unica almeno principale, che fè determinare i successori di Domiziano ad abolire per sempre le naumachie dall’Anfiteatro e a sollevare il livello dell’arena.
Verso la metà del secolo XVIII il Cassio s’interessò del calcolo circa la quantità dell’acqua necessaria ad inondare l’arena dell’Anfiteatro Flavio, per darvi naumachie. A questo scopo, dice egli[884], «stimossi opportuno il ricorrere alla nota abilità del P. Boshovitz pubblico lettore di tali scienze (matematiche) nel Collegio Romano. Egli sapeva essere stato scritto in altre occasioni sopra lo spazio ed estensione della medesima Cavea dal sig. Ab. Gaetano Ridolfi espertissimo in geometria, aritmetica ed anco idraulica. Suggerì perciò non potersi trovare di lui più idoneo per soddisfare al proposto quesito. Si compiacque la di lui gentilezza di assumere il laboriosissimo incarico, e dopo serî riflessi ne stese la dotta operazione nel foglio che si aggiunge al § 7, pagina 134».
[254]
In sostanza, il Ridolfi venne a questa conclusione: che per allagare l’arena dell’Anfiteatro (ritenuta non sostrutta) all’altezza di 10 palmi architettonici, pari a m. c. 2,23 (altezza abbondante perchè possano galleggiare le barche, ma da lui supposta, perchè, come egli scrive: «le navi e gli uomini che si sommergessero non avessero a recare impedimento al libero andare dei naviganti)», occorreva un volume d’acqua di barili 139784, pari a m. c. 8134,784. — Si deve avvertire che il Ridolfi suppose l’arena, allora interrata, alquanto più ampia di quella che realmente era.
Lorenzo Re, il quale sostenne l’arena sostrutta fin da principio, e la suppose inondata soltanto sopra al pavimento, disse che a sostenere le barche erano sufficienti tre o al più quattro piedi d’acqua: vale a dire m. 1,18 il massimo.
Per noi (posta l’arena al piano dei mensoloni e stabilita la superficie massima dell’acqua all’altezza di metri due dal piano del tavolato) occorrerebbe un volume d’acqua di 6400 m. cubi. Ma non pare che vi sia stato bisogno di tanta altezza nè di tanto volume. Le barche infatti che dovevan solcare il piccolo mare anfiteatrale, non poterono essere di grande mole nè cariche di molti uomini; ma sibbene di limitate proporzioni, e, come bene osserva il Gori[885], non più lunghe di 5 metri; nè forse ebbero più carico che di un otto uomini ciascuna fra rematori e combattenti.
La portata dello speco è tale, che in pochissimi minuti l’acqua potea raggiungere i due metri d’altezza sul pavimento dell’arena. Io nondimeno credo che non vi se ne introducesse tutta quella quantità di cui era capace; e congetturo inoltre che a bello studio ne venisse introdotta minor quantità; che questa raggiungesse il livello sul piano dell’arena di m. 1,70 circa, altezza, più che sufficiente a sostenere le piccole barche Corintie e Corciresi; e che l’acqua si facesse affluire in modo, che, per raggiungere questo livello, impiegasse un’ora circa di tempo. Questo lo deduco dall’epigramma XXVIII[886] di [255] Marziale il quale in linguaggio poetico così cantò:..... «Mentre che Nereo apparecchia le sue onde a ricevere le truci navi, pe’ i feroci combattimenti, permette di andare pedestramente nelle liquide acque. Videro intanto Teti e Galatea guazzar nell’onde animali ad esse ignoti; e nell’equorea polvere videro cocchi tratti da focosi destrieri che Tritone stesso credette i cavalli del suo signore. La doviziosa onda Cesarea t’offriva quanto nel Circo e nell’Anfiteatro s’ammira».
Le espressioni poetiche del poeta cesareo vengono a dichiararci che nel tempo del lento sollevamento dell’acqua[887], e mentre questa trovavasi in un conveniente livello[888], s’eseguivano in essa corse di cocchî e giuochi di animali «assuefatti a fare nell’acqua quel che facevano in terra».
L’inondazione degl’ipogei poteva farsi a comodo; e quindi poco c’importa di conoscere il volume dell’acqua necessaria a riempirli ed il tempo che questa v’avrà impiegato. Contuttociò, poste le sostruzioni stabili, si può dedurre che il volume necessario fu circa di un terzo minore di quello che sarebbe occorso a riempire l’intero ipogeo vuoto all’altezza di m. 3,50; ossia occorreva un volume d’acqua di m. c. 7467 circa, ed appena un’ora ed un quarto di tempo.
Opino che simili inondazioni si facessero prima che gli spettatori occupassero i gradi, acciocchè il rumore del grosso volume d’acqua, che si scaricava nel sotterraneo, non tradisse il segreto che si voleva serbare.
E qui mi si permetta manifestare una mia idea circa i varî ludi dati da Tito nell’Anfiteatro, allorquando lo dedicò, e dei quali parla esplicitamente Dione.
Alcuni scrittori opinarono essere impossibile il combattimento delle gru; ed il Casaubono era tanto persuaso di questa impossibilità, che corresse il testo di Sifilino, sostituendo alla gru (γεράυοις) i germani (Γερμανοὺς). Il Reimaro s’oppose a questa correzione, ed io non vedo l’assoluta impossibilità di quel combattimento. Chi di noi non sa che i volatili e tutti gli animali s’azzuffano fra loro, allorchè vengono a contrasto per una preda? Perchè dunque dovrà sembrare impossibile che le gru, quei grossi uccelli, abbiano potuto azzuffarsi fra loro, molto più se, come è possibile, fossero state antecedentemente ammaestrate, e legate a lungo per una zampa? — Che realmente si eseguisse questo strano combattimento, me lo persuade inoltre lo stesso divisamento di Vespasiano, in voler dare nel suo Anfiteatro giuochi in acqua: divisamento che potè far sorgere in Tito l’idea di completare, direi quasi, la straordinaria [256] rappresentazione, dando un combattimento di nuovo genere; esibendo, cioè, nella solenne dedicazione del nostro monumento, giuochi aerei, terrestri e marini.
Concludiamo:
L’esame del monumento ci ha fatto conoscere la verità della narrazione di Dione; ha confermato il parere del Nibby relativamente al passo di Suetonio, ed ha illustrato splendidamente l’epigramma XXVIII[889] di Marziale, rivelandoci il vero senso di quei versi oscuri. Ora in grazia di quest’esame, intendiamo come veramente nel solo Anfiteatro-Naumachia di Vespasiano Nereus poteva concedere di andare pedester nelle liquide onde, potendo correre sul piano inondato dell’arena (prima che le acque giungessero ad un livello da sopportar le barche) i cocchî, camminare gli uomini e guazzare le bestie; e vediamo come i versi di chiusa, che finora sembravano una puerile incensata, non erano che l’espressione di un fatto vestito di poetiche forme:
Fucinus et pigri taceantur stagna Neronis,
Hanc unam norint saecula Naumachiam.
[257]
Nel secondo capitolo della PARTE I dimostrammo che la voce clypeum, usata dal cronografo dell’anno 334[890], significava scudo rotondo, per lo più di bronzo, coll’effigie scolpita od a rilievo di una divinità o di un eroe o di qualche personaggio illustre; ed aggiungemmo che esso scudo solevasi collocare nelle pareti esterne dei tempî ed in luoghi pubblici. Dimostrammo parimenti che questi clipei ornarono il quarto ordine dell’Anfiteatro Flavio; dicemmo che tuttora si ravvisano i fori nei quali erano fissati quegli scudi, e promettemmo finalmente di dare il nostro umile giudizio circa i seguenti quesiti:
1.º Chi si rappresentò in quei clipei?
2.º Perchè questi non furono collocati in tutti e singoli gli spazi liberi, ma procedeano e si alternavano in una maniera tanto strana?
Eccoci adunque pronti ad esprimere il nostro parere: ma desideriamo che questo nostro giudizio sia ritenuto del tutto ipotetico, e ripetiamo ancora una volta di essere sommamente lieti, se altri potessero dare ai quesiti proposti soluzione più plausibile.
Negli scudi dunque, che anticamente decoravano i tempî e gli edificî pubblici, eranvi rappresentate le effigie delle divinità, degli eroi e dei personaggi illustri. Ora quali di questi soggetti erano effigiati nei clipei del nostro Anfiteatro?
Non pare probabile che in essi vi siano state le immagini delle divinità pagane, tanto perchè gli anfiteatri non erano tempî, quanto perchè, essendo quelle divinità così abbondanti in Roma gentile, l’imperatore Domiziano avrebbe potuto scegliere quaranta di esse e farle collocare in ciascuno dei [258] quaranta spazî liberi del quarto ordine dell’Anfiteatro stesso. Ma noi abbiamo spazî i quali furono certamente privi di clipei!
Oltre a ciò, nell’Anfiteatro Flavio v’erano 160 fornici, e tutti con statue. Ora, se quell’imperatore avesse voluto decorare l’Anfiteatro colle immagini della divinità, avrebbe prescelto al clipeo collocato in alto, la statua posta in luogo più visibile, quali erano i fornici: contentando, in questa guisa il maggior numero possibile della sterminata serie dei Numi maggiori, minori e minimi.
Ma a questi argomenti di convenienza noi possiamo aggiungerne uno di fatto. Negli inizî del secolo XIX, in una escavazione praticata nelle basse arcate del Colosseo, furono rinvenuti parecchi torsi di statue panneggiate, nonchè una bellissima testa di Mercurio, la quale, come leggesi nelle Memorie enciclopediche Romane[891], servì a restituire la famosa statua acefala di questa divinità, che allora ornava il Giardino Pontificio, e che ora ognuno può vedere nel ricco Museo Chiaramonti al Vaticano[892]. Gli artisti esaminarono diligentemente la qualità del marmo, le proporzioni, lo stile; e giudicarono che la rinvenuta testa di Mercurio apparteneva alla statua suddetta[893]; ed oggi, tanto per la sua integrità, quanto per la finezza dell’arte e l’intelligenza dello scultore, quel simulacro forma uno dei principali capi di quell’interessantissima collezione. Ora questo fatto non conferma l’ipotesi che le immagini delle divinità non furono, nel Colosseo, scolpite od a rilievo sui clipei, ma bensì statue marmoree collocate nei fornici?
Escluse le divinità, rimangono gli uomini illustri. Ma i personaggi più illustri dell’Impero furono senza dubbio gl’Imperatori; e questi, a mio parere, vi furono effettivamente effigiati. Io congetturo che Domiziano abbia fatto incidere o fondere undici clipei, quanti cioè erano gli Imperatori che avevano governato l’Impero da Augusto fino a Domiziano stesso; e che poscia, li abbia egli fatti collocare negli spazî liberi esterni del quarto ordine dell’Anfiteatro; curando, per quanto fu possibile, una certa simmetria nella loro disposizione. Sennonchè, onde ottenere questa simmetria, come avrà egli fatto? Se gli Imperatori, e conseguentemente gli scudi, fossero stati dodici, era cosa facilissima il disporli simmetricamente. Bastava fissare tre clipei in ciascuna delle quattro parti corrispondenti ai quattro principali ingressi dell’Anfiteatro. [259] Ma gli Imperatori, e quindi i clipei erano soltanto undici! Ed allora?....
I fori o le tracce superstiti mi sembra possano dare un indizio del modo con cui Domiziano sarà riuscito a raggiungere, per quanto fu possibile, questa simmetria. Secondo la nostra ipotesi, i clipei sarebbero stati undici. Faceva dunque mestieri decorare uno degli ingressi con due soli clipei. E poichè l’ingresso rivolto all’Esquilino era, diremo così, meno nobile, conveniva lasciar questo (come infatti si lasciò) con due soli clipei, anzichè gli altri ingressi dell’asse maggiore e quello dell’asse minore, il quale fu indiscutibilmente decorato, come apparisce dalle medaglie, di uno scudo centrale. Noi dalla parte dell’Esquilino troviamo le tracce dei clipei in due spazî liberi, egualmente distanti dall’ingresso centrale; e questi spazî si trovano sui fornici corrispondenti ai numeri XXXV e XLII. La disposizione di questi due degli undici clipei c’invita a congetturare che dalla parte opposta ve ne siano stati collocati altri due, e alla stessa maniera relativamente all’ingresso imperatorio. Anzi in quella parte che guarda il Celio ve ne dovette essere un terzo, il quale, come apparisce dalle medaglie dei Flavî, trovavasi nello spazio centrale (V. Fig. 12.ª).
Ora ragion vorrebbe che sugli altri due ingressi dell’asse maggiore fossero stati collocati gli altri sei clipei: tre in ciascuna parte, e allo stesso modo disposti. Ma se la presenza dei fori allo spazio corrispondente al numero XXIII ce lo persuaderebbe, la mancanza dei fori allo spazio LIIII della parte opposta ce ne dissuade assolutamente; e ci spinge a ritenere che in queste due parti non vi poterono essere più di due clipei. Dico non più di due clipei, perchè immaginandone noi tre, l’uno tanto prossimo all’altro, ne sarebbe venuta una disposizione troppo difforme da quella che avevano i tre clipei nel centro della parte più nobile; mentre se noi ne immaginiamo soltanto due, ai numeri LVI e LIX da una parte, XVIII e XXI dall’altra, detti clipei sarebbero stati distanti fra loro in ciascuna parte, quanto lo erano i tre situati sull’ingresso imperatorio.
Manca ora di trovare il posto degli ultimi due. Io opino che, essendo la parte dell’ingresso imperatorio la più nobile (come ce l’attestano le medaglie, le quali sempre riproducono l’Anfiteatro dalla parte suddetta), i clipei siano stati collocati nei punti intermedî fra i numeri LIX e LXIII, e fra XVIII e IV. Ma non essendo stato possibile collocarli ai numeri LXVI e XI, equidistanti da LIX e LXXIII, e da IV e XVIII, perchè quegli spazî erano occupati dalle finestre; mi sembra ragionevole ritenere che essi fossero stati collocati ai numeri LXVII e X, anzichè agli altri LXV e XII; per la ragione che, collocando ciascuno dei due clipei in quei dati punti intermedî da me prescelti, essi (sebbene alquanto disugualmente distanti dai laterali) sarebbero [260] sembrati posti pressochè ad egual distanza dagli altri clipei, per l’effetto ottico prodotto dall’ovale, più spiccato verso l’estremità dell’asse maggiore e meno verso quella del minore.
Ciò supposto, cerchiamo d’indagare qual ordine si sia potuto tenere nel collocare le effigie di questi undici Imperatori. Io mi permetto congetturare che siano stati disposti per ordine cronologico, ed in questa guisa: al numero LXVII Augusto; al LIX Tiberio; al LVI Caligola; al XLII Claudio; al XXXV Nerone; al XXI Galba; al XVIII Ottone; al X Vitellio; al IV Vespasiano; sull’ingresso imperatorio, Tito; al numero LXXIII Domiziano. Quest’ordine, che pone l’effigie d’Augusto a destra del gruppo centrale, e fa coincidere i clipei dei tre Flavî fondatori dell’Anfiteatro nell’ingresso imperatorio, parmi rafforzi la ragionevolezza della supposta disposizione dei clipei (V. Fig. 13ª).
Ma qui sorge spontaneamente una difficoltà. Oltre ai fori che vediamo negli spazî liberi, corrispondenti alle arcate superstiti che portano i numeri XXXV e XLII, e che hanno aperto la via alla soluzione del problema propostomi, noi abbiamo altri spazî similmente con fori; e questi spazî si trovano precisamente sopra gli archi portanti i numeri XXIII, XXV, XXXI, XXXIII, XL, XLVIII, e L! Come spiegarci questo fatto?... O noi dobbiam [262] dire che questi secondi clipei furono aggiunti successivamente, secondo che si succedevano gli Imperatori; o dobbiam dire che furono aggiunti tutti in una volta. Nella prima ipotesi, non essendovi tracce di clipei in tutti gli spazî liberi, e d’altronde essendo il numero di questi molto inferiore a quello degli Imperatori che succedettero a Domiziano; converrebbe affermare che in un dato tempo si fosse cessato dal collocare nel quarto ordine dell’Anfiteatro le effigie dei reggitori dell’Impero. — Io, non vedendo ragione plausibile di questa cessazione, preferisco attenermi alla seconda parte del dilemma; e trovando opportunissimo il tempo della grande restaurazione dell’Anfiteatro, compiuta da Severo Alessandro, opino che questo Cesare sia stato appunto colui il quale fe’ collocare i clipei tutti in una volta, e, con ogni verosimiglianza, tanti quanti furono gli Imperatori da Nerva (immediato successore di Domiziano) a Severo Alessandro inclusivamente. Questi Imperatori furono quindici, ma i periodi di regno furono solamente tredici, perchè Marco Aurelio e Lucio Vero (161-180), Caracalla e Geta (198-217) regnarono insieme; e ritengo probabile che nei clipei relativi a questi due periodi di regno fossero i due rispettivi Cesari rappresentati insieme, come era solito farsi nelle medaglie e nelle monete. Così vediamo accoppiate le teste di Nerone e Agrippina, di M. Antonio e Cleopatra, di Postumo ed Ercole; e quelle di M. Aurelio e L. Vero, di Caracalla e Geta, le quali nelle medaglie le vediamo l’una di contro all’altra.
Anche qui è necessario investigare il modo con cui Severo Alessandro avrà distribuito i tredici clipei che egli (secondo la mia ipotesi) aggiunse agli undici già posti da Domiziano.
Nella parte superstite del recinto esterno dell’Anfiteatro (la quale è poco meno della metà dell’intero recinto) noi, oltre alle tracce di due dei clipei da me attribuiti a Domiziano, vediamo le tracce di altri sette clipei. Ora, ammessa la mia ipotesi, nell’altra metà ve ne dovettero essere stati altri sei. — Accingiamoci senz’altro ad indagare il posto che essi poterono occupare.
Mentre le medaglie dei Flavî ci mostrano il quarto piano dell’Anfiteatro decorato da tre tondi e quattro rettangoli, una delle medaglie di Severo Alessandro ed una di Gordiano ce lo rappresentano decorato da una serie di tondi, terminata da due rettangoli. Ognuno vede che queste ultime medaglie ci attestano, nel loro linguaggio convenzionale, un aumento di clipei nella parte centrale (sull’ingresso imperatorio), dall’epoca di Severo Alessandro in poi. Basato su questo fatto, colloco un clipeo al numero II ed un altro al LXXV, i quali, aggiunti ai tre Domizianei, formano un numero pressochè uguale a quello dei tondi espressi nelle ultime delle anzidette medaglie. — Le tracce esistenti ai numeri XLVIII e L, nella parte superstite del quarto piano, mi [263] fanno argomentare che altri due clipei fossero stati aggiunti a quelli Domizianei (numeri LXVII e X), occupando i numeri LXV e XII. Gli ultimi due clipei che mancano per compire i sei, li colloco a piombo dei due ingressi posti alle estremità dell’asse maggiore.
Disposti in tal guisa i tredici clipei, ciascuna delle due parti principali (quella, cioè, più nobile — dell’ingresso imperatorio — e l’altra della porta principale, divenuta ai tempi di Severo Alessandro ancora più ragguardevole che per l’innanzi, sì per il tempio di Venere e Roma, sì per il famoso Colosso), quelle due parti, ripeto, sarebbero state decorate con simmetria.
Ci resta ora a vedere con qual ordine Severo Alessandro avrebbe collocati gli Imperatori effigiati nei clipei.
Mi par naturale che, potendolo egli fare, li debba aver disposti cronologicamente, ponendo, cioè, nel primo posto dopo Domiziano Nerva, immediato successore di lui; quindi Traiano, e così via dicendo, fino allo stesso Severo Alessandro. Il fatto poi che questa disposizione dei tredici clipei avrebbe fatto capitare Eliogabalo e Severo Alessandro (i grandi restauratori dell’Anfiteatro) sull’ingresso imperatorio, fra Vespasiano, Tito e Domiziano, mi conferma nella proposta opinione (V. Fig. 13ª).
Osservando la disposizione dei clipei nella parte superstite del quarto piano dell’Anfiteatro, nasce spontaneamente la curiosità di sapere perchè, potendosi disporre i sette clipei aggiunti ai due Domizianei, colla stessa simmetria con cui sarebbero stati disposti i clipei dalla parte opposta, (vale a dire sull’ingresso imperatorio); siano stati invece disposti irregolarmente rispetto all’asse minore.
In questo caso, purtroppo certo, noi non possiamo procedere altrimenti che per arzigogoli; ed io propongo ciò che in questo momento mi passa nella fantasia.
Non si potrebbe opinare che Severo Alessandro abbia trascurata la simmetria che con ogni certezza poteva ottenere sull’ingresso rivolto all’Esquilino, affinchè i tre fondatori ed i due restauratori dell’Anfiteatro non avessero riscontro sopra alcuno degli altri ingressi, e perchè tutti e cinque quei Cesari occupassero la parte più cospicua del recinto? Sennonchè Severo Alessandro pur ottenne, secondo la mia opinione, e subordinatamente al principio propostosi, una relativa simmetria nella parte meno nobile qual’era quella dell’Esquilino.
Difatti: nella parte caduta del recinto (giusta la disposizione da noi immaginata), tra un gruppo di clipei e l’altro restano cinque interpilastri, e cinque appunto ne restano dalla parte dell’Esquilino; talchè potremmo congetturare che in questa parte si sia data agli scudi quella disposizione, onde [264] ottenere almeno la stessa distanza tra i varî gruppi di clipei in tutto il recinto.
Concludiamo:
Che fra un finestrone e l’altro del quarto ordine dell’Anfiteatro Flavio vi siano stati clipei fissi e non posticci, come opinò il Maffei, è certo. Quali soggetti però vi siano stati effigiati, noi non lo sappiamo con certezza; ma fino a che non si dia a questa questione una soluzione più plausibile di quella da me presentata, io riterrò che in quei clipei vi furono rappresentate le immagini degli Imperatori, da Augusto a Severo Alessandro.
[265]
Nell’Introduzione di quest’opera facemmo notare che la venatio fu, fra i Romani, un’impresa ordinariamente libera e volontaria; dicemmo che i padroni talvolta punivano i servi, e la pubblica autorità i delinquenti, obbligandoli a discendere sull’arena e pugnare colle fiere; ed aggiungemmo che se i suddetti delinquenti eran rei di delitti gravissimi e capitali, venivan essi esposti alle fiere legati ed inermi.
È questa una cosa tanto nota, che non ha mestieri di dimostrazione. Gli antichi scrittori, tanto storici che poeti, sì oratori che legisti, ce l’attestano concordemente e ripetutamente.
Ma non tutti i delitti si punivano con siffatte pene; e senza perderci in inutili parole riportiamo le leggi romane riguardanti i delitti e le pene di cui parliamo. Eccole[894]:
1. Qui noctu manu facta praedandi ac depopulandi gratia templum irrumpunt, BESTIIS OBIICIUNTUR.
2. Auctores seditionis et tumultus vel concitatores populi pro qualitate dignitatis aut in crucem tolluntur aut BESTIIS OBIICIUNTUR, aut in insulam deportantur.
3. Lex Cornelia poenam deportationis infigit ei qui hominem occideriti eiusve rei causa furtive facendi cum telo fuerit, quive venenum hominis necandi causa habuerit, vendiverit, paraverit, falsumque testimonium dixerit, quo quis periret, mortisve causam praestiterit; quae omnia facinora in honestiores poena capitis vindicari placuit; humiliores vero aut in crucem tolluntur, aut BESTIIS OBIICIUNTUR.
[266]
4. Qui sacra impia nocturnave ut quem obcantarent, defigerent, obligarent, fecerint faciendave curaverint, aut cruci suffiguntur, aut BESTIIS OBIICIUNTUR.
5. Qui hominem immolaverint exve eius sanguine litaverint, fanum templumve polluerint, BESTIIS OBIICIUNTUR, vel si honestiores sint capite puniuntur.
6. Magicae artis conscios summo supplicio affici placuit, id est BESTIIS OBIICI aut cruci suffigi.
7. Qui patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, patronum, patronam occiderit, etsi antea insuti culleo in mari praecipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur vel ad BESTIAS DANTUR.
8. Lege Julia maiestatis tenetur is, cuius ope, consilio adversus imperatorem vel rempublicam arma mota sunt, exercitusve eius in insidias deductus est; quive iniussu imperatoris bellum gesserit delectumve habuerit exercitumve comparaverit, sollicitaveritve, quo desereret imperatorem. Hi antea in perpetuum aqua et igni interdicebantur; nunc vero humiliores BESTIIS OBIICIUNTUR, honestiores capite puniuntur.
Ora domandiamo: i pagani credettero di rinvenire nei Cristiani qualcuno degli enumerati delitti? Ed in caso affermativo, furono essi damnati ad bestias? E se in Roma furono effettivamente dati alle fiere, in qual punto dell’alma Città eseguivasi la condanna?
***
Tutti sappiamo che fino all’impero di Nerone nessuna legge colpì il Cristianesimo; e non v’ha chi ignori che fino a quei giorni fu esso ritenuto dai gentili per una setta del giudaismo. Giunto il funesto momento dell’incendio di Roma, ordinato, come si legge in Plinio sen., Stazio, Suetonio e Dione[895], dallo stesso Nerone; questi, onde liberarsi dall’infamia di cui l’opinione pubblica giustamente avealo marchiato[896], ne incolpò i giudei. Il volgo ritenne [267] per vera quella voce sparsa; e la calunnia si rese ancor più credibile, quando potè accertarsi che l’incendio avea avuto principio dalle taberne giudaiche, site presso il Circo Massimo, e che i quartieri da loro abitati[897] erano rimasti non tocchi dal fuoco. Ma i giudei ben presto si liberarono da quel terribile incubo, poichè Poppea, seguace dell’ebraismo, istigata dai suoi correligionari, perorò la loro causa. Essa ripetè a Nerone le spudorate calunnie già disseminate dai giudei contro i Cristiani; gli descrisse il cristianesimo quale setta empia ed illegale; aggiunse che il Fondatore della nuova religione era autore di una dottrina malefica, e che insegnava i delitti più empî e nefandi[898], e concluse che l’imputazione dell’incendio di Roma non dovesse ricadere sopra i giudei ma sopra i Cristiani, comunemente ritenuti per una setta del giudaismo.
La perorazione di Poppea produsse effetto favorevole per i giudei, i quali, alla lor volta, riprodussero nei tribunali le più sfrontate calunnie contro i Cristiani, accusandoli di seguire una religione nuova e malefica; di usare sacrifizî umani, cibandosi delle carni dei bambini e bevendo il lor sangue; di praticare adunanze tenebrose e turpi[899], ecc.
I seguaci di Cristo procurarono difendersi: addussero convincentissime prove della loro innocenza e dell’onestà delle loro azioni, e dimostrarono esser una spudorata calunnia quella del preteso versamento del sangue dei bambini nei loro sacrifizî. Ma non poterono discolparsene ancor meglio, giacchè la legge dell’arcano vietava loro di manifestare i misteri della Fede e di ponere margaritas ante porcos: e se poterono attestare solennemente l’insussistenza [268] delle azioni nefande nelle loro adunanze, non poterono però negare di radunarsi in luoghi reconditi e sotterranei, e talvolta in ore notturne; nè poterono negare i portenti che Iddio, per loro mezzo, operava a conferma della verità della nuova religione.
Le prove addotte dai Cristiani non valsero a distogliere i giudici dal condannarli; e, guidati da principî erronei, basati sulle false testimonianze dei giudei, violentati dalla volontà del tiranno, conclusero in senso sfavorevole per il Cristianesimo; dichiararonlo religione nuova e malefica[900], affermarono che i suoi seguaci facevano sacrifizi empi e tenebrosi, ed aggiunsero che i cristiani erano conoscitori dell’arte magica, sediziosi e concitatori dei popoli[901].
In seguito a questa dichiarazione, il nome cristiano fu proscritto; e dai tribunali di Nerone in poi, bastava che il Cristiano confessasse di esser tale perchè non potesse parlare in sua difesa; e l’esser seguace di Cristo equivalse ad una sintesi di delitti. «Sed Christianis solis nihil permittitur loqui quod causam purget, quod veritatem defendat, quod iudicem non faciat iniustum, sed illum solum expectatur, quod odio publico necessarium est, confessio nominis, non examinatio criminis quando si de aliquo nocente cognoscitis, non statim confesso eo nomine homicidae, vel sacrilegi, vel incesti, vel publici hostis (ut de nostris eulogiis loquar) contenti sitis ad pronuntiandum, nisi et consequentia exigatis qualitatem facti, locum, modum, tempus, conscios, socios»[902].
A quei tempi S. Pietro esortava i fedeli alla costanza della confessione della fede, e dalle sue parole apparisce chiaramente che fin d’allora i cristiani venivano sottoposti alle pene stabilite dalle citate leggi: «Nemo autem vestrum patiatur ut homicida, aut fur, aut maledicus, aut alienorum appetitor. Si autem ut Christianus non erubescat, glorificet autem Deum in isto nomine»[903].
Nella seconda metà del primo secolo Plinio giuniore interroga Traiano circa il da farsi contro i Cristiani: «Nomen ipsum, gli dice, etiam si flagitiis careat, an FLAGITIA COHERENTIA NOMINI puniantur?» Questa domanda, come ognun vede, presuppone una legge, e questa fu lasciata intatta da Traiano colla sua famosa risposta: «Conquirendi non sunt, si deferantur et arguantur puniendi sunt»[904].
Adriano vietò che si continuasse la persecuzione dei Cristiani, per aversi egli potuto accertare che eran essi innocenti dei delitti che a quel nome ritenevansi [269] annessi, e sentenziò: «Iniustum esse ut quisquam sine crimine reus constitueretur»[905].
Lattanzio, Sulpizio Severo, Prudenzio ed Orosio, autori rispettabilissimi, non certo coevi ai fatti, ma non più lontani da quell’epoca funesta che di due o tre secoli al massimo (e quindi più autorevoli di coloro i quali nel secolo nostro e nel passato osarono negarlo), ci dicono pur essi che Nerone emanò decreti di proscrizione del nome cristiano, e che i Fedeli, anche dopo la strage fatta da quel tiranno per l’incendio di Roma, venivano tradotti innanzi ai tribunali e condannati perchè seguaci di Cristo.
È dunque indiscutibile che i Cristiani, in virtù degli editti di proscrizione emanati da Nerone e mantenuti in vigore fino a Costantino Magno[906], furono assoggettati alle pene comminate da quelle leggi ai rei: e poichè fra queste non era ultima la damnatio ad bestias, vediamo se i Cristiani siano stati talvolta dati alle fiere.
Ulpiano (secondo Lattanzio) raccolse le leggi in vigore contro i Cristiani: «Domitius, De Officio Proconsolis, libro septimo, rescripta principum nefaria collegit, ut doceret quibus poenis affici oporteret eos qui se cultores Dei confiterentur»[907]. «Questa collezione di leggi, dice il ch. Lugari[908], noi ora non la troviamo nel Digesto, nè potremmo trovarcela; poichè nel riordinamento della legislazione romana fatto da Giustiniano, tutte le leggi emanate in onta del Cristianesimo furono espulse. Per questa sola riflessione cade la poco seria sentenza di alcuni moderni che ritengono aver errato Lattanzio[909], senza pensare che Lattanzio, avendo vissuto sotto Diocleziano, sarebbe stato testimonio de auditu ed anche de visu di quel che diceva».
Poste adunque le leggi, i contravventori alle stesse dovean esser puniti; e perchè fossero puniti, dovean essere ricercati dalla pubblica autorità, giacchè è dovere di ogni magistrato scovare i delinquenti, onde purgarne la società. Nell’Impero romano non mancò nè potè mancare questa doverosa vigilanza; chè ogni buon preside, dice Ulpiano, «sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquidere debet, et prout quisque deliquerit in eum animadvertere». Balduino[910] commentando un passo di Cicerone, nell’orazione pro Roscio Amerino, [270] esce in queste parole: «Egli è peraltro vero che ai Romani piacque di comandare che in mancanza di accusatori i magistrati stessi facessero la inquisizione dei colpevoli, e fossero nel medesimo tempo accusatori e giudici».
Quel «conquirendi non sunt» di Traiano a Plinio, è una bella conferma della ricerca che facevasi dei rei; e una conferma ancor più chiara la troviamo nella nota fuga dei Cristiani all’inasprirsi delle persecuzioni: fuga di cui ci rendono certi Tertulliano[911], Origene[912], S. Cipriano[913], e S. Giovanni Crisostomo[914].
Alla ricerca dei colpevoli fatta dalla pubblica autorità s’aggiunga finalmente la schifosa genia dei delatores, sì pagani o giudei che cristiani apostati e fratelli rinnegati; e questi ultimi poi erano, come è chiaro, anche più pericolosi dei primi «periculis in falsis fratribus», perchè potevan essi dare alle autorità gentili copiose liste di nomi e minuti ragguagli sulla novella religione.
Ora, presentati che fossero i Cristiani dinanzi ai tribunali; confessato che questi avessero di essere seguaci di Cristo; potevano per avventura evadere le pene comminate per quei delitti che si ritenevano connessi col nome Cristiano? No, ma si deferantur, rispose Traiano a Plinio, et arguantur puniendi sunt; e i delinquenti, se honestiores, venivano per lo più o decapitati od esiliati; e gli humiliores (e talvolta anche gli honestiores) erano o crocifissi o condannati ad bestias.
Il popolo ritraeva grande sollazzo dall’assistere a quest’ultima pena, e bramava tanto di vedere un tale spettacolo, che, come ce l’attesta Tertulliano[915], per il più piccolo motivo domandava ai magistrati che si gettassero i Cristiani alle fiere: «Si Tiberis ascendit in moenia, si Nilus non descendit in arva, si coelum stetit, si terra movit, si fames, si lues; statim Christianus ad leonem acclamatur». Il popolo romano avea, a tale riguardo, privilegi speciali. Nel Digesto leggiamo: «Ad bestias damnatos favore populi praeses dimittere non debet: sed si eius roboris vel artificii sint, ut digne populo romano exhiberi possint, principem consulere debet»[916].
Ai tempi dell’Impero i cittadini romani erano esenti per legge dalla damnatio ad bestias; i Cristiani però furono ben presto condannati a quella pena, qualunque si fosse la loro condizione. Così, ad esempio, in Lione nell’anno 177, reclamante populo, fu condannato ad bestias un Cristiano il quale era cittadino [271] Romano. Gli stessi Imperatori si dilettavano di siffatte condanne; e di Caligola si legge che un giorno, non essendovi in pronto rei da darsi alle fiere, fè prendere alcuni spettatori, e, sospintili nell’arena, diè compimento allo spettacolo. E quanto più prendevan voga i giuochi anfiteatrali, tanto più gli Imperatori cercarono di trovar materia onde più frequentemente celebrarli; e fra i condannati ad bestias vennero annoverati i parricidi, i fratricidi e i rei di lesa maestà: «Etsi antea insuti culleo in mari praecipitabantur, hodie tamen vivi exuruntur vel ad bestias dantur»; e dei rei di lesa maestà leggiamo: «Hi antea in perpetuum aqua et igni interdicebantur; nunc vero humiliores bestiis obiiciuntur, vel vivi exuruntur»[917].
Dagli scritti di Tertulliano e di altri scrittori apprendiamo che, alla fine del secondo secolo, le pene da subirsi dai Cristiani erano determinate dall’arbitrio dei magistrati; ma il fatto ci ha dimostrato che fra quelle non era ultima la «damnatio ad bestias». Onde il condannato venisse meglio dilaniato dalle belve, legavasi ad un palo; e perchè gli spettatori meglio lo vedessero, il palo collocavasi in un punto alquanto elevato. Così leggiamo di S. Policarpo, che ricusò di essere legato (nel rogo) al palo[918]; di Saturo: ad ursum substrictum..... in ponte[919]; di s. Blandina: Blandina vero ad palum suspensa bestiis obiecta est[920]. Questo pulpito o ponte vedesi rappresentato in varî cimelî; come, ad esempio, in una lampada di Cartagine, illustrata dal P. Bruzza[921], nella quale vedesi il disgraziato paziente legato ad un palo che sorge su di un ponte, mentre un feroce leone lo assalisce per dilaniarlo.
Non sempre le belve uccidevano la vittima, perchè per lo più, anzi che di ultimo supplicio, quella condanna serviva per torturare e far soffrire il paziente, usandosi in tali casi di belve ammaestrate[922]. E questa fu forse la ragione per cui s. Ignazio scriveva ai romani che nutriva la speranza di trovare nelle belve tale disposizione, che non gli perdonassero la vita.
È notissimo che i seguaci di Cristo si propagarono in un modo straordinario; e non possiamo negare che il Cristianesimo, specialmente in Roma, abbia avuto uno sviluppo rapido e trionfale. In una lettera, che s. Paolo scrisse ai Romani nell’anno 58 di C., leggiamo il nome di un gran numero di fedeli, ai quali in gran parte erano connesse intiere famiglie. In quella lettera si ricordano infatti i coniugi Aquila e Prisca et domesticam Ecclesiam eorum; Epitteto, Maria, Andronico, Giunia, Ampliato, Urbano, Stachyn, Apelle; quei [272] della casa di Aristobolo; Erodione; quei della casa di Narcisso, Trifena e Trifosa, Perside, Rufo, Asincrito, Flegonte, Erma, Patroba, Ermine, et qui cum eis sunt fratres; Filologo, Giulia, Nereo e la sua sorella Olimpiade, et omnes qui cura eis sunt sanctos[923]; e nella lettera ai Filippesi S. Paolo fa menzione di coloro, qui de Caesaris domo sunt. Nell’anno 64 dell’êra nostra, al triste momento dell’incendio neroniano, fu tradotta innanzi ai tribunali, secondo la frase di Tacito, una multitudo ingens di Cristiani: frase, dice l’Armellini[924] che ha fatto impazzire un povero scrittore straniero, Hochart P.[925], il quale non sapendo, per odio al Cristianesimo, accettare questa testimonianza, ha finito col sentenziare, Tacito essere non un autore genuino, ma uno pseudonimo d’uno scrittore del medio evo!!
Nè per la persecuzione la nuova fede perdè terreno; giacchè, secondo la espressione di Tertulliano, semen est sanguis Christianorum; e talmente s’ingrossarono le sue file, che poco mancò che nell’anno 80, coi nipoti di Domiziano, il Cristianesimo non salisse al trono dei Cesari. Esso combattè gloriosamente per due secoli ancora, e si propagò in tal guisa, che secondo lo stesso Tertulliano, se i Cristiani, ritenuti dai pagani per loro nemici, avessero emigrato in remote parti dell’orbe, i gentili avrebbero avuti più nemici da combattere che cittadini cui comandare[926].
Una prova materiale poi del gran progresso del Cristianesimo in Roma, l’abbiamo finalmente nelle aree primitive e nei cimiteri sotterranei. Nel solo raggio di cinque chilometri dal recinto di Servio Tullio, e senza considerare le aree ed i cimiteri minori, noi troviamo circa 30 cimiteri detti maggiori, i quali tutti furono iniziati non oltre il III secolo inclusive.
Da quanto fin qui si è detto, possiamo dedurre:
1.º Che Nerone proscrisse la religione cristiana, e che colle sue leggi si diè principio all’êra delle persecuzioni;
2.º Che i delitti connessi col nome cristiano erano puniti da quelle leggi con varie pene, e fra queste non era ultima la damnatio ad bestias;
3.º Che i Cristiani furono tradotti dinanzi ai tribunali, sia perchè ricercati d’ufficio dai magistrati, sia perchè accusati dai delatores, o pagani o ebrei o rinnegati fratelli;
4.º Che i seguaci di Cristo furono realmente condannati ad bestias; ed abbiamo addotto, per incedens, qualche esempio[927];
[273]
5.º Che essendo i Cristiani a quei tempi in gran numero, numerose pur dovettero essere le vittime, nel mondo pagano in genere, e nella sua capitale in ispecie.
***
Ma se queste deduzioni sono generalmente ammesse dagli storici, non così concordi sono essi nello stabilire il sito in cui nell’alma Città de’ Cesari si gettavano i Cristiani alle fiere dopo l’edificazione dell’Anfiteatro Flavio.
Alcuni dicono non potersi assicurare che l’arena del Colosseo sia stata bagnata dal sangue cristiano: ed appoggiano il loro argomento sulla mancanza di formali documenti, i quali (dicono) sono necessarî, perchè in Roma v’erano circhi in cui egualmente s’eseguivano i combattimenti colle fiere, e perchè v’erano almeno due anfiteatri. Rispondiamo:
Dicemmo nell’Introduzione che dopo l’invenzione degli anfiteatri, le venationes si eseguirono costantemente in questi; che il circo non venne più usato a tal uopo, perchè poco adatto allo scopo; e che se in qualche caso eccezionale tornò questo ad usarsi per i ludi venatorî, ciò avvenne mentre l’anfiteatro veniva restaurato per danni subiti e causati da incendî, terremoti, ecc. — Ora ci piace aggiungere quanto a questo rispetto scrive il ch. P. Sisto Scaglia[928]: «Veteres antiquitatum romanarum periti, non videntur satis distinxisse inter circum et anphitheatrum, circa praefata spectacula. Ut sim brevis, Demsteri dumtaxat verba citabo: Quamvis autem theatra, circi et alia huiusmodi loca singulares quaeque, ac proprios ludos haberent, et exercitationes [274] cuique loco accomodatas: tamen eadem saepe omnibus in locis peracta sine discrimine fuerunt[929]. Est scilicet in his verbis cur quaeramus quomodo et ludi circenses in amphitheatro et tragoediae vel gladiatorii ludi in circo fierent. Circus Romuli Maxentii, circo Neronis multo inferior, cuius notabiles adhuc ruinae ad tertium circiter milliarium Viae Appiae conspiciuntur, satis ad rem nostram conferret. Sed quid dicendum de maioribus circis? Nemo non videt quam parum eiusmodi hippodromi scenicis spectaculis ludisque gladiatoriis aliisque id genus convenirent, cum exigua tantum pars spectatorum possent ludis gaudere. E contrario in amphitheatris omnes ad unum ludos cernere satis, quocumque in arenae loco agerentur, poterant. Quod autem omnem dirimit difficultatem illud est, quod NULLIBI IN RUINIS HIPPODROMORUM inventae sint caveae ubi belluae asservarentur; eas vero in superstitibus amphitheatris recognoscere adhuc aliquando licet».
Relativamente poi alla seconda ragione che si adduce, e che consiste in ammettere almeno due anfiteatri in Roma, diciamo:
A pag. 31 di questa opera asserimmo che gli anfiteatri stabili in Roma non furono che due: quello di Statilio Tauro ed il Flavio; ed aggiungemmo che il Castrense, se potè chiamarsi nei catologhi anfiteatro, non fu tale che per la forma e non già per la sua destinazione a’ pubblici spettacoli, che mai non l’ebbe[930]. Se noi infatti esaminiamo l’edifizio castrense; se esaminiamo, dico, le sue dimensioni, la rozzezza dei suoi muri ed il sito ove sorgeva, vedremo tosto che un tal edifizio non potè essere stato adibito a scopo di pubblici spettacoli.
Ho detto: le sue dimensioni; giacchè era esso tanto piccolo che in nessuna maniera poteva servire ad accogliere in sè le tante migliaia di spettatori che s’adunavano nell’anfiteatro in occasione dei ludi gladiatorî; ed era assolutamente improporzionato ad una città di pressochè un milione e mezzo d’abitanti, e alla quale in quelle circostanze affluivano genti pur anche da remotissime regioni. L’anfiteatro Castrense non ebbe che il podio ed una precinzione composta di nove soli gradi; e di questo ce ne fa fede Palladio in un disegno, già forse conosciuto dal Durand, ed ultimamente riprodotta dal ch.º Lanciani[931], ove abbiamo le misure già prese dal famoso architetto Vicentino.
Ho aggiunto: la rozzezza dei suoi muri; poichè nella costruzione di quell’edificio il materiale usato fu il laterizio, e quindi di ben poca cosa in confronto coi muri degli anfiteatri Tauro e Flavio, che sono di pietra tiburtina.
[275]
Ho detto finalmente: la posizione od il sito ove sorgeva; imperocchè non fu esso edificato urbe media, come il Flavio, o nel Campo Marzio, come il Tauro; ma fuori delle mura della città, in un luogo di poco conto e affatto incomodo per accedervi.
I classici ricordano gli anfiteatri Taurino e Flavio, ma nessuna menzione fanno del Castrense; e se lo troviamo nei cataloghi, dobbiamo ciò ad Aureliano, il quale ebbe la bella idea di conservarlo, innestandolo nelle sue mura.
Io opino con il Lugari[932] che l’edifizio Castrense altro non fosse che il vivarium, cioè il serraglio delle belve destinate ai giuochi, e la schola dei venatores. «Che questo edifizio fosse il vivario, dice il testè citato autore, è reso evidente da un passo di Procopio nella sua storia della guerra gotica dove questo scrittore narra l’assalto dato da Vitige alle mura di Roma[933]. Dice pertanto Procopio che — Vitige andò con molta gente nei dintorni della porta Prenestina contro quella parte del recinto che i Romani chiamano Vivario, dove le mura erano facilissime ad espugnarsi. — Nel capo poi seguente aggiunge che — ivi il luogo era piano interamente e perciò soggetto agli assalti dei nemici, e le muraglia talmente a mal termine da non poter la cortina opporre gagliarda resistenza; che — v’era in quel punto un muro sporgente per non lungo tratto dalla linea del recinto, costrutto dai Romani dei tempi più antichi, non per sicurezza maggiore, perchè non aveva nè la difesa di torri, nè vi erano stati fatti i merli, nè altra cosa dalla quale si fosse potuto respingere un attacco dei nemici contro il recinto, ma fatto per un piacere non bello, cioè per tenervi custoditi leoni ed altre fiere, dal che questo edifizio fu chiamato vivario, poichè così chiamano i Romani il luogo ove sogliono nudrire bestie non mansuete. Ora essendo indisputabile che l’anfiteatro Castrense si trovi nei dintorni della Porta Prenestina, che faccia parte delle mura sporgendo fuori della linea del loro andamento, che non abbia difesa di torri, non risultando dal suddetto disegno del Palladio, aver avuto merli; vedendosi manifestamente le mura contigue a questo edifizio dalla parte di Levante verso la porta Prenestina, ove innanzi è pianura aver sofferto gravissimi danni, tanto d’essere stato necessario in gran parte ricostruirle, e le mura che si attaccano al Castrense dalla parte di Ponente verso l’Asinaria, ove il terreno è scosceso mostrandocisi tuttora assai ben conservate, ed apparendo nel mezzo del nostro edifizio tracce non dubbie di destruzione, quali dovrebbero esservi state secondo la narrazione di Procopio, e non trovandosi infine altra parte delle mura circostanti [276] alla quale accomodar si possano così bene i connotati lasciatici da Procopio, ritengo d’aver còlto nel segno riconoscendo in questo edifizio il Vivarium. A ritenere pel vivario il Castrense, prosegue il Lugari, non può recarci ostacolo l’esser tal fabbrica di forma ovale, perchè nessuna legge dettata dalla natura della cosa ha mai prescritto dover essere il vivario rettangolare, quale comunemente se la immaginarono gli archeologi: nè osta il suo tipo anfiteatrale, che parrebbe per sè escludere affatto l’idea di celle per custodirvi le belve, avvegnachè vi poterono queste nel caso trovar posto comodo ed abbondante[934]. Anzi io stimo il tipo anfiteatrale essere acconcio assai per siffatto edifizio. Infatti, dovettero i venatores avere la loro scuola ove addestrarsi alla caccia e dove ammaestrare le belve[935]; ma separare il vivario dalla schola dei venatores sarebbe riuscita cosa assai incomoda e pericolosa per il trasporto quotidiano delle belve dal vivario all’arena e dall’arena al vivario qualora i due edifizî fossero stati distinti; dunque dovette avere il vivario nel suo centro l’arena, attorno alla quale, per sua natura di forma ovale, fosser disposte le celle per le fiere. Confortano questa mia opinione le escavazioni fatte dal P. Martignoni nell’anfiteatro Castrense durante la prima metà del secolo XVIII, nelle quali fu scoperta, come dice il Ficoroni che la vide, l’antica platea, ossia l’arena, e sotto questa si rinvennero delle vaste stanze ripiene di stinchi e d’ossa di grossi animali; ecco le sue parole: «portandomi colà, e veduto l’antico piano, restai non poco maravigliato; ma più rimasi sorpreso, allorchè avvisato dal detto P. Martignoni calai per una scala contigua al muro di fuori sotto la platea, e vidi, che ve n’era un’altra più spaziosa ripiena di stinchi, e d’ossa di grossi animali»[936]. Le espressioni del Ficoroni ci fanno conoscere che quest’arena non fu di legno come nell’Anfiteatro Flavio, ma stabile e di murazione; e che quelle vaste stanze sotterranee non servirono per gli usi dei giuochi anfiteatrali, ma per deposito di ossa di grossi animali. Questo fatto rannodato all’altro, del non essersi, nell’escavazione degli ambulacri formati dai muri di sostruzione dell’arena dell’Anfiteatro Flavio, trovata traccia di ossa di animali, mentre stando alla proporzione dei due anfiteatri se ne sarebbero ivi dovute trovare in copia grandissima, ci conduce a ragionevolmente pensare che le fiere uccise nell’Anfiteatro Flavio venissero trasportate nel Castrense, dove date le carni in cibo alle belve che là si custodivano, si gettasse in quei sotterranei il carcame, [277] forse regalìa dei venatores, i quali poi a lor vantaggio avran fatto traffico di quelle ossa: chè fur queste sempre materia di commercio, anche ai nostri tempi; ne’ quali di più a somma vergogna della decantata civiltà del secolo XIX s’andò tant’oltre da far traffico eziandio delle ossa umane su i campi di Crimea. So bene che il Nardini seguito dagli archeologi fin quasi al dì d’oggi pensò fosse stato il vivario in quello spazio rettangolare che trovasi a destra della porta Maggiore lungo le mura esternamente[937]; ma dopo la demolizione delle torri onoriane e d’altre costruzioni che deturpavano il magnifico monumento delle due acque Claudia ed Aniene nuova, la supposizione del Nardini non può più reggersi, avvegnachè il fornice destro che egli stimò fosse la porta principale del vivario, si vide aver servito a tutt’altro, al passaggio cioè della via Labicana come al passaggio della via Prenestina serviva il sinistro. Inoltre la serie dei monumenti sepolcrali rinvenuti presso il detto fornice sul margine destro della Labicana rendono affatto impossibile il vivario in quel posto; dacchè tra l’area occupata dai sepolcri e l’acquedotto di Claudio, che in quel tratto fu incorporato alle mura, non resta che uno strettissimo spazio.
«Ancor peggiore di questa è l’altra opinione la quale fu in vigore tra i secoli XV e XVI, che cioè nell’area del castro Pretorio vi fosse stato eziandio il vivario[938], e questo, come si deduce dalle espressioni di Lucio Fauno e dei suoi contemporanei, lo argomentarono a quei tempi sia per la protuberanza che questo edifizio produceva nelle mura, credendolo perciò il vivario accennato da Procopio, senza badare alla località del tutto diversa in cui lo poneva lo storico, sia per le celle che si vedevano attorno alle mura, le quali allor si pensava fosser covili di fiere; così Lucio Fauno: id ex eo etiam perspici potest quod nonnullae caveae prope moenia videmus manufactae ferarum antris ac lustris persimiles. Il volgo poi appellava quell’area vivariolo, come ci attestano concordemente gli scrittori di quell’età[939], ad eccezione del Bufalini che nella sua pianta di Roma lasciato l’appellativo vivarium all’area del castro Pretorio applica il nome di vivariolum ad alcuni pochi ruderi posti nella vallata al di fuori del suddetto castro[940].
«Siffatta opinione fu confutata dal Panvinio col riconoscere assolutamente in quella grande area quadrata, detta fino a quel tempo castrum custodiae ed insieme vivario, il campo dei pretoriani e conseguentemente in quelle celle le abitazioni dei militi. Fu allora che alcuni pensarono il vivario [278] ricordato da Procopio fosse sorto in quel tratto di terreno che fiancheggia esternamente alle mura il lato sud del castro Pretorio. Ma questa opinione riconosciuta erronea nei suoi fondamenti, per non trovarsi quell’area nella località indicata da Procopio, fu rigettata dal Nardini e dal Nibby, seguiti pressochè da tutti gli archeologi posteriori. Taluno però ai nostri giorni impressionatosi dalla presenza di due grossi muri posti ad angolo retto tra loro nel tratto di terreno suddetto, segnatone uno dal Bufalini nella sua pianta di Roma e l’altro dal Nolli nella sua, e dei quali si potè vedere qualche resto fino al 1872, ha risollevato la vieta idea del vivario in quel posto. Ma da quel che sono per dire si parrà chiaro che quelle muraglie non possono in alcun modo convenire al recinto del vivario ricordato da Procopio; e da prima la lor costruzione di opera quadrata a grandi parallelepipedi di tufa; dico di tufa giacchè ce lo attestano quei massi squadrati adoperati nei risarcimenti delle mura in quel torno, fa rimontare quell’edifizio a tempo anteriore assai alla introduzione dei giuochi anfiteatrali in Roma; e la forma rettangolare di quell’area circoscritta da quei muri tufacei d’opera quadrata fa nascer più che d’altro la idea di un antichissimo campo d’arme in quella località, riconosciuta in tutti i tempi la più esposta agli assalti dei nemici; fin dal tempo di Romolo del quale si legge di aver costituiti due accampamenti attorno alla sua Roma e l’un dei quali appunto su queste alture, e chi sa quell’area non sia propriamente desso forse abbandonato quando fu costruito il famoso aggere serviano; abbandono confermatoci dalla mancanza di un terzo muro che corresse lungo la via, la quale usciva dalla porta Viminale dell’aggere di Servio, e dal prostrarsi, a quanto sembra, di quel lato del claustro, ricordato dal Nolli al di là della detta via, come il chiarissimo Lanciani ha opinato, segnandolo con linee punteggiate nella Forma Urbis; per le quali cose la via anzidetta avrebbe traversato contro ragione l’area in discorso.
«Ed è tanto spontanea la idea che destan quell’area e quei muri, di un accampamento, che lo stesso Lanciani parlando di quella, che esso ritiene pel vivario, esce in siffatte parole: il vivario fu un lungo rettangolo del tipo di un campo romano fabbricato di grandi blocchi di pietra, simile alle baracche della seconda legione Partica ad Albano. Del resto fosse o no questo l’accampamento di Romolo, il certo è che il claustro in questione è di tempo anteriore all’età dell’Impero, e già a quest’epoca abbandonato, essendo che il castro Pretorio, per quel che sopra si è detto di quei muri, ne occupò una parte; e di più i ritrovamenti fatti presso gli avanzi di quelle antiche muraglie, di capitelli marmorei di grandi dimensioni e di lastre di marmo mischio[941] ci dicono che nel periodo imperiale altre fabbriche ancora vi si [279] ergevano. Inoltre trovandosi codesti muri del preteso vivarium in condizioni tali da non potersi supporre lasciati in piedi da Aureliano, è giuocoforza conchiudere che non siano queste le muraglie del vivario. I muri in questione non fecer parte del recinto aurelianeo, chè le mura in quel punto tagliandoli fuori si attaccano direttamente a quelle del Castro Pretorio. Ora supporre che siano stati lasciati intatti a lor posto grossi muri di qualche altezza a contatto del recinto, è supporre un errore strategico madornale, che sebbene si volesse, non si potrebbe supporre in Aureliano, il quale per essere rimasto il circo di Eliogabalo a contatto delle mura lo fece appunto abbattere per tal riguardo; dunque dovettero questi muri essere stati demoliti da Aureliano, se pure a quel tempo erano in piedi, e perciò non furono le muraglie del vivario. Nè per attestarcene la esistenza in pieno essere ai tempi di Aureliano giova appellare alle piante iconografiche ed alle prospettive del secolo XVI, chè per quanto uno voglia mettere a lambicco il cervello per ritrovarveli non gli sarà mai dato. Vegga chi lo desidera le piante iconografiche illustrate dal De Rossi, dallo Stevenson, dal Müntz, dal Gnoli e dall’Hülsen, che se in talune vi ha segnato qualche monumento estramuraneo, questo lo troverà fuor di tutte altre porte che della Tiburtina. Di più la lunghezza di questi muri è talmente grande da contrastare apertamente con quanto del muro del vivario ci narra Procopio, vale a dire che era di breve lunghezza. Oltre di che la espressione dello storico Greco, un muro, mal si addirrebbe a due muri in isquadra. Ma quello che fa assolutamente escludere la ipotesi, che l’area presso il Castro Pretorio fosse il vivario, è la sua situazione. Il vivario, secondo narra Procopio, si trovava nei dintorni della Porta Prenestina, sicchè non possiamo cercarlo oltre la Tiburtina, ma quest’area è al di là e assai al di là della Tiburtina, dunque essa evidentemente non fu il vivario.
«Venendo ora alla seconda parte della mia sentenza, prosegue il Lugari, dico che l’appellativo Castrense dato dai cataloghi a questa fabbrica di forma anfiteatrale ci apre la via a riconoscere in essa la palestra dei venatores e ci conferma eziandio nell’opinione che fosse questo edifizio al tempo stesso il vivario. Ognun sa che la parola castrense accenna a malizia: così era detto peculium castrense quel danaro che il figlio, ricavatolo dal militare, potea ritener come suo. Suetonio dice che Caligola cognomen castrensi ioco, o loco come leggono alcuni, traxit, quia manipulario habitu inter milites educabatur[942]. Militari furono i giuochi appellati ludi castrenses e munus castrense; e similmente la corona castrensis fu detta così perchè premio dei militari. Quando dunque i cataloghi appellano castrense questa fabbrica è sicuro indizio che essa appartenne a soldati: a quale scopo poi loro appartenesse la [280] forma anfiteatrale cel dice chiaro, e tutti gli archeologi lo hanno riconosciuto, a scopo di giuochi[943]. I ludi castrenses ed il munus castrense, giuochi venatorî[944] dati probabilmente dai Pretoriani[945], ci fan travedere che furono essi i soldati ai quali questo edifizio appartenne; e come a costoro veramente appartenesse ed a qual fine ecco in pronto ad insinuarcelo alcune antiche testimonianze.
«Da due lapidi, una dedicatoria rinvenuta sul principio dello scorso secolo presso la porta Viminale[946], l’altra lusoria trovata nel Castro Pretorio[947] apprendiamo che dei Pretoriani v’ebbe una classe dominata dei venatores, il compito della quale era, come dall’assieme dei fatti è lecito ragionevolmente dedurre, non solo di prodursi nelle rappresentanze venatorie, che in date ricorrenze davansi nei loro alloggiamenti[948], e talora in quelle apprestate nei luoghi destinati ai pubblici spettacoli[949], ma eziandio di ammaestrar le fiere ed addestrare alla lotta i bestiarî. Or questi Pretoriani venatores dovettero avere un luogo ove potessero comodamente esercitare sè stessi a lottar colle fiere ed adempiere il loro magistero; ma come non riconoscerlo e per la forma, e per la inettitudine a pubblici spettacoli e per la pertinenza a giuochi militari, nell’anfiteatro Castrense, situato appunto nella regione del Castro Pretorio? — Inoltre questa palestra non avrebbe potuto trovare posto migliore che nel centro dello stesso vivario, dove senza condurre in giro quotidianamente [281] le belve a fin di portarle alla schola dei venatores, le avesser questi avute belle e pronte ad ogni concorrenza.
«Questa ragionevole postura della palestra averla ben compresa gli antichi lo dimostra il fatto, d’essere stato cioè affidato il vivario alla custodia appunto dei Pretoriani, ed il monumento epigrafico che ce lo attesta, col rappresentarci venatori esenti, venatores immunes, far causa comune col custode del vivario, cum custode vivarii, ci conforta a ritenere indivisa la palestra dal vivario.
«Dunque l’applicazione di Castrense data dai cataloghi a questo edifizio di forma anfiteatrale ci è argomento a ritenere che questa fosse la schola dei venatores, e corrobora le deduzioni già fatte, che fosse a un tempo il vivario».
Fin qui il ch. Lugari.
Escluso l’Anfiteatro Castrense, non rimangono in Roma che due anfiteatri stabili e destinati ai pubblici spettacoli: il Taurino ed il Flavio. Ma l’anfiteatro di Statilio Tauro fu, fin dal principio e per la sua scarsa capacità in poco uso. In occasione infatti della vittoria Aziaca, della pretura di Druso, del natalizio di Augusto e della morte di Agrippina, benchè l’anfiteatro di Tauro già fosse edificato, pur nondimeno i solenni ludi non furono celebrati in esso, ma bensì o nel Campo Marzio, entro steccati di legno, o nel Flaminio o finalmente nei Septi; e l’anfiteatro di Tauro andò sempre maggiormente in disuso. Caligola tentò di darvi nuovamente giuochi gladiatorî, ma se ne indispettì per la sua piccolezza di quell’anfiteatro, e, come dice Dione, lo disprezzò: τὸ γὰρ τόῦ Ταῦρου Θέατρον ὑπερεφρόνησε[950]. Per i giuochi che egli diede nell’anno 38 dell’èra volgare, fece chiudere con legnami un’area, e perchè questa fosse più spaziosa, ordinò la demolizione di grandiosi edifizî. Nerone non si curò affatto dell’anfiteatro Taurino, e ne fe’ costruire uno di legno nella regione del Campo Marzio, il quale durò tutto il terzo anno del suo impero. Nel regno di questo stesso Principe arse l’anfiteatro di Tauro[951], e dopo l’edificazione del FLAVIO, non si pensò più a restaurarlo: anzi la nuova e grandiosa mole fece dimenticare, come dice il Nibby, l’anfiteatro Taurino, e d’allora in poi non venne più ricordato dagli storici; e se lo troviamo nei cataloghi, è perchè nel secolo IV ancora se ne conservavano considerevoli avanzi, i quali, secondo il Maffei[952] — appoggiato ad un passo di Cassiodoro[953] — erano forse ridotti ad altr’uso. E lo stesso Maffei opina inoltre che [282] ai tempi di Teodorico già fosse diroccato e passato da parecchio tempo addietro in proprietà privata. Nè sarebbe questo un caso unico nei cataloghi, poichè anche l’anfiteatro Castrense, tuttochè abbandonato e ridotto a far parte delle mura, pur nondimeno se ne fa in essi menzione.
Dunque non rimase in Roma che un solo anfiteatro stabile ed in pieno uso per i pubblici e solenni spettacoli; e questo fu il FLAVIO.
Gli antichi scrittori confermano questa conclusione. Essi infatti non contraddistinguono mai l’Anfiteatro Flavio con aggettivi, ma ne parlano costantemente in modo assoluto. Capitolino, narrando le opere eseguite da M. Antonino Pio, così si esprime: Romae haec extant: Templum Hadriani, Graecostadium post incendium restitutum, instauratum AMPHITHEATRVM. — Lampridio scrive: AMPHITHEATRVM ab eo instauratum post exustionem; e Vopisco: additit alia die in Amphitheatro una missione centum iubatos leones etc.
È questo il modo costante di esprimersi di tutti gli autori; talchè il Maffei[954], in un capitolo della sua Verona illustrata, parlando degli anfiteatri, dice: «Il perpetuo modo di parlare degli scrittori e Cristiani e Gentili fa conoscere a bastanza, come in Roma un Anfiteatro solo era d’uso, ed era in possesso di tal nome; poichè nol distinguono essi con sopranome alcuno; e quando dicono, fu ristorato l’anfiteatro, fu condotto nell’anfiteatro, si fecero giuochi nell’anfiteatro, intendono senz’altro di quel di Tito, il che dimostra come era solo; poichè non soleano a cagion d’esempio dire il Teatro per significare quel di Pompeo, benchè più sontuoso degli altri».
Concludiamo:
Abbiam veduto che le venationes, dopo l’invenzione dell’anfiteatro, si celebrarono ordinariamente e costantemente in questo, e raramente ed eccezionalmente nei circhi.
Abbiam veduto che l’unico anfiteatro, che in Roma era in pieno uso dall’anno 80 d. C. in poi, fu il FLAVIO.
Abbiam veduto che ove si celebravano le venationes, ivi eziandio si gettavano alle fiere i rei, veri o presunti che fossero, di certi delitti; e poichè i reati che si credevano connessi col nome cristiano si punivano, come dicemmo, colla damnatio ad bestias, dobbiam conchiudere che l’arena dell’Anfiteatro Flavio fu bagnata dal sangue cristiano; e che il numero dei Martiri ivi immolati non fu scarso, giacchè la proscrizione del Cristianesimo, proclamata da Nerone, durò fino alla promulgazione dell’editto di Costantino[955].
[283]
Ma se possiamo positivamente affermare (e di questo ne debbono essere persuasi anche i più ipercritici) che l’arena del Flavio Anfiteatro fu bagnata dal sangue cristiano, non così, dopo i — sebbene vacui — sofismi dei moderni ipercritici[956], possiamo dare un elenco specifico dei singoli Martiri. Farebbe mestieri accompagnarlo con un lungo e laborioso studio critico sopra ciascuno di essi[957]. Io mi limito a riprodurre i nomi di quei pochi Martiri, che fino al 1897 comunemente si ritennero immolati nel Colosseo; lasciando ad altri il compito di dimostrare l’autenticità di quest’elenco.
A quest’elenco del Marangoni aggiungerò col Martigny (Dictionnaire des antiq. chrétiennes s. v. Colysée) e col Kraus (Real-Encyclopaedie der christlichen Alterthümer, s. v. Colosseum) S. Alessandro Vescovo, per le ragioni accennate quando si parlò degli oratorî che circondavano il Colosseo[958].
[285]
Il titolo di questa questione farà sogghignare parecchi archeologi moderni. Oggi infatti quasi generalmente si ritiene che la lapide di cui parliamo sia una falsificazione del secolo XVII. Io, a dire il vero, non avrei voluto toccare questo tasto, e volentieri avrei taciuto, se lo studio del Colosseo non mi avesse, quasi direi, trascinato ad indagare l’origine di questa moderna persuasione, e a pesare le ragioni per cui la nostra lapide venga annoverata fra le false. Inoltre, se io avessi saltato a piè pari questa questione, il lettore avrebbe avuto ogni diritto di notare nel mio lavoro una lacuna, e giustamente avrebbe potuto fare delle osservazioni poco benevole a mio riguardo. Non era dunque possibile tacere; e poichè in un’opera di quest’indole, non sarebbe stato sufficiente limitarsi alla semplice esposizione delle varie opinioni, e terminare (come a bello studio feci altrove)[959] con un punto interrogativo, ma faceva d’uopo esaminare criticamente gli argomenti dei dotti; perciò ho creduto conveniente fare sulla nostra lapide uno studio speciale.
Pertanto prego vivamente il lettore di non volersi decidere per la genuinità o falsità della stessa, prima di aver letta per intero la mia dissertazione.
Contradittori non mancheranno certamente; e pensare di persuaderli sarebbe (specialmente ai tempi nostri) pressochè un’utopia. Del resto ricordiamoci che se gli scrittori del settecento non furono infallibili, non lo sono neppure i contemporanei.
Io appartengo al numero dei secondi, e quindi posso ingannarmi. Nondimeno confesso con ogni lealtà che, specialmente nella presente questione, non posso seguire ciecamente nè gli uni nè gli altri; ma voglio studiare spassionatamente la lapide, e, senza preconcetti di sorta, voglio esaminare le ragioni che generalmente s’adducono per dimostrare la genuinità o meno della nostra epigrafe.
[286]
Nè per questo pretendo dire che il mio studio riuscirà completo e sotto ogni rispetto esauriente, no; m’auguro però che esso vorrà richiamare nuovamente l’attenzione degli archeologi in genere e degli epigrafisti in ispecie; affinchè essi, mossi dall’amore di quella scienza che è loro propria, possano tornar sopra una questione che, secondo il mio giudizio, è tutt’altro che risoluta.
Presento nuovamente la riproduzione della lapide tratta dal calco eseguito con ogni cura dal Sig. Attilio Menazzi sull’originale che trovasi nei sotterranei di S. Martina. (V. Fig. 14ª).
Non è mia intenzione fare una storia particolareggiata di questa lapide sepolcrale. Sarebbe cosa superflua; giacchè gli archeologi già sanno che la nostra epigrafe fu rinvenuta nel cimitero di S. Agnese sulla Via Nomentana, negli scavi ivi eseguiti al principio del secolo XVII[960].
Sappiamo pur anche che questa lapide passò poscia nelle mani della marchesa Felice Randanini, famosa raccoglitrice di memorie sacre; che questi fatti ci vengono narrati da testimonî coevi e fededegni, quali sono il Bellori[961] e l’Aringhi[962]; e che il primo di questi scrittori fu un uomo integerrimo per costumi, dotto, e, per quanto lo comportavano i suoi tempi, competentissimo in materie archeologiche[963].
[287]
Nessuno ignora, finalmente, che la nostra lapide più tardi la possedè Pietro Berrettini da Cortona[964]. Presso di lui si trovava quando il Tolomeo la descrisse, il quale, allorchè costrusse il sotterraneo di S. Martina, la fè fissare nelle pareti di quello stesso sotterraneo in cui tuttora si conserva.
Oltre ai citati autori, l’epigrafe «Sic premia servas» è ricordata dal Reinesio[965], dal Bonada[966], dal Fleetwood[967], dal Lam[968], dal Mamachi[969], dal Bianchini[970], dal Mabillon[971], dal Marangoni[972], dal Venuti[973], dall’Orsi[974], dal Marini[975], dal Mazzolari[976], dal Magnan[977], dal Terribilini[978], dal Fea[979], dal Visconti[980], dal Nibby[981], dal Canina[982], dal Piale[983], dal O’Reilly[984], dal Giampaoli[985], dal Gori[986], ecc.
Sebbene tutti questi scrittori ammettano in genere l’autenticità della lapide[987] (non escluso il Gori, il quale, come abbiamo visto a pag. 101, trattò di diminuire quanto più potè il valore della medesima), pur nondimeno non tutti convengono circa l’età e l’interpretazione dell’epigrafe. Passiamo ora ai moderni e contemporanei. Essi sono: il De Rossi[988], il Tomasetti[989], il [288] Promis[990], l’Armellini[991], i Bollandisti[992], il Mantechi[993], il P. Grisar[994], il Rohrbacher[995], il Cinti[996], il P. Scaglia[997].
Tutti questi autori (eccettuati il Tomasetti[998] e il Rohrbacher) ritengono la lapide per falsa[999].
Dalla lista considerevole di scrittori che trattarono la presente questione si deduce chiaramente essere tre le opinioni degli archeologi intorno a questa lapide. Alcuni la dicono genuina, e non posteriore alla seconda metà del secolo I; altri la dicono pure genuina, ma non anteriore al secolo V dell’era volgare; altri finalmente la credono una falsificazione perpetrata nel sec. XVII, o, secondo qualcuno, nel secolo XIV.
Esaminiamo una per una queste disparate opinioni, incominciando dalla più grave: da quella, cioè, che ritiene l’epigrafe per una falsificazione del secolo XVII.
A qualcuno potrà sembrare che quest’opinione possa trovare appoggio sulla sentenza del De Rossi[1000] il quale scrisse: «Christiana res epigraphica, quae corruptricis Ligorii manus effugerat, in redivivum aliquem hac aetate Ligorium videtur incidisse, qui optimis illis viris (Severano ed Aringhi) fucum quandoque fecerit. Ma applicare la sentenza del De Rossi alla nostra lapide, sarebbe fare un oltraggio alla sua scienza e alla sua autorità; giacchè da questa applicazione ne risulterebbe una inverosimiglianza ed una impossibilità morale. Difatti, se fosse vero che quell’ignoto falsario, quel redivivo Ligorio, avesse fatta incidere la nostra iscrizione, egli, con la sua astuzia, sarebbe giunto ad allucinare non solamente quegli ottimi uomini del secolo XVII, quali furono il Severano e l’Aringhi, ma eziandio un altro uomo eruditissimo e dottissimo dello stesso secolo; un uomo amato da personaggi i più distinti, stimato dagli eruditi, encomiato dai Gronovi, dai Mabillon, dai Crescinbeni, onorato [289] da tutti i buoni[1001], sarebbe giunto ad allucinare, dico, il Bellori, il quale assicura che la lapide «Sic premia servas» è neque SPURIA NEQUE RECENS. Inoltre quel redivivo Ligorio, quell’ignoto falsario, sarebbe giunto colla sua astuzia ad allucinare non solo quegli uomini dotti ed ottimi del secolo XVII or ora ricordati, ma anche quelli del secolo seguente XVIII; e così avrebbe allucinato un Mamachi, un Bianchini, un Mabillon, e tanti altri che con essi ritennero la lapide per vera.
Quell’ignoto falsario, quel redivivo Ligorio, sarebbe giunto colla sua astuzia ad allucinare non solo quegli uomini ottimi e dotti del secolo XVII e XVIII, ma anche quelli del secolo XIX, quali furono il Fea, il Nibby, il Visconti ed altri, poichè anche essi dissero che quella lapide è sincera, genuina; e taluno giunse a dirla sincrona. Non basta: sarebbe giunto ad allucinare il Marini, quel grande epigrafista, che lo stesso De Rossi chiamò sommo; e sarebbe finalmente giunto ad allucinare il Card. Mai, gloria della letteratura del secolo XIX; giacchè anche questi approvò e confermò la sentenza del Marini, che aveva detta elegans la congettura del Marangoni[1002].
Ma che un falsario possa arrivare colle sue astuzie ad allucinare tutti i dotti di tre secoli, non esclusi i contemporanei alla scoperta, è cosa non solamente inverosimile ma anche moralmente impossibile. Dunque, ripeto, se la lapide di Gaudenzio si dicesse falsa per la sola sentenza del De Rossi, si farebbe un insulto alla logica, alla scienza e all’autorità dell’illustre archeologo, il quale si protesta che quella sua sentenza era quasi inapplicabile alle lapidi romane di quel tempo, ed aggiunge: «Id interim satis sit significasse Romanas vix paucas hoc saeculo in lucem editas vel chartis mandatas inscriptiones in capitis iudicium fore vocandas».
Nè si dica che questa nostra lapide debba essere annoverata fra quelle vix paucas, giacchè ciò potrà dirsi delle lapidi d’ignota origine, non però della nostra, la cui storia conosciamo, e la quale testimonî fededegni e contemporanei ci attestano aver veduto quasi direi, coi proprî occhi estrarre da un cimitero sotterraneo (elapsis annis-non multis abhinc annis); e dicono averla poscia posseduta la marchesa Randanini, una delle prime raccoglitrici di lapidi; e precisamente in tempi, in cui «la gara di riunire le memorie cristiane non aveva ancora aguzzato l’ingegno degli speculatori»[1003]. Di fronte alle egregie doti di quei testimonî, non si può dubitare della provenienza della lapide; ed è innegabile che questa fu estratta da un Cimitero nel quale, con tutta verosimiglianza, le escavazioni furono fatte a cura appunto della Randanini [290] e dell’Angelelli; il che si deduce anche dal fatto che in una cripta trovata nel cimitero ostriano (?), vi sono molti nomi di Signore che andarono a visitare il cimitero mentre si scavava[1004].
Nè possiamo dire, finalmente, che la nostra lapide appartenga a quei tempi, in cui i negozianti di Roma non già inventarono nuove lapidi, ma spacciarono esemplari moderni più o meno fedeli di epigrafi genuine ed antiche[1005].
Dunque non potremo neppur dire falsa la lapide per quella sentenza scritta dal De Rossi. Più tardi esamineremo le altre ragioni che adduce lo stesso De Rossi per dichiarare falsa la lapide di Gaudenzio.
Ma andiamo innanzi nell’esame degli altri argomenti che si adducono in favore della falsità della lapide. Innanzi tutto faccio avvertire al lettore che le falsificazioni sono assai più comuni e si trovano più facilmente nei codici e manoscritti in genere, che nelle lapidi.
Faccio avvertire inoltre che se vi sono falsificazioni epigrafiche antiche scolpite su marmo, queste erano quasi esclusivamente delle lapidi pagane. Ho detto quasi esclusivamente, giacchè, come già si disse, il vizio delle iscrizioni cristiane sospette, consiste in essere riproduzioni più o meno fedeli di epigrafi genuine ed antiche[1006]: ora riproduzione non è davvero sinonimo di falsificazione!
Da queste due avvertenze deduco che la sentenza di coloro i quali dicono essere la nostra lapide una falsificazione del secolo XVII, è per lo meno inverosimile; e quell’iscrizione sarebbe od il primo, e finora caso unico, od un raro esempio di lapide cristiana esistente, totalmente falsa. Ora per affermare una cosa simile, non basta una semplice asserzione, ma è necessaria una piena, evidente e matematica dimostrazione.
Ma ammettiamo per un momento che si tratti di una falsificazione del secolo XVII. Noi, come abbiam visto, conosciamo la storia della lapide. Fu trovata nel cimitero di S. Agnese, e questo non può negarsi, perchè testimonî fededegni ce l’attestano.
Ora ciò che questi testimonî ci riferiscono viene confermato dai fatti. Si sa con certezza che quando venne in luce la lapide, nel cimitero di S. Agnese, furono eseguiti degli scavi. Questi dovettero restituire, come l’esperienza c’insegna, epigrafi cristiane, le quali poi (per ciò che si è detto di sopra) dovettero andare nelle mani dell’Angelelli e della Randanini; e noi sappiamo, che [291] precisamente nelle mani di questa andò la nostra lapide. L’autenticità dunque dell’iscrizione «Sic premia servas» non può essere contrastata logicamente. E se si ammettesse che l’iscrizione fosse stata falsificata, si dovrebbe pure dimostrare che il falsario, ignoto, ebbe tanto ardire da portarsi per il primo in un cimitero sotterraneo fino allora inesplorato, nonchè l’avvertenza, forse singolare in quel tempo, di scrivere la lapide in questione sopra un marmo di forma cimiteriale, perchè non s’avesse in seguito a dubitare della sua autenticità; nasconderla in quel cimitero; e tutto ciò poi senza alcun utile da parte sua, e senza sua gloria, giacchè scoperta che fu ed estratta, i testimonî contemporanei non dànno lode ad alcuno, nè dicono che alla Randanini costasse molto l’averla[1007]. Ma tutto ciò è inverosimile. L’origine dunque della lapide fa giustamente argomentare che ella non sia falsa.
Dal momento poi della scoperta fino ai giorni nostri la sua storia si potrebbe scrivere senza difficoltà.
Dal cimitero passò alla Randanini, da questa a Pietro da Cortona, e questi, dopo poco tempo, la pose ove tuttora la vediamo. Di qual monumento si conosce con maggior precisione, con più certezza la storia? E questo è un altro argomento per negare la falsità dell’epigrafe.
Ma se la falsità non è probabile nè verosimile, è però possibile; benchè, per quel che si è detto, nego che vi sia possibilità morale.
Ma ammettiamo che vi sia: in questo caso non resta che esaminare l’iscrizione giusta i canoni della critica lapidaria. Prima però che io incominci questo esame, credo opportuno ripetere al lettore che la sentenza che dice falsa la nostra lapide, ha contrario il parere di uomini sommi. Nè intendo parlare degli antichi collettori epigrafici, i quali poterono riunire, senza discernimento, lapidi genuine e false, non altrimenti che i moderni compilatori, i quali ne annoverano fra le lapidi false altre che forse un giorno la sana critica restituirà alla loro vera fede e fra le lapidi sincere. Nè parlo di altri scrittori sotto altro riguardo rispettabilissimi, ma che in materia epigrafica, o in critica lapidaria, non hanno autorità decisiva, come sono il Mamachi, l’Orsi, il Bianchini, il Mabillon, ecc.; nè di quegli archeologi, i quali, sia per ragione di tempo sia per ragione di studio, non potrebbero dare (come direbbero i moderni) adeguato giudizio su antichità sacre, come, p. es., il Fea, il Nibby, il Venuti, il Piale, ecc.; ma parlo di profondi conoscitori di epigrafia, e di epigrafia cristiana, e di letterati, alla cui memoria si farebbe un grave insulto, se si dicesse che eglino non seppero scernere il vero dal falso in questione di epigrafia. Parlo [292] del Marini. Questi la ritenne per lapide genuina, l’annoverò fra le iscrizioni cristiane sincere, e disse elegans la congettura del Marangoni, già da noi riportata al c. III, part. I di questo lavoro. È vero che il Marini non ordinò nè rivide o corresse le sue schede per la gran collezione epigrafica cristiana; ma è pur vero che la nostra epigrafe si trova in quella parte del manoscritto che era la più disposta, direi quasi, per la stampa. Ecco la ragione per cui il Mai la pubblicò senza difficoltà di sorta. Ma in ogni modo è certo che la nostra lapide non fu, come tante altre, trascritta dal Marini per soli suoi fini particolari, ma fu da lui esaminata, studiata, riveduta: giacchè entra nel novero di quelle poche, cui appose nota; e non una nota qualsiasi ma una nota, che, nella sua brevità, rivela la competenza del sommo epigrafista che era.
Il Marini dunque, che nei suoi Arvali (e quante volte ebbe occasione) battè senza pietà il povero Ligorio, ed inveì sempre e veementemente contro i falsarî, non pensò punto alla falsità della nostra lapide; anzi la lodò e ne ammise l’autenticità.
Parlo inoltre del Mai, il quale visse in tempi in cui l’archeologia cristiana aveva già incominciato il suo sviluppo; che aveva ben veduta nella raccolta Mariniana lo studio dell’illustre collettore, il quale, eccezione fatta delle lapidi calaritane, tutte le altre ben aveva riunite per pubblicarle; del Mai, dico, il quale non ebbe difficoltà di riportare la nostra epigrafe e ritenerla per genuina e sincera.
Parlo finalmente del Visconti.
Egli nel 1827 dimostrò la genuinità e la sincerità della nostra lapide e la ritenne come sincrona; nè mai ritrattò la sua sentenza benchè cessasse di vivere nel 1875, quando la sacra archeologia aveva raggiunto il suo pieno sviluppo ed era già ridotta a scienza.
Ritenendo dunque come cosa indiscutibile la falsità della nostra iscrizione s’andrebbe contro la notissima autorità di sommi uomini, epigrafisti, letterati ed eruditi.
Ma, a dire il vero, oggi a questo poco si bada; e solo fanno eco e trovano appoggio facilmente quelle opinioni moderne che tendono a distruggere una qualche tradizione. È vero che i progressi fatti dall’archeologia sacra in questi ultimi anni, sono notevoli, ma è anche vero che non hanno gettata nuova luce sulla nostra questione.
Le cose si trovano allo stesso punto, e le difficoltà purtroppo sono sempre le stesse! Non resta per tanto che esaminare criticamente la lapide.
***
Uno dei maestri della critica lapidaria, non v’ha chi l’ignori, è il Maffei.
È vero che oggi si ritiene che i suoi canoni siano applicabili alle sole lapidi pagane, e si opina aver egli errato nello studio delle lapidi cristiane. Ma [293] se noi esaminiamo i suoi canoni, e con riserbo facciamo qualche distinzione, mi sembra che essi possano anche applicarsi alle lapidi cristiane.
Infatti, nella sua Arte critica lapidaria[1008] il Maffei stabilisce certi criterî, coi quali egli insegna il modo di distinguere le iscrizioni vere dalle false; e dice che di due specie sono gli indizi per i quali si possono riconoscere le une dalle altre: ALTERA PRACTICA, uti vocant, ab ipsa monumentorum inspectione petita; INTERIORA ALTERA et ab iis quae continentur desumpta.
Gli indizî estrinseci, secondo lo stesso autore, sono: genus, facies, color; e segue spiegando ciò che per essi s’intende. I secondi poi, ossia gli intrinseci, sono: la troppa antichità della lapide, la singolarità delle formole, i punteggiamenti e cose simili.
Ora è evidente che i primi, vale a dire, i canoni estrinseci, siano applicabili anche alle lapidi cristiane.
Un’iscrizione cristiana scolpita su di un marmo, la cui facies et color mostrino essere marmo moderno, si dirà giustamente falsa[1009]. Lo stesso si dica di una lapide sepolcrale cristiana (il cui genus è cimiteriale), se questa per la paleografia si dovesse riportare ai secoli VII e VIII. Viceversa: una lapide che per la sua iscrizione dovremmo creder dell’epoca in cui i cimiterî sopratterra erano rari, e di cui quindi il genus dovrebbe essere cimiteriale; se essa presentasse la forma ossia il genus delle lapidi non cimiteriali, non si potrà recisamente ripudiare, ma si potrà dubitare della sua sincerità.
Dunque questi dati estrinseci, che c’insegna il Maffei per distinguere le lapidi vere dalle false, mi sembra possano applicarsi anche alle lapidi cristiane.
In quanto poi all’indizio intrinseco principale (la paleografia), volendo il Maffei che si usi circa di esso somma cautela e che mai sia disgiunto dagli indizî estrinseci, è indubitato che valga eziandio (non certo assolutamente e disgiunto dagli altri) anche per le lapidi cristiane. E il De Rossi[1010] c’insegna: «Egli è innegabile, ed anche i più circospetti e peritosi epigrafisti lo confermano, che l’argomento paleografico, adoprato con giudizio, ha molto valore».
Dunque i dati estrinseci posti dal Maffei possono aver forza nell’esame delle lapidi cristiane sospette. I dati intrinseci poi non sono tutti egualmente ed assolutamente applicabili alle lapidi cristiane.
Il Maffei dubita dell’autenticità di una lapide se questa presenta un’antichità assai remota. Ma questo criterio non può applicarsi alle epigrafi cristiane, delle quali ve ne sono molte che risalgono fino ai tempi primitivi della Chiesa e alla stessa età Apostolica. Dunque questo canone non è applicabile al caso [294] nostro. Dubita ancora di una lapide, se l’epigrafe si allontana, secondo la sua specie, dalla comune formola e dizione. Ma questo canone, se è giusto per le lapidi appartenenti a monumenti romani pubblici e privati, non è così assolutamente applicabile alle lapidi cristiane, le quali, benchè anch’esse avessero, secondo la diversità delle epoche, le loro formole e dizioni, pure, per la singolarità delle circostanze, dei luoghi e degli scrittori, poterono andar soggette, e vi andarono effettivamente, ad eccezioni[1011]. Il Lupi[1012] scrive: «In omnibus facultatibus habenda prae oculis est aurea illa sapientium virorum constitutio qua iuris prudentes in legum oraculis intelligendis utuntur ut semper exceptione aliqua restringenda putent effata veterum, quamtumlibet absuluta, ne forte inopino aliquo casu queat eorum veritas labefactari; omnis namque definitio in iure civili periculosa est, rarum est enim ut non subverti possit quod quidem aliqua prudentes dictum, prudentissime dicitur ubi sermo est DE ANTIQUORUM EPITAPHIIS».
Ciò posto, applichiamo alla nostra lapide tutti quei criterî che si possono ad essa applicare.
Il marmoris color et facies è uno dei criterî estrinseci. Ora il marmo della nostra lapide è evidentemente antico, essendo marmo greco, ed è certamente antico, anche perchè sull’altra faccia della lapide v’è scritta un’altra epigrafe indiscutibilmente antica, e che secondo l’Aringhi, il Fletwood, il Marini ed altri, dice:
AVRELIA AVGVRINA HIC EST[1013].
[295]
Ora questo laconismo, questa totale mancanza di simboli, questo nome Augurina e questo gentilizio Aurelia scritto per intiero, ci fanno necessariamente dire che il marmo su cui è scolpita l’iscrizione non è posteriore al secolo II[1014].
Il marmo dunque su cui è l’epitaffio di Gaudenzio, per il suo colore, per la sua qualità, ecc. può dirsi, senza timore d’essere contraddetti, antico e antico assai, e certamente non posteriore al secolo II.
Nemmeno si può dir falsa la lapide per il marmoris genus, giacchè ha essa tutti i requisiti perchè sia lapide cimiteriale, al cui genus appartiene. L’altezza, la forma, il fatto incontestabile che essa è stata estratta da un cimitero, ecc., son tutte cose le quali ci dicono che essa appartiene indiscutibilmente alla classe delle lapidi cimiteriali.
Alla nostra lapide dunque non mancano i requisiti estrinseci perchè essa sia ritenuta per genuina.
Tralascio per ora la questione paleografica, perchè di essa ne parlerò nell’esame della seconda opinione.
Ma fin d’ora faccio notare che la paleografia è criterio fallace assai se si separa dagli altri, come avvertono il Maffei, il Fabretti, il Marini, il Morcelli, e lo stesso P. Scaglia[1015] il quale, appena due anni fa, scriveva: «Criteria omnia ista sese invicem conplent ac confirmant, paucis exceptis casibus, in quibus aut lapicidae imperitia aut alia de causa exceptio datur». E a pag. 58, aggiunge: «Non semper vero e complexu litterarum aetatem erui fas est; nam bene potuit etiam saeculo primo lapicida quilibet, sive ex negligentia, sive ex [296] imperitia, litteras inelegantes describere, et viceversa etc.». E quindi, riconosciuto che per la nostra lapide stanno gli altri canoni citati, s’userebbe l’argomento paleografico senza giudizio[1016], se per questa sola ragione si dicesse falsa.
L’unico criterio intrinseco posto dal Maffei, applicabile alle iscrizioni cristiane, è, come abbiamo veduto, la singolarità: e questa, non si può negare, è veramente applicabile alla nostra.
Se si riflette che l’iscrizione di Gaudenzio, ammesso che non sia riproduzione o falsificazione, dovrebbe essere del tempo dei Flavî, e considerata la specie cui dovrebbe appartenere, essa s’allontana pur troppo da quella semplicità, da quel laconismo, da quelle formole proprie della classe di epitaffi cimiteriali di quei tempi. Ma in questo caso si può, innanzi tutto e con ragione, applicare ad essa l’eccezione di cui parla il Lupi[1017]; e secondariamente quest’epigrafe appartiene a quella specie d’iscrizioni quarum vim ut quis intelligat seiungere eas non oportet ab adiunctis loci, temporis, ac personae quae epitaphium posuit[1018].
Oltre a ciò, quest’iscrizione nulla ha che fare con quelle semplici memorie che vediamo sui sepolcri di un fedele qualunque, od anche di un martire; le quali presentano precisamente un laconismo e una semplicità caratteristica; ma dobbiamo dirla un elogio, un epitaffio di una natura tutta sua propria. Dunque dai canoni estrinseci posti dal Maffei per riconoscere la falsità della lapide, e che sono applicabili alle lapidi cristiane, si deduce che la nostra non è falsa: il canone intrinseco poi, perchè non applicabile a questa per le circostanze della lapide, non può neppure convincerci della falsità della iscrizione di Gaudenzio. Secondo la critica epigrafica dunque, non possiamo dichiarare falsa l’iscrizione «Sic premia servas».
Ma lasciamo il Maffei, ed esaminiamo la cosa secondo i dettami del De Rossi, le cui dichiarazioni, specialmente sulla presente questione, tanto più valgono, in quantochè, come si legge nei suoi Musaici, egli crede la nostra iscrizione una falsificazione dei tempi di Urbano VIII. Ma anche di questo suo parere ci occuperemo tra breve.
Il De Rossi adunque[1019] scrive: «Si distinguono SEMPRE le lapidi incise con cura, secondo la regola dell’arte, da mano perita, del mestiere; da quelle che appaiono tracciate in fretta, senza studio di calligrafia epigrafica o da mano nuova ed inesperta dell’arte lapidaria». Ora è evidente che la nostra epigrafe appartenga alla seconda specie, cioè a quella delle iscrizioni tracciate [297] in fretta, senza studio di calligrafia epigrafica; e non a quella delle lapidi incise con cura e secondo le regole dell’arte. Ma le lapidi appartenenti a questa seconda classe, secondo il chiaro archeologo «niuna impronta hanno di tipo speciale e caratteristico (caso assai raro), ovvero alle lettere dei manoscritti più che all’alfabeto epigrafico ci si mostrano affini».
Dunque la nostra lapide, come quella che niuna impronta ha di tipo speciale e caratteristico, non può dirsi falsa per la sua paleografia non regolare e non comune. Nel cimitero di Domitilla, in mezzo a quattro epigrafi in caratteri bellissimi, il De Rossi ne trovò una scritta in paleografia molto trascurata, perchè incisa da mano imperita: eppure le giudicò tutte contemporanee[1020]. L’illustre archeologo poi, nella sua memoria sul museo epigrafico cristiano Pio-Lateranense, afferma che «il delicato fastidio degli umanisti del quattrocento e dei dotti del cinquecento per l’umile e popolana epigrafia dei primi cristiani, l’ha trovata quasi immune dalla lebbra che tutta ne ha impestata e guasta la parte classica»[1021]. E se vi furono lapidi della cui sincerità può dubitarsi, ciò non può dirsi che di quelle le quali spettano al cadere del secolo XVII, quando cioè, differita l’esecuzione del nobilissimo disegno (ideato dal Boldetti di un museo lapidario cristiano), istituirono privati musei di lapidi antiche segnatamente cristiane, e si studiarono di derivare a loro pro qualche parte di quanto iva in dispersione[1022], il Carpegna, il Bianchini, il Capponi, il Vettori, il Ficoroni, e tanti altri. Ora la nostra lapide era già nota, veduta e scritta, anzi stampata nella prima metà del secolo XVII.
Dunque non può essere compresa nel numero delle false suddette.
Di più: la gara di collettori di lapidi cristiane adescò i venditori a falsare la merce (scrive il De-Rossi).
Ma in che consiste questa falsificazione? Ascoltiamolo dal sommo maestro: «I negozianti di Roma, ai quali solo si faceva capo da ogni paese, spacciarono esemplari moderni più o meno fedeli di epigrafi genuine ed antiche, ed ho trovato essere talvolta avvenuto, che della medesima epigrafe, l’originale rimanesse in Roma, e che copie moderne si fossero in pari tempo spedite una al museo di Catania e una all’arcivescovile di Ravenna».
Dunque la falsificazione, chiamiamola così se si vuole, consistette nel copiare lapidi esistenti in Roma e spedirle fuori, come originali. Ma la nostra, si trova proprio qui a Roma. Dunque, secondo la stessa teoria del De Rossi, essa non cadrebbe nella classe delle falsificate, e sarebbe, in ogni modo, originale. Non basta. È certo, e niuno potrà negarlo (e questa vedo sia la ragione [298] principale su cui si basa la sentenza od opinione che discutiamo), che la nostra lapide è una singolarità[1023]. Ora, considerato che gente fossero i falsarî od il fine che essi si proponevano, il nostro marmo come potrà dirsi falso?
I falsarî, l’ho detto poc’anzi colle parole del De Rossi, veduta la gara dei collettori di lapidi cristiane, ingannarono specialmente i lontani col formare esemplari più o meno fedeli di lapidi genuine e sincere. Non inventarono dunque nuove lapidi, ma soltanto copiarono più o meno fedelmente dagli originali. Ora la nostra lapide, non essendo copia più o meno fedele, ma originale, non può dirsi falsa. Ed il fatto di essere essa nella sua dicitura affatto singolare, esclude l’ipotesi di una falsificazione. Lo scopo dei falsarî, è notissimo, era il guadagno; e a questo fine, astutamente facevano esemplari più o meno fedeli. E appunto per il lucro, dovettero essi incidere le lapidi in modo che la loro merce fosse sicuramente spacciata. E per spacciarla più facilmente mandavano fuori di Roma copie più o meno fedeli delle lapidi esistenti. Ma se anche avessero inventato tutto di sana pianta i falsarî, avrebbero certamente procurato di non allontanarsi troppo dalle formule esistenti e conosciute; molto più che quegli esemplari si spedivano a raccoglitori i quali spessissimo erano eruditi. E gli eruditi, ammaestrati forse dall’accaduto ai raccoglitori delle lapidi pagane, dubitarono ancora delle cristiane; ed una prova l’abbiamo appunto nella nostra lapide. Il Bellori dice che quest’iscrizione è neque SPURIA neque recens. Si vede dunque che ai suoi giorni v’erano lapidi spurie e recenti, e che gli eruditi l’esaminavano attentamente per non essere tratti in inganno! Gli spacciatori dunque e i falsarî dovevano avere un interesse speciale di formare le lapidi in modo che a prima vista non facessero dubitare della loro sincerità.
Ma se questo dubbio, di fronte a una lapide non comune, sorgeva lontano da Roma, con quanta più ragione non sarebbe sorto in Roma se i falsarî avessero voluto spacciare una lapide, la quale, come la nostra, è tutta propria, eccezionale, singolarissima? Dunque, ripeto, il fine stesso propostosi dai falsarî, e la singolarità della lapide, escludono la sua falsità.
Non mi pare infine verosimile che un falsario del secolo XVII, senza avere dati di sorta, atti, ecc., potesse giungere a scrivere un epitaffio così veemente, tanto espressivo, così significante, che corrispondesse a qualche dato storico, quale è il nostro. A me pare, per la ragione che son per esporre, che quello non possa essere stato dettato se non da colui il quale si trovava presente ad un atto sommamente indegno di chi lo commetteva, ed evidentemente ingiusto verso di colui che lo riceveva. Infatti, qui lo scrittore rimprovera Vespasiano, [299] e lo rimprovera non con espressioni qualsiansi, ma con queste parole: «Sic premia servas»; e a Gaudenzio dice; «Premiatus es morte». Si ponga mente alle espressioni suddette, e si vedrà la ragionevolezza della mia asserzione. Sappiamo che Vespasiano diè premî agli artisti, ai letterati, a tutti quei genî insomma, che facevano qualcosa di pubblica utilità. Si legga Suetonio, e si troverà che quell’imperatore (e non ricorda altri imperatori) premiò oratori greci e latini, premiò poeti, premiò il ristauratore del Colosso di Nerone, ed un meccanico per aver solamente progettato il trasporto d’ingenti colonne al Campidoglio; premiò Apollinare il trageda, premiò Tarpejo e Diodoro citaristi e via dicendo.
Ora è verosimile che un falsario ignoto del secolo XVII, il quale doveva essere certamente astuto, e che cercava non la sua gloria ma soltanto il suo proprio interesse, fosse potuto giungere ad indicare Vespasiano tanto sottilmente, e che (anche ammessa la sua sottigliezza ed astuzia) avesse scritto una lapide, la quale, in fin dei conti, non avrebbe potuto facilmente vendere, per la stessa ragione, che allontanandosi dal solito formulario, l’avrebbero creduta inventata? Inoltre: il presunto falsificatore della nostra lapide, fu un letterato o fu un volgare idiota? Se letterato, come concepire tutti quegli errori? Non avrebbe procurato, per meglio ingannare l’incauto compratore, di adoperare lo stile classico del tempo dei Flavî? Se idiota, come è che conosceva le opere di Suetonio? Ma v’ha di più: il Baronio, nei suoi Annali, ha dimostrato ad evidenza che Vespasiano pretese essere il Cristo, di cui sapeva parlarsi nelle sacre pagine. Ciò posto, quanto non sono espressive quelle parole: «Promisit iste, dat Kristus omnia tibi?».
Egli volle dire: «Promisit iste qui se dicit Christus, at Christus verus OMNIA tibi DAT».
E chi può affermare senza dubitare, che la scienza, la sagacia di un falsario settecentista giungesse a tanto? Questo è moralmente impossibile. È dunque moralmente impossibile che la lapide sia una falsificazione del sec. XVII.
Il P. Grisar[1024] dice che l’iscrizione di Gaudenzio fu fabbricata nel secolo XIV (1300). Meno male! Dal 1700 alla metà circa, del 1400, già siamo tornati indietro di tre secoli! E le ragioni? Le stesse di coloro che la dicono falsificata nel secolo XVII: La paleografia, lo stile dell’iscrizione[1025]. E se si leggono tutti gli autori moderni che parlano di questa lapide, tutti ci ripetono [300] le stesse cose. E quelli che la credono genuina, ma una riproduzione del secolo V, od anche un’eco di una leggenda popolare dello stesso secolo, che argomenti adducono? Gli stessi!!! Ma di questi ultimi ci occuperemo dopo di avere esaminato quanto il De Rossi, l’Armellini, ecc., dicono per dimostrare che la lapide è una falsificazione fatta sotto il pontificato di Urbano VIII.
Il De Rossi ragiona così:
«Poco prima che Urbano VIII facesse erigere dal Bernini il tabernacolo di bronzo sulla Confessione Vaticana, il Salvatore in musaico della sua nicchia fu delineato dal Grimaldi (nel codice Barberiniano XXXIV, 50, p. 250); e l’iscrizione del libro in quell’immagine è assai diversa dalla forma, che ora vediamo e che è fornita di punti sugli I.... L’iscrizione adunque, dopo il disegno fattone dal Grimaldi[1026] fu tutta arbitrariamente rifatta: e ciò deve essere avvenuto[1027] quando Urbano VIII fece eseguire l’opera tutta nuova in musaico ai lati della nicchia le immagini dei principi degli Apostoli e risarcire quella antica del Salvatore.
«Nell’epigrafia cristiana però VERI PUNTI ROTONDI su tutti gli I (non su quelli soltanto sui quali poteva cadere l’accento) si veggono in due lapidi della penisola Iberica, una del 589 nella Spagna, una del secolo incirca VII nel Portogallo.
«In tutta la rimanente epigrafia cristiana[1028], ed in ispecie in quella di Roma e dei suoi musaici, giammai appare il punto sull’I, eccetto in due iscrizioni che oggi si giudicano[1029], e con piena ragione, falsificate ai tempi incirca di Urbano VIII. Una è quella del preteso architetto dell’Anfiteatro Flavio che dal museo della Marchesa Felice Randanini passò all’ipogeo di S. Martina ove tuttora si vede. L’Aringhi, suo primo editore, e quanti dopo di lui la pubblicarono neglessero i punti sugli I[1030]. Pietro Ercole Visconti li notò e ne fece grande caso, stimandoli accenti. Ma non è così; non potendo l’accento cadere costantemente su tutti gli I[1031]. L’altro esempio, e di fattura contemporanea al precedente, è l’iscrizione del martire Primitivo data ai tempi di Urbano VIII alla predetta marchesa Randanini, e da lei inviata poi a Faenza».
Qui si nota tosto una petizione di principio. L’iscrizione del libro in musaico dovè essere rifatta arbitrariamente ai tempi di Urbano VIII, perchè ha i punti sull’I come le iscrizioni di Gaudenzio e di Primitivo. Le iscrizioni di [301] Gaudenzio e di Primitivo furono fatte ai tempi di Urbano VIII, perchè hanno i punti sull’I come l’iscrizione in musaico del vaticano.
Ma, anche ammesso che il disegno del Grimaldi fosse esatto e che prima non vi fossero i punti sull’I, non è logico da ciò dedurne la falsificazione della nostra lapide. Perchè non dice altrettanto delle due lapidi dell’isola Iberica? Perchè in Ispagna ed in Portogallo, prima di Urbano VIII, si poterono usare i punti sull’I, e in Italia no? E la lapide di Gaudenzio, non l’avrebbe potuto incidere uno spagnuolo.
E lo stesso nome Gaudentius, non potrebbe essere, come Laurentius spagnuolo? E se quei punti triangolari che vediamo sugli I della lapide dell’ipogeo di S. Martina fossero stati aggiunti da mano moderna[1032], per questo solo noi dovremmo ritenerla per falsa?
***
Il De Rossi scrive che «quegli apici si trovano talvolta sovrapposti, non come accenti, ma veri punti complementari della vocale i, nei documenti diplomatici e manoscritti fino dal secolo in circa XII, oggi è consentito dai più autorevoli paleografi. Ma ciò spetta alla scrittura minuscola, nè vale per la maiuscola segnatamente delle epigrafi incise in pietra od effigiate a musaico. In quanto alla paleografia epigrafica classica l’Hübner sentenzia: quod puncta litterae superimponuntur, in universum ab antiqua consuetudine prorsus abhorrere et nocivi usus esse creditur, recte».
Che nell’epigrafia classica non siano stati usati i punti, è certo; ma che per via eccezionale, ed in lapidi volgari, non si usino, non punti, ma apici (come si veggono nella nostra), è anche certo, e noi abbiamo esempî, sempre eccezionali, anche antichissimi. Fra migliaia d’iscrizioni pompeiane noi ne abbiamo qualcuno che ha gli apici. Si veda, il C. I. L., vol. IV, i n.i 1186, 1068, 1189, 1190 ecc., e si troveranno gli apici sulle parole:
IV´NIAS, VENATIÓ, VÉLA, POMPÉIS, VENÁTIO, FADÍVM, CENÁCVLA SEXTÁS, ANNÓS, SATRIÓ, LVGRÉTIO, MV´NIFICO, PRÓ, VÁRVS, SÍRICVM, etc.
Si dirà che questi sono accenti? Ma accenti anche su quel Venatió, Sextás, Amnós, SATRIÓ, MV´NIFICO? S’aggiungerà che non sono sulla vocale I? Ma l’abbiano in quel SÍRICVM, FADÍVM.
[302]
Ma lasciamo questi esempî pompeiani e adduciamone altri più a proposito per la nostra lapide, nella quale gli apici potrebbero essere d’altronde, tante altre gagliofferie che in questa stessa lapide fece l’ignorantissimo scalpellino[1033]. Lapidi adunque con gli apici sull’I, ve ne sono e ne vediamo una nel Museo Veronese[1034], un titoletto riportato dal Lupi[1035], che è del tempo di Domiziano, ossia dell’epoca della nostra. Un’altra fu riportata dal Chimentelli[1036]; v’è inoltre quella di C. Livio Clemente riferita da Zaccaria[1037], e per finire dirò che v’è la famosa lapide di Furfone[1038] (V. pag. 303).
Il Garrucci[1039] descrisse questa lapide e ne fece fare un calco in carta. Un altro calco, pure in carta, fu fatto dal Bormann, e il Ritschel ne fece fare un disegno e lo pubblicò. Ma non ostante che gli apici fossero 36 e bene incisi sul marmo, pure, come dice il P. Garrucci[1040], legere non noverunt neque animadverterunt. E mentre il Mommsen faceva strani ghigni e versacci quando vedeva le riproduzioni del Ritschel ed assicurava che questi prendeva facilmente degli abbagli, pure, quando si trattò di contradire il Garrucci, ricorse tosto ai calchi del Ritschel che erano privi di apici, e negò che vi fossero: ed il Mommsen, a colui che, a suo parere, prendeva sempre abbagli (il Ritschel), questa volta (che in realtà l’aveva preso) diè ragione, dichiarando il Garrucci l’allucinato. Ma il dotto gesuita fece fare un accurato calco in gesso della lapide e ne pubblicò un’esatta riproduzione in una dissertazione archeologica[1041].
Gli apici c’erano purtroppo, e tutti sull’I; il granchio l’aveva preso il Mommsen; il quale, non sapendo che rispondere, cercò una scappatoia e disse: i punti sono stati aggiunti da mano moderna!!! Bravo!
Come si fa presto a levarsi dagli imbarazzi!
Siamo dunque leali. Il Garrucci diceva: i punti vi sono; non so che significhino, ma vi sono. Ed io dico: iscrizioni con apici, o punti vi sono. Saranno eccezioni, ma vi sono; e non è lecito dire che una lapide, specialmente se è nota la sua storia, sia falsificazione del secolo XVII, solo perchè ha i punti. Anzi aggiungo che i punti triangolari od apici sull’I, sono anch’essi una [304] prova dell’autenticità della lapide; perchè essendo quelli cosa eccezionalissima nell’epigrafia, il falsario si sarebbe bene guardato dal metterli; volendo falsificarla, egli avrebbe data ad essa ogni apparenza di genuinità, omettendo cioè tutto ciò che poteva renderla sospetta. Avrebbe, dico, fatta l’iscrizione imitando la paleografia dell’epoca cui voleva riportarla, ed avrebbe tralasciato di mettere gli apici sull’I per meglio ingannare il compratore[1042]. Ma poi, che bisogno aveva un falsario del secolo XVII, di fare quell’iscrizione, se lui, con quella lapide stessa, poteva ottenere il suo scopo senza incidervi «Sic premia servas» essendovi (nell’altra parte) l’iscrizione di Augurina Aurelia che è certamente genuina e antica? Sarebbe bastato darla al compratore come si trovava! Il guadagno l’avrebbe avuto lo stesso, e vendendo una cosa autentica!
Inoltre il De Rossi (come s’è detto) fa questo ragionamento: il Grimaldi fece il disegno dell’iscrizione in musaico del Vaticano, ed in esso (disegno) non vi sono punti sull’I. Dunque in origine non v’erano, e furono aggiunti sotto Urbano VIII quando fu tutta arbitrariamente rifatta. Ed io potrei argomentare lo stesso: l’Aringhi, il primo editore della lapide Sic premia servas, e quanti dopo di lui la pubblicarono, la pubblicarono senza i punti sugli I. Più tardi poi la vediamo pubblicata con punti rotondi ed altre volte triangolari. Dunque, in origine, quando fu scoperta nel cimitero di S. Agnese, era senza punti. Più tardi furono aggiunti. Che ti sembra, o lettore, di questo ragionamento? Io non avrei difficoltà in ammetterlo, perchè non impedirebbe ma confermerebbe la genuità della lapide. Ma bisognerebbe dimostrarlo, e non basta l’esempio del Grimaldi, il quale avrebbe potuto anch’egli neglettere, come l’Aringhi, i punti sull’I[1043]. Ma se tanta era la mania di mettere i punti triangolari sull’I, in lapidi esistenti, come vorrebbe il Mommsen relativamente alla lapide Furfonense, anche noi, se così vogliono gli archeologi moderni, diremo, che furono aggiunti arbitrariamente ai tempi di Urbano VIII, benchè, come nella lapide di Furfone, non vi sia ragione di sorta per asserirlo[1044].
[305]
E qui aggiungerò quanto il Garrucci[1045] dice intorno alla forma dei segni che noi vediamo appunto nella lapide di Gaudenzio: «una proposizione finalmente (così Egli) parmi degna di nota, quella dico, del Ch. Ritschel, il quale scrive che l’apice posto sopra le lettere non ebbe mai la figura di punto: puncti figuram apex ne habuit quidem unquam. All’apice sia che si consideri come distintivo della quantità, sia che dell’accento acuto insieme e della quantità, trovasi surrogato il PUNTO in Albina Brvˆti F. e in Fâtv della beneventana epigrafe già da me citata.... Ma inoltre di esso punto è marcato l’I lungo, e non alla maniera singolare al certo, delle lapidi di Furfone e di Fiume. Siano esempio PÎSO, così scritto in due nitidissimi esemplari del Museo Vaticano.... il che fa salire l’uso del punto sugli I un quindici anni avanti ai primi esempii di punti impressi sugli V, che non precedono il 680, laddove il danaro di Lucio Pisone dimostrato dal Cavedoni coll’assentimento del Borghesi, battuto circa il 665[1046]. Un esempio forse più remoto, di tal paleografia erasi citato dal Borghesi[1047], e fu da me richiamato nella dissertazione medesima: leggesi inciso in un bollo di mattone così scritto: M. ALFÎSI. F. Laonde fa maraviglia come il ch.º Ritschel abbia potuto asserire puncti figuram apex ne habuit quidem unquam».
A quest’esempio si può aggiungere un altro, trovato parimenti in bollo figulino dei tempi degli Antonini, bollo che io stesso ho veduto co’ miei occhi, e che ognuno può vedere nel monumento, al suo posto (od anche nell’opera pubblicata da Gio. Battista Lugari)[1048], in cui sull’I di Felicissimo è manifesto il punto rotondo, e mostra esser questo l’uso volgare di scrivere.
OPVS DOLIARE. NEGOTIAN || TE AVR FEiCISSM
(delfino)
I punti od apici dunque che troviamo sull’I della lapide di Gaudenzio non sono sufficienti per farla dichiarare falsificazione dei tempi di Urbano VIII.
***
Ma è già tempo di esaminare la seconda opinione, la quale ci darà motivo di studiare la nostra lapide più particolareggiatamente sotto l’aspetto paleografico.
[306]
I seguaci di quest’opinione ritengono che l’iscrizione «Sic premia servas» sia stata incisa nel secolo V. Il Bellori non le assegna un’epoca precisa, ma dopo aver detto che la lapide è neque spuria neque recens, aggiunge che la ortografia e la forma dei caratteri indicano essere molto posteriore ai tempi Vespasianei: sed orthographia et caractheres longe sequiorem Vespasiano Augusto aetatem indicant. Il Nibby, già da noi altre volte citato, è più esplicito nell’esprimere la sua opinione, e dice che lo stile della lapide in questione, presenta tutta l’apparenza del secolo V.
Io non so comprendere come nel secolo V, quando per certo non si pensava a falsificazioni, si volesse formare un epitaffio, che, per lo scritto, dovrebbe riferirsi a Vespasiano. È vero che il Gori, come dicemmo, con maravigliosa disinvoltura afferma che quell’epitaffio è una riproduzione di qualche leggenda popolare: ma, di grazia, una riproduzione in marmo, di una leggenda popolare intorno ad un fatto accaduto circa trecento anni indietro, non ci farebbe dir vero il fatto che in esso marmo è scritto? Ignora forse i carmi di Damaso i quali si riferiscono a fatti di molto anteriori a quel Papa, v. g. Hic habitasse prius ed altri?
Ma lasciamo questo punto per sè chiarissimo, e studiamo la cosa secondo i canoni della scienza archeologica cristiana.
Verso la fine del secolo IV, la sepoltura nei cimiteri sotterranei addivenne più rara, e agli esordî del secolo V, e precisamente dal sesto all’ottavo anno di questo secolo, secondo il De Rossi[1049], o l’anno 426 secondo l’Armellini[1050], cessò. Ora la nostra lapide è cimiteriale, anzi, come vedemmo, fu estratta da un cimitero. Dunque dovrebbe essere stata scritta nel primo decennio[1051] del secolo V. Ma se ciò è possibile per sè, è però impossibile dimostrarlo.
Dire poi che nelle catacombe si scrivessero lapidi per ingannare i posteri, o si riproducessero leggende popolari contrarie alla verità storica, come piacque di asserire al Gori, è ardito ed inverosimile; e il marmo stesso, per sua natura cimiteriale, esclude questa ridicola asserzione. È vero nondimeno che nel secolo V furono usate molte lapidi cimiteriali per chiudere formae e coprire sarcofagi che si trovavano nei cimiterî sopratterra, e che nel rovescio di quelle lapidi furono scritti epitaffi in memoria dei defunti deposti sopratterra; ma è ridicolo pensare che nel secolo V fosse deposto sopratterra un defunto, il quale, secondo l’iscrizione, morì sotto Vespasiano.
[307]
Ma poi è inutile insistere.
La lapide fu trovata in un cimitero sotterraneo e non sopratterra, e questo basta per dimostrare che è cimiteriale e quindi anteriore almeno ai primi anni del secolo V. Vediamo piuttosto quali ragioni abbiano spinto il Bellori e il Nibby a credere la nostra iscrizione opera antica sì, ma di molto posteriore a Vespasiano o perchè abbia tutta l’apparenza del secolo V.
Due sono le ragioni addotte dal Bellori: 1º orthographia et caractheres; 2º in ipsa non amphitheatri sed theatri mentio habetur.
Già feci notare che il criterio paleografico è poco dimostrativo se si trova disgiunto dagli altri criterî, dei quali è mestieri sempre tener conto allorchè si tratta della sentenza capitale di una lapide. Ora s’è visto già che gli altri criterî s’addicono, e molto bene, alla nostra iscrizione. Dunque dalla sola paleografia non può trarsi argomento sicuro, e se ciò si tentasse, sarebbe far uso di essa senza giudizio, come dice il De Rossi.
Di più: l’argomento tratto dalla paleografia ha forza quando si tratta di lapidi appartenenti a monumenti pubblici e solenni, ed anche parlandosi di epitaffi cimiteriali incisi da mano perita e secondo le regole dell’arte. Allora giovano certamente a farci distinguere le diverse epoche; ma non già quando si tratta di lapidi private, di epitaffi cimiteriali incisi da mano inesperta, con fretta o con caratteri trascurati. In questo caso non si può trarre prova di sorta; e fallace assai sarà il giudizio dedotto da questo solo argomento, perchè: Non semper e complexu litterarum aetatem erui fas est; nam bene potuit etiam saeculo primo lapicida quilibet, sine ex negligentia, sive ex imperitia, litteras inelegantes describere[1052].
L’iscrizione «Sic premia servas» trovasi precisamente nel numero di queste seconde lapidi, e dalla sua paleografia non si può dedurre essere del sec. V. Il Fabbretti[1053] d’altronde già aveva insegnato quanto fosse fallace il giudizio d’una lapide basato su i soli caratteri: «Incertum et fallax esse probationis genus ex caractherum conformatione tempora distinguere». Il Maffei[1054]. aggiunge: «Satis profecto colligi iam posse arbitror quam fallax et ambigua scripturae coniectura sit, dies enim in re deficeret, ubi singula quae in hanc rem animadverti proferre velim.... infirmum ergo in litterarum exaratione argumentum est ad aetatem lapidum eruendam. Scripturae argumentum generatim minime certum est, indubitatum esse ita ut ex eo tantum de sinceritate lapidum possimus decernere, nam ea quidem quandoque est in lapidibus [308] scriptum facies ut validum aut vetustatis aut novitatis iudicium faciat, at saepissime ita ambigua est, ut ARGUI NIHIL POSSIT. Secundo haberi pro certo velim aberrare toto coelo qui e litteris num sub Traiano an sub Commodo, num secundo vel tertio vel alio quopiam saeculo.... inscripti lapides fuerint decidi posse opinantur».
Il maestro finalmente dell’arte lapidaria[1055], scrisse: «Neque a Maffeio dissentio, quem verissime scripsisse puto.... ut ii omnino fallantur qui PLERUMQUE.... AETATEM INSCRIPTIONUM CERTE se nosse dictitant». Si dice che questi finiscono poi quasi con disdirsi; e che in pratica sovente affermano, questa o quella lapide offerire lettere di questo o quel secolo.
Questa è un’ingiuria che si fa a questi uomini dotti e maestri dell’arte lapidaria; ma dato pure che si siano serviti del criterio paleografico più spesso di quello che in realtà fu, non possiamo però dire che nel determinar essi l’epoca ad una lapide, abbiano trascurato gli altri canoni da loro stessi posti; e se, scrivendo, si contentarono di accennare una delle ragioni della loro affermazione, dovettero però sottintendere le altre, dalle quali la paleografia non deve andar disgiunta.
Del resto, noi non dobbiamo guardare alle azioni degli uomini i quali tutti humana patiuntur, ma alle loro dottrine: e se queste sono ragionevoli, giuste e rette, dobbiamo aderire ad esse senza punto badare alle loro azioni individuali opposte ai principî retti e alle dottrine sane e vere che essi stessi dettarono; e ciò che essi non fecero per qualche ragione speciale, dobbiamo farlo noi seguendo i loro dettati.
Quando poi si desiderasse una dimostrazione pratica, e quindi convincente, della veracità, rettitudine e ragionevolezza dei principî posti da quei sommi uomini; quando, cioè, si volesse vedere che basare il giudizio di una lapide sopra la paleografia, sarebbe un giudizio assai fallace, ambiguo ed erroneo, si confronti per poco questa nostra lapide con epigrafi antichissime di età certa, e se ne troverà un confronto nei bronzi, nei graffiti, nelle pitture, nei marmi di grossa e piccola mole, e nelle lapidi anche di epoca molto antica e dei secoli migliori.
Così, per es., l’A nel nostro marmo ha qualche volta la sbarra ad angolo; e tutti sappiamo che questa forma fu comune e molto usata appunto nel secolo V e nei secoli posteriori. Ma sappiamo altresì che questa forma di A, si trova pur anche usata innanzi alla prima guerra punica, nelle monete della metà del secolo VI di Roma, ed in altre dell’èra repubblicana[1056]. Nei marmi [309] dei secoli anteriori all’Impero[1057], e parimenti in quelli del secolo I dell’Impero troviamo l’A della forma citata. Così nel C. D. R. N. pag. 113, n. 220, leggiamo una lapide pompeiana con l’A di tal forma; e il Xengeimester (Inscript. pariet. Pomp. Vol. IV), c’insegna che questa forma di A fu usata nelle iscrizioni delle pareti di Pompei, le quali non possono essere posteriori all’anno 80 dell’êra volgare, vale a dire all’età a cui dovrebbe riportarsi la nostra lapide.
Un esempio poi ugualissimo al nostro, e dell’epoca appunto dei Flavî, lo troviamo fra i marmi grezzi di Marmorata, ove, sopra un masso di africano, si legge:
Queste lettere furono incise da un marmista idiota, che, per il nome del servo Laetus deve riferirsi all’anno 80 dell’era nostra[1058].
Un altro esempio più recente è poi quella lapide cristiana del cimitero Ostriano nella quale si vede nei due A la sbarra ad angolo: e questo marmo, come avverte il ch.º Armellini, è di data antichissima.
Da quanto si è detto si deduce che dalla sola paleografia non si può trarre argomento per dimostrare che l’iscrizione «Sic premia servas» sia del secolo V, e si deduce esser purtroppo vero il canone di quei sommi maestri i quali dissero che la paleografia plerumque e generatim è assai fallace e non ha valore demostrativo.
Vediamo ora se dall’ortografia si possa o no argomentare che la nostra lapide è posteriore a Vespasiano e precisamente del secolo V. È questa la seconda parte della prima ragione che adduce il Bellori per dubitare dell’età di quest’iscrizione. E senza dimorarmi di più, dico subito: neppure dall’ortografia si può trarre argomento, e lo provo prima coll’autorità e poi col fatto.
L’Oderici[1059] scrive: «le leggi della chiarezza e della grammatica non furono sempre le più religiosamente osservate nelle iscrizioni: mille esempi se ne mostrano tutto giorno». Il De Rossi[1060] dice: «quod si ne his epitaphiis, scriptura, dictio, sermo non modo ab elegantia sed ab ipsis quoque gramaticis legibus non semel abhorrent, id ab auctorum rusticitate et vernaculae linguae ac pronunciationis specie, magis quam a saeculi barbarie esse repetendum satis intelligitur».
[310]
Dalle autorità passiamo ai fatti. Gli errori ortografici della nostra lapide sono: 1º la mancanza del dittongo ae.
2º La m usata invece della d nella parola ALIUM.
3º La mancanza della c nella parola AUTORI.
4º Il segno d’abbreviazione sull’V, nella voce THEATRV il quale veramente non si potrebbe dire come a suo luogo vedremo, errore ortografico.
Per quel che riguarda la mancanza del dittongo ae, lo Scaligero[1061] insegna che la e si trova frequentemente usato dagli antichi invece del dittongo ae; ed il Fon[1062] pretende che ciò si debba ascrivere alla grande quantità di schiavi greci ed asiatici che erano in Roma, e quindi all’influenza dei nomi grecanici. Sia però questa od altra la ragione, è certo che fu spesso ed in ogni età tralasciato.
Così il Noris, nei suoi Cenotafi Pisani[1063] assicura che la parola caetera, ai tempi di Augusto, si scriveva senza il dittongo ae.
Ed il Lupi, parlando della mancanza di questa a[1064] dice: «Quod si ad inscriptiones provoces plenae sunt rei notissimae exemplis collectiones, Manutii, Lipsii, Gruterii, Bosii, Aringhii, Reinesii, Sponii, Fabretti, Malvasiae, Vignolii, Boldetti, Donii, Gorii, aliorumque». E prosegue[1065]: «Neque haec barbaries et neglectus ortographiae quod attinet ad diphtongos in christianis lapidibus tantum observatur.
Non solum tangit Atridas
Iste dolor.
Etiam Ethnici epitaphiographi: licet ut plurimum diligentiores epigrammatis suis, leges tamen exacte scribendi saepe sunt praetergressi».
E lo Zaccaria[1066] dice: «Questi (dittonghi) spesse fiate da negligenti scalpellini si tralasciavano».
Difatti, iscrizioni d’ogni età, d’ogni sorta, pagane e cristiane, hanno questa mancanza[1067].
Il difetto della c nella parola AVTORI, secondo, l’Heinrichio, il Ballhornio e il Bejero, non sarebbe un errore ma un’esattezza ortografica.
[311]
Ma questa è un’opinione loro speciale; io però che non ritengo il nostro quadratario per un dottore in filologia, seguo l’opinione più comune ed ammetto che la voce auctor s’abbia a scrivere con la c; anzi aggiungo che la mancanza di questa consonante in quel vocabolo è un errore.
Ma questa scorrezione è confacentissima al caso nostro; al caso, cioè, di un uomo del volgo, forse di un marmista che lavorava nell’Anfiteatro, il quale a sfogo dello sdegno da cui fu preso nel vedere condannato a morte il suo, dirò così, principale, mentre era degno di premio e di lode, scolpì sul marmo i suoi sentimenti nell’impeto dello sdegno, con quei modi e con quelle parole che erano usate comunemente dal volgo, come noi stessi spesso leggiamo negli scritti di gente idiota, gli stessi errori che pronunziano parlando. E questo fatto lo vediamo verificarsi anche a’ giorni nostri, e possiamo essere sicuri che ciò avvenne in tutti i tempi, non esclusi i più remoti, come ce l’insegna il Padre Marchi[1068] di ch. memoria.
L’altro errore, quello della m invece della d, può essere un errore grammaticale od anche di ortografia. Se grammaticale, non è questo il primo esempio del mascolino usato in luogo del neutro. Troviamo per es.: monumentus hic est[1069] e hic monumentus per hoc monumentum in lapidi antiche[1070]: collegius[1071], cubiculus, eum sepulchrum, hunc aedificium[1072]. Onde nel caso nostro, se si fosse usato il mascolino per il neutro non sarebbe cosa nuova, e non indicherebbe che la lapide è di tarda età.
Se poi si volesse considerare come errore ortografico, esempî di cambiamenti di lettere nelle lapidi antiche sono frequentissimi, senza che queste perdano punto della loro antichità. Chi di noi non sa, a mo’ d’esempio, quanto sia comune nelle lapidi la B in luogo della V, scambio che noi troviamo nelle lapidi non solo arcaiche ma anche in quelle dell’alto impero?
Parimenti fu uso comunissimo quello di usare la b per la p e viceversa. Così si legge pleps per plebs; collabsum per collapsum, sup per sub, ecc. Lo stesso si dica della d per la t, come v. g. si vede nei cenotafi pisani che sono dell’età augustea, e in lapidi dell’epoca degli Antonini; la e per la i e la i per la e; la m per la n; la q per la c (specialmente nelle lapidi napoletane); e così troviamo pure at fines per ad fines, set per sed, ed anche qui per quo, ecc.
Il segno d’abbrevazione sulla V, non può dirsi un errore, ma piuttosto un’eccezione ortografica: la quale però non basta a far dichiarare una lapide falsa o di bassa età.
[312]
Infatti, questo segno non è che un ripiego del quadratario, il quale, o lo fece perchè l’ultimo verso rimanga nel mezzo, o, e più probabilmente, perchè dimenticatosi d’incidere la M, e avvertitolo dopo aver inciso il resto, ricorse alla correzione solita a farsi in questi casi. E che questa correzione sia stata usata nelle epigrafi antiche ed in quelle d’età non bassa, lo deduco dalle parole del Morcelli[1073], sommo maestro in arte lapidaria. Egli dice che «caeterum haec emendationis causa assegnaveris ne mendum a scriptore ipso prodiis videatur». E che gli antichi, prima della decadenza, usassero questo segno lo vediamo in molte lapidi, e troviamo che precisamente sta in luogo della M. Così ad es. in honore, Deoru, Olla, Eoru, Foebu, libertu, agne, memoria, parentu, maloru, ecc., ecc., che si trovano nelle lapidi già riportate dal Gruterio, Fabretti, Marini, registrate in varie collezioni epigrafiche, e che ora si trovano quasi tutte riunite nel C. I. L., le quali ognuno può facilmente vedere. Nondimeno credo opportuno aggiungere quanto il Garrucci, nella sua bella opera sui segni delle lapidi,[1074] scrive: «Riscontransi.... dei segni così fatti nelle lapidi, ed il Marini, colla usata sua dottrina e diligenza ne ha raccolto un buon numero di esempî[1075].
«Ma essi dimostrano l’assenza di una consonante o di una sillaba e meritano perciò il nome di notae scripturarum dato da S. Isidoro a simili segni[1076]. Nè sono essi di uso sì recente che non rimontino ai tempi medesimi di Augusto, siccome in Proni dei cenotafi pisani invece di Patroni, in Ceria nel graffito pompeiano, che porta la data dell’anno 717, in luogo di Centuria; in SINCERV d’altro graffito pure pompeiano[1077], ed in ITE[1078], ed in Olla[1079], adoperato ad esprimere l’assenza di un M, ecc.».
Conchiuderò queste osservazioni alla prima parte delle obiezioni del Bellori, colle parole del Maffei[1080]: «nulla fere est informium litterarum, nulla distortae, inaequalis, tremulae, oblongae, confusae, connexae, scripturae facies cuius specimen vel in milliaris cippo, vel in funereis paganorum tabellis aliquando non viderim».
Ed aggiungerò le parole di un illustre archeologo, il quale trattando del ragionamento letto dal sig. De Petri sopra le tavolette cerate di [313] Pompei[1081], finisce così il suo discorso: «Quanto alle quistioni grammaticali crediamo che serviranno queste scritture per aprir gli occhi, se è possibile, a coloro i quali si OSTINANO A DETERMINAR LE EPOCHE CO’ DATI DELL’ORTOGRAFIA.
«Lasciando stare gli errori, noi vediamo che i Pompeiani tuttavia ritenevano nella pronunzia, la quale ci si manifesta nella scrittura privata, di sopprimere l’aspirata in Chirographum, Amaranti, Nimpodoti, Agatomeni, Agatoclis, Cryseroti, Ienurnae, Pospori, Pronimi, Palepati; di adoperare la V in luogo della Y in Lampuris; in Hupsaeo, che del resto trovansi in generale scritti anche col h e coll’y; di porre il qu in luogo del cu in pasquon, e l’inserire una vocale in Ichimas, Lanisisticis, invece di Ichmas, ossia Icmas, lanisticis; l’s prende il posto dell’x in Sexcentos, la f per ph in Alfei, in Fatiscus; l’xs sta x in Maxsimus, Axsiochus, dixsit, Sexs, Alexsandrini, Sexsaginta. Finalmente Giovianus è così scritto invece del comunissimo Jovianus, della quale ortografia non so altro, se non stupire, dovendo ammettere che la pronunzia del Gi e Ge per J si abbia da far rimontare ad un’epoca sì remota alla quale finora non si ardiva di portare il Geronymus, il Genuarius, il Gerusalem, delle antiche scritture».
La paleografia dunque e l’ortografia non sono ragioni sufficienti perchè questa lapide si dica del secolo V.
A queste ragioni del Bellori ne aggiunge un’altra il Nibby, dicendo che la lapide per lo stile presenta tutta l’apparenza del secolo V. La difficoltà del Nibby poteva aver forza quaranta o cinquant’anni fa; ma ora, che si sa positivamente che la sepoltura cimiteriale cessò nei primi anni del secolo V, e per quello che fin qui s’è detto, la difficoltà del Nibby rimane priva quasi di ogni valore. Del resto trattandosi di stile, potremo vedere se vi siano lapidi d’epoca più antica, e che possano confrontarsi colla nostra.
Leggiamo in Plinio[1082] che sulle pareti del tempio di Ardea si leggeva quanto segue:
«Dignis digna loca picturis condecoravit
Reginae Junionis Supremae coniugis templum,
Marcus Ludius Elotus Aetoliae oriundus
Quem nunc et post semper ob ostem
Nunc Ardea laudat».
[314]
È innegabile che quest’epitaffio abbia molta somiglianza col nostro. Ora, se all’epoca classica della latinità, ossia ai tempi Augustei, furono scritti sulle pareti di un tempio versi tali da far dire al Tiraboschi[1083]: «Se io non gli avessi trovati in Plinio, gli crederei fatti ne’ nostri secoli bassi; così sono essi composti in uno stile barbaro a un tempo e moderno»; con più ragione, ai tempi di Vespasiano e nell’oscurità delle catacombe, si poterono scrivere i nostri versi da un quadratario idiota nell’impeto dello sdegno; senza che per questo lo stile si debba dire barbaro e basso. Dissi versi, giacchè, se bene si pone mente, quell’iscrizione ci ricorda i versi saturnî come quelli riportati da Plinio, e dei quali ha trattato magistralmente il P. Garrucci nella sua Sylloge Inscriptionum[1084], alla quale rinvio il lettore perchè giudichi se io abbia o no errato in chiamarli così. Dunque anche la difficoltà dello stile, come quelle della paleografia e dell’ortografia, non ha qui forza.
Ma un’altra difficoltà ci presenta il Canina[1085]. Egli dice che il nome ed il modo con cui viene designato Gaudenzio fa riportare questa lapide ad età tarda. Riguardo al modo, confesso che non so che rispondergli, perchè non capisco che cosa egli voglia intendere con questa parola generica. Ma se per modo vuol intendere lo stile della lapide, la questione l’ho or ora risolta.
Se poi per modo voglia significare l’espressione della lapide, non so come questa si possa dire di molto posteriore a Vespasiano quando i due protagonisti della lapide stessa sono appunto Gaudenzio e Vespasiano.
Relativamente al nome, non nego che questo possa fare una tal quale obiezione, giacchè la desinenza in entius fu frequentissima nei tempi tardi, ma però non fu esclusivamente propria di quell’età.
Infatti, o Gaudenzio appartenne a famiglia libera o fu servo o fu liberto. Se appartenne a famiglia libera (ciò che non pare probabile), anche fra le famiglie libere (ed in tempi remotissimi) si ricordano nomi che hanno la desinenza in entius, come Mexentius[1086], Placentius[1087], Eventius, Dentius; e nella epoca repubblicana e dell’alto impero, abbiamo varî Terenzî, ecc., per esempio: Terentius (console), Terentius (scrittore), Terentius (comico); abbiamo: Juventius (console), Juventius (comico)[1088], Juventius (giureconsulto); Placentius[1089], Calventius[1090], Gentius[1091], Cosentius, ecc.: e tra i nomi femminili, [315] s’ha: Gentia[1092], Calventia[1093], ecc. Onde non sarebbe strano se ai tempi de’ Flavî vi fosse stato un Gaudentius; e a questo riguardo (desinenze in antius, entius, ontius) il De Rossi[1094], scrive: «inde tamen minime colliges illarum appellationem quae saeculo praesertim quarto viguere, ne primas quidem origines ab antiquiore aetate esse repetendas».
Se si dica poi che il nostro Gaudenzio fu o servo o liberto (come sembra più verosimile); allora, attese le circostanze ed i tempi, atteso che il cristianesimo fu estesissimo nella famiglia de’ Flavî; che fu uso dei padroni servirsi dei liberti nelle opere loro, l’obiezione cade da sè. Difatti: fra l’immensa serie di nomi dei liberti e servi, per la maggior parte a noi sconosciuti, chi potrà con serietà affermare non esservene stato a quei tempi neppur uno che avesse la desinenza in entius?
Esaminiamo ora le altre difficoltà, incominciando da quella già proposta dall’Aringhi due secoli e mezzo fa, e riprodotta nuovamente dal Gori nell’anno 1875. Questa lapide, dicono, non può essere dei tempi di Vespasiano, perchè sotto quest’imperatore non vi fu persecuzione.
Rispondo:
Sebbene sotto l’impero di Vespasiano non avesse luogo una persecuzione, pure non v’ha difficoltà per opinare plausibilmente che Gaudenzio (appunto perchè cristiano) potesse esser vittima di quell’imperatore. Infatti:
Se Gaudenzio, divenuto cristiano, si fosse ricusato di prestare più oltre la sua opera nella costruzione di un luogo che sarebbe stato poi il teatro del sangue umano[1095]: o se[1096] invitato da Vespasiano a costruire una naumachia[1097], egli ne avesse accettato l’incarico; ma che poi, mutata l’idea della naumachia e stabilito di ridurre l’edificio a luogo di spettacoli gladiatorî (tanto aborriti dai cristiani) avesse voluto declinare dall’incarico preso: o finalmente che si fosse ricusato di costruire l’ara, ecc.; non sarebbero stati motivi sufficienti per un Imperatore pagano, benchè non persecutore del cristianesimo, per fargli mettere in esecuzione la legge neroniana, a quei tempi purtroppo vigente, per far uccidere Gaudenzio? E non furono questi i motivi per cui i Quattro Santi Coronati, scultori di opere notevoli (per essersi, cioè, ricusati di scolpire una divinità), furono barbaramente uccisi?
[316]
Del resto ancorchè la Chiesa sotto alcuni Imperatori godè di pace, pur nondimeno, come tutti sappiamo, non mancarono mai qua e là martiri; e chi ignora che sotto lo stesso Vespasiano, per es., fu ucciso il santo Vescovo di Ravenna, Apollinare?
Ma a quest’obiezione dell’Aringhi avean già risposto trionfalmente il Marangoni[1098] ed il Piale[1099], alle opere dei quali rinvio il lettore.
Infine Dione Cassio[1100] ci dice che Vespasiano fe’ morire varî qui in mores Judaeorum transierunt; e questo passo non si spiega altrimenti (attesa la nota confusione che fu fatta a quei primi tempi tra il cristianesimo e giudaismo) che coll’aver fatto, Vespasiano, uccidere varie persone convertite al cristianesimo; religione che gli Imperatori e i gentili in genere, credettero fosse la stessa, o almeno una setta del giudaismo.
Dunque benchè Vespasiano non movesse persecuzione contro il cristianesimo, pur nondimeno Gaudenzio potè essere martirizzato sotto quell’imperatore, sia perchè, essendo quegli cristiano, potè ricusarsi di proseguire l’opera affidatagli; sia perchè anche sotto Vespasiano vi furono martiri; e sia finalmente perchè, per testimonianza dello storico pagano già citato, Vespasiano fe’ realmente uccidere varî, i quali, verosimilmente, furono quelli che abbracciarono la religione di Cristo, e furono scoperti come tali.
***
Siamo giunti finalmente a poter dire con certezza morale che la lapide «Sic premia servas», risale all’età Vespasianea, e che per conseguenza il Gaudenzio in essa ricordato, visse in quegli stessi tempi. Ma chi fu questo Gaudenzio? Perchè Vespasiano lo fece uccidere? Per rispondere a questi quesiti basta mettersi sott’occhio la lapide e spiegarla: dalla semplice lettura di essa, tutto appariva chiaro.
«Sic premia servas, Vespasiane dire,
Civitas ubi gloriae tue autori
Premiatus es morte Gaudenti letare
Promisit iste, dat Kristus omnia tibi
Qui alium paravit theatru in coelo».
La disposizione dei versetti (a due coppie, con uno spazio frapposto in mezzo, forse per la forma bislunga del marmo) indica che la nostra lapide si debba leggere a colonna. Laonde non so spiegarmi la ragione per cui il Marangoni [317] ed il Fea ne abbian fatto la versione letterale leggendola continuatamente, senza far conto di quello spazio, che pur v’è; e così avvenne che quella traduzione poco concordasse colla versione libera che poi ne fecero.
Fatta questa osservazione necessaria, ecco la versione letterale della lapide:
Così i premî serbi, o Vespasiano crudele?
O Città, dove all’autor della tua gloria....
Premiato sei colla morte, o Gaudenzio, rallegrati.
Promise questi; Cristo ti dà ogni cosa,
Che altro teatro preparò nel cielo.
In versione più libera, può suonar così:
Così serbi la fede dei premî promessi, o crudel Vespasiano? e dove, o Roma, riserbi i dovuti premi all’autore della tua gloria? La morte fu il tuo premio, o Gaudenzio, ti rallegra; Vespasiano promise, ma Cristo ti dà tutto, preparandoti nel cielo miglior teatro.
Non credo necessario giustificare quelle poche supposizioni che si troveranno in questa spiegazione, giacchè esse sorgono spontaneamente come si dimostra dalla concordanza perfetta delle due versioni.
Dall’esame analitico di questa lapide si può ricavare:
1º Che il nostro Gaudenzio fu cristiano: Kristus dat omnia tibi. Qui alium paravit theatru, in celo[1101].
2.º Che fu martire: Premiatus es morte. Un cristiano il quale fu fatto uccidere dall’Imperatore, e che per questa ragione ricevè da Cristo la gloria del Paradiso, non dovrà dirsi martire?
3.º Che fu martirizzato sotto Vespasiano: Vespasiane dire.
Ma qui si potrebbe obiettare:
Quel Vespasiano, invece dell’Imperatore, non potrebbe esser un altro qualunque che avesse lo stesso nome?
No. Infatti, se questo Vespasiano invece di premiare fece uccidere Gaudenzio, dobbiam dire che quegli avesse nelle sue mani il potere di premiare e di punire colla morte; avesse, cioè, quel potere che i giuristi chiamano merum imperium.
Ora apprendiamo dalle Pandette e dal Codice di Giustiniano (e tutti gli interpreti del diritto romano, come Cuiacio, Donnello, Averano, Roet, Brunemann, Perezio, ecc. sono concordi), che questo potere competeva all’Imperatore, [318] direi, per natura; e, per delegazione, al Prefetto della Città e a quello del Pretorio. Si deduce questo anche dalle famose parole dette da Traiano al Prefetto del Pretorio[1102]: «Accipe gladium, quem pro me, si bene atque ratione imperavero, distringes: sin minus, eo ad interitum meum utere». Nè si può supporre che, all’infuori del fondatore della famiglia imperiale dei Flavî, vi siano stati altri imperatori di nome Vespasiano. Nè questo nome apparisce nei cataloghi dei Prefetti del Pretorio o in quello della Città[1103].
Quindi se il nostro Gaudenzio fu ucciso da un Vespasiano il quale avesse il potere di uccidere, questi non potè essere che l’Imperatore.
4.º Finalmente, che fu martire in Roma: «Civitas, ubi glorie tue autori». Ho detto martire in Roma, e lo deduco dal fatto che la lapide fu trovata scavando un cimitero cristiano romano. E la sana critica c’insegna che, usandosi in un discorso un nome generico, questo si deve riferire a quella cosa che gli è vicina e non lontana; e ora la lapide fu trovata a Roma: dunque la città cui si riferisce il discorso, è Roma.
Nè vale obiettare che in questo caso si sarebbe dovuta usare la voce Urbs e non Civitas; giacchè qui il discorso non è rivolto alla città materiale, ossia alle mura, ma ai cittadini; e tutti sanno che i latini usarono la voce civitas per indicare il formale, e Urbs il materiale della città. E nel caso nostro si dovè dire, come fu detto, civitas, e non altrimenti.
Di più: in quella lapide si fa allusione ad un teatro, e ad un teatro dei tempi di Vespasiano, a cui pure è rivolto il discorso. Ma, ad eccezione dell’Anfiteatro Flavio, non s’ha memoria che Vespasiano abbia eretto altri edifizî per darvi spettacoli pubblici.
Se dunque la città a cui qui si rivolge il discorso è Roma, se il marmo fu trovato in un cimitero cristiano di Roma (e questo indica che il martire fu deposto in Roma), dobbiam pur dire che Gaudenzio è un martire romano.
Fin qui l’iscrizione ci dice che Gaudenzio fu cristiano, che fu martire, che subì il martirio sotto Vespasiano, e che lo subì in Roma. Ma chi fu questo Gaudenzio? Nulla si potrà dedurre dalla lapide? Il Nibby, il Canina e il Gori, pur trovando difficoltà intorno a quest’iscrizione, concedono nondimeno che il Gaudenzio in essa ricordato abbia relazione con un luogo di spettacoli fatto edificare da Vespasiano. E questo è innegabile, ed è chiaro anche per quel relativo alium che si riferisce a Theatrum. Ora sotto l’impero di Vespasiano e [319] per suo ordine fu edificato in Roma quel luogo di spettacoli che formò la gloria di Roma, una vera maraviglia del mondo, il Colosseo, di cui Marziale:
«Barbara pyramidum sileant miracula Memphis».
Se dunque si parla in questa lapide di un luogo di spettacoli costruito sotto Vespasiano; se in essa si rimprovera Roma, perchè, ingrata, anzichè premiare, lasciò uccidere colui il quale fu l’autore della gloria sua; non essendovi memoria di sorta, la quale ricordi che Vespasiano abbia eretto altri edifizî da spettacoli in Roma, come or ora dicemmo; e molto meno, che sotto Vespasiano siano sôrti in Roma tali edifizî da potersi dire «gloria della Città», se si eccettui il Colosseo: credo non si possa dubitare che quel luogo di spettacoli non fosse l’Anfiteatro Flavio, e quindi che questo abbia relazione col nostro Gaudenzio.
Ma in che consiste questa relazione? Non si può dire che Gaudenzio fosse uno dei famosi gladiatori dei quali qualche città andava stoltamente superba, perchè quest’ipotesi viene esclusa dalla natura della lapide, che è cristiana, e dal fatto: giacchè se Gaudenzio fu ucciso sotto Vespasiano, non potè certamente presentarsi sull’arena dell’Anfiteatro Flavio, perchè questo fu dedicato da Tito.
Diremo forse col Nibby[1104], che Gaudenzio sia stato un artista che pose in quel colosso l’opera sua? Ma le singole parti e la scultura di quest’Anfiteatro non sono certamente tali da poter far chiamare l’esecutore autore della gloria di Roma! Di più quella voce THEATRV non vuol dire un capitello, un ornato, una statua; ma significa, in senso comune, il corpo intiero della fabbrica.
Che resta dunque, se non che Gaudenzio sia stato l’inventore, l’autore insomma l’architetto del Colosseo?
Ecco dunque che dalla lapide si deduce pur anche chi fosse Gaudenzio. Ma se a questo noi aggiungiamo l’argomento di cui si serve il Marangoni[1105] per manifestare quella sua ormai famosa opinione, che il Marini dice elegans; l’argomento, dico, tratto dal silenzio degli scrittori antichi sull’architetto del Colosseo, ci convinceremo ancor meglio della verosimiglianza del nostro asserto.
Non v’ha, direi quasi, scrittore pagano il quale parli di fabbriche di qualche fama, che non rammenti l’autore della fabbrica stessa. Si parla del celebre [320] tempio di Giove Olimpico, e se ne ricordano gli architetti[1106]; si nomina il celebratissimo tempio di Diana in Efeso, ed ecco insieme il nome de’ suoi architetti, Ctesifonte, Demetrio e Teonio[1107]; si nominano i Propilei d’Atene e nel medesimo tempo ci si fa sapere che ne fu architetto Mnesicle. Plinio[1108] ricorda il celebre Arsenale Ateniese, e ci dice che l’architetto ne fu Filone; fa menzione del famoso Laberinto di Lesurnio, e fra gli architetti nomina Teodoro[1109]. Sostrato si nomina quando si parla del Foro d’Alessandria[1110]. Si fa menzione del Foro Traiano, e si ricorda Apollodoro[1111]; si rammenta il tempio dell’Onore e della Virtù, ed ecco dirsene l’autore Muzio[1112].
Demetriano e Detriano sono ricordati in occasione del tempio della dea Bona e del trasferimento della sua statua[1113].
Ricordano Prisciano[1114] e Cornelio Nipote il tempio di Marte al Circo Flaminio, e dicono che Edmodono ne fu l’autore.
Plinio Giuniore[1115] dice che Mustio fu l’architetto del tempio di Cerere e de’ Portici. Narrasi che nei giuochi di Libone per la prima volta si coprì il teatro, e se ne dice autore Valerio Ostiense[1116]. Così pure non si nomina il Portico di Ottavia, senza che si ricordi Batraco; il tempio di Venere e Roma, senza che si nomini Adriano; e via via.
Ora, come mai quello stesso Marziale, che tanto lodò Rabirio[1117] per una fabbrica che non si può certamente paragonare col Colosseo, non nominò, non lodò, anzi come mai non scrisse, non dico un epigramma, ma nemmeno una parola in lode di colui che architettò ed edificò quella maraviglia mondiale, alla quale egli stesso dedicò ben 28 epigrammi, un libro intiero?
Dicemmo che Suetonio, nella vita di Vespasiano, narra che quest’Imperatore usò premiare quegli artisti che lo servivano: e questa fu una proprietà speciale di Vespasiano, giacchè quest’atto di liberalità Suetonio non lo attribuisce a nessun altro Imperatore. Ora se dice che donò premi ed onori ai retori greci e latini, ai poeti, al restauratore del Colosso di Nerone, ad un meccanico per aver fatto il semplice progetto del trasporto d’ingenti colonne [321] al Campidoglio, al trageda Apollinare, ai citaristi Tarpeio e Diodoro; perchè nulla ci dice del premio che, meritamente e con più ragione che agli altri, si sarebbe dovuto dare dal liberale Imperatore all’architetto della fabbrica più grandiosa della sua epoca: all’autore, dico, di quella maraviglia mondiale?
È questo un problema storico, il quale, come ben dice l’O’Reilly[1118] è di facile e chiara soluzione, se il silenzio degli storici pagani s’attribuisca all’odio che essi nutrivano verso i cristiani, e all’astio che avevano di vedere che un’opera così stupenda e così celebre fosse stata architettata da un cristiano: ma il problema è altrettanto oscuro e di difficile soluzione se si tentino altre spiegazioni.
Finalmente conferma ciò che si è finora detto, il consenso universale. Appena questo nostro epitaffio rivide la luce, tosto fu appropriato all’architetto del Colosseo; e le parole del Bellori: elapsis annis reperta.... quae amphitheatri Flavii Architecto adscribitur, ne sono una prova.
A quell’epoca non v’era certamente ragione di partito, d’interesse, o di altro, perchè si desse a questa lapide una simile interpretazione. In quell’epoca (secolo XVII), il Colosseo, come abbiam visto, era abbandonato; non era ancora stato solennemente dedicato al culto; anzi poco tempo dopo, era addivenuto un ricovero di malandrini, ecc. E nessuno si sarebbe presa certamente la briga di cercare il nome dell’architetto di quella fabbrica, in tempi in cui il monumento era purtroppo trascurato; quando nessuno aveva fatto in proposito la minima questione; e molto meno poi si sarebbe cercato l’architetto di quell’edificio pagano e destinato a’ giuochi tanto odiati dai fedeli, in un cimitero sotterraneo cristiano; e se il volgo e i dotti diedero a quella lapide (venuta allora alla luce, e trovata al posto, murata in un loculo) l’interpretazione esposta, fu perchè questa risulta chiaramente dalla lapide stessa. Nè si dica doversi ciò attribuire all’ignoranza dei tempi e a persuasione erronea; poichè non è verisimile che l’errore e l’ignoranza trionfino lungamente, e trionfino su persone di ogni sorta, tanto dotte che ignoranti. Ben presto l’ignoranza viene illuminata, l’errore vinto, l’inganno smascherato.
Ora quest’interpretazione data alla nostra lapide, non pur da anni, ma da tre secoli, dura; e non solo è ritenuta vera tenacemente dal volgo, ma eziandio dai dotti da noi citati, ed anche da altri contemporanei, i quali, se non hanno scritto intorno a questa lapide, pure da me consultati hanno risposto essere dello stesso parere mio[1119], ad eccezione di alcuni i quali, o dubitano, o negano recisamente, adducendo però argomenti puramente negativi.
[322]
Dunque quest’interpretazione si può dire costante e generale, la quale, appunto perchè tale e perchè spontanea, è vera, e forma uno di quei criterî filosofici di verità, i quali ci rendono moralmente certi di una cosa.
E qui potrei conchiudere, ma prima voglio rispondere ad alcune difficoltà che si presentano.
Il Bellori dubita che il nostro Gaudenzio possa essere stato l’architetto del Colosseo perchè in ipso (marmore), così egli, non Amphitheatri sed theatri mentio habetur.
Rispondo innanzi tutto, che:
Pictoribus atque poetis
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.
Ora, essendo l’iscrizione di Gaudenzio un epitaffio che l’autore ha voluto scrivere con un certo ritmo, è perdonabile che egli abbia detto «teatro» invece di «anfiteatro», giacchè usando quest’ultima voce, l’ultimo verso avrebbe sonato molto male. Di più, non può fare difficoltà che in un epitaffio di questa natura si sia usato il genere per la specie. Ora è certo che la voce «teatro» potè usarsi, e si usò effettivamente anche dai classici, per indicare in genere qualunque edificio o luogo atto a celebrarvi spettacoli[1120]. Dunque lo scrittore del nostro epitaffio avrebbe potuto usare questa voce, anche se fosse stato un letterato. E ciò è così vero, che la legge che riguardava gli spettacoli, fu detta dagli antichi lex theatri: e senza perder tempo in cercar prove per dimostrarlo, valga per tutte quell’iscrizione appartenente appunto all’Anfiteatro Flavio, incisa su di uno dei gradi, ove leggesi:
IB. IN THEATR. LEGE. PL VE...... VR IA
ICET. P.. X I I R
(C. I. L. 6. Pars. 4ª add. 32098).
E questo vuol dire che, secondo la legge degli spettacoli, lex theatri, nell’anfiteatro si assegnavano tanti posti ad una data associazione, ecc.
Del resto, la voce theatrum usata in quest’iscrizione, per la ragione già detta, non potea dar luogo ad equivoci, e dovea necessariamente interpretarsi per Amphitheatrum, anche perchè l’opera massima fatta da Vespasiano per gli spettacoli, non fu un «teatro», ma l’Anfiteatro nostro.
Quindi non pare che questa difficoltà possa veramente fare ostacolo.
Un’altra obiezione è tratta dalla qualità della persona di Gaudenzio. Se questi fu cristiano, si dice, non potè essere architetto dell’Anfiteatro Flavio, [323] perchè un cristiano non avrebbe osato architettare un edificio per un genere di spettacoli, nei quali (senza dire che tutti e sempre gli spettacoli furono con ragione aborriti dai cristiani) lo spargimento del sangue umano era l’oggetto del divertimento e del plauso del popolo; e tali appunto erano quelli che si davano negli anfiteatri.
E questo va benissimo; ma io già previdi questa difficoltà e l’accennai quando dissi che la prima idea di erigere media urbe (e precisamente ove erano gli stagna Neronis) un edificio, non fu quella che l’edificio stesso servisse per darvi spettacoli gladiatorî e venatorî, ma per farvi giuochi navali ed incruenti. Si dovea, cioè, edificare una naumachia, della quale, come dissi, parla Marziale. E che la primitiva disposizione dell’Anfiteatro Flavio fosse stata per naumachia, l’ho già dimostrato nel corso dell’opera.
Inoltre i cristiani non correvano certamente, senza una speciale ispirazione, incontro alla morte; ma se erano perseguitati fuggivano, secondo l’insegnamento del Maestro, in aliam terram.
E non solo materialmente, ma evitavano la morte anche con mezzi leciti ed onesti, dei quali potevano usare senza offendere la loro fede. Ora se noi supponiamo che Gaudenzio fosse liberto di Vespasiano[1121], ciò che è assai verosimile, e che fosse stato costretto a prestare la sua opera al Patrono, cui, per la libertà ricevuta, era in dovere d’ubbidire; io non vedo la ragione per cui Gaudenzio, benchè cristiano, si fosse potuto ricusare di servire il suo Patrono nella costruzione di una fabbrica, lo scopo della quale (per sè e riguardo alla costruzione materiale, che spetta all’architetto) è del tutto indifferente, colla certezza di esser ucciso.
Ma anche ammesso che l’Anfiteatro Flavio fosse stato fin dalla prima idea costruito per darvi giuochi cruenti; dato che Gaudenzio non fosse stato liberto di Vespasiano; allora dirò col Piale[1122], che, appunto per questo, fu fatto uccidere da Vespasiano; perchè, cioè, fattosi poi cristiano, si ricusò di prestare più oltre l’opera sua in quell’edificio. Dunque quest’obiezione o non nuoce o conferma l’asserto.
Sennonchè questa soluzione è causa di una nuova difficoltà. Se il nostro Gaudenzio fu un personaggio cotanto celebre e martire della Chiesa nascente perchè non se ne fa menzione nei martirologî, nei calendarî, negli indici, nei fasti della Chiesa Romana? Come è che si ricordano un Gaudenzio martire in Africa, un Gaudenzio di Novara, un Gaudenzio di Rimini, un Gaudenzio di Arezzo, ecc.; e del nostro Gaudenzio non si fa nessuna menzione?
[324]
Rispondo:
I nomi dei martiri non erano registrati nei calendarî, nei martirologî, negli indici, ecc., se non dopo praticata la così detta vindicatio. Ora questo processo di riconoscimento vi sarà stato relativamente al martirio di Gaudenzio? Dalla lapide si rileva che egli fu martire, premiatus es morte, ecc.; ma noi non sappiamo positivamente se sia stato o no vindicatus. E se la Chiesa non dichiarò che Gaudenzio sparse il suo sangue per la fede, non potè essere venerato dai fedeli. Mancando dunque il dato positivo della vindicatio, non v’ha ragione di maravigliarci se nei cataloghi, nei martirologî, ecc., non si trova il nome di Gaudenzio; e dalla mancanza di questo nome non si può dedurre, come è chiaro, che egli non fosse vero martire[1123], e, molto meno, architetto del Colosseo.
Ma del resto questo è un argomento negativo, il quale di fronte a tanti argomenti positivi e diretti, non ha valore; e dal quale si potrebbe solamente dedurre che nessuna memoria si conosce di questo martire romano; mai però che questa memoria non sia esistita, o che un dì non possa (come tante altre memorie) tornare a luce. Anzi, se non m’inganno, a me sembra di trovare questa memoria nel martirologio di Usuardo, codice di Brussels, e precisamente al giorno 7 Maggio.
Dopo la memoria di Flavia Domitilla e di S. Giovenale, si legge: Ad radicem Montis Septimi passio S. Gaudentii martyris. Il Martirologio di Usuardo è d’epoca tarda, tardissimo è il codice di Brussels, e la sua autorità è assai debole; ma tutte le memorie dei codici martirologici sono sempre preziose per le ricerche archeologiche, massime quelle che mostrano un certo classicismo ed una certa antichità, da qualunque fonte esse provengano. Non disprezziamo dunque questa notizia isolata, e maturiamola con calcolo per la nostra ricerca.
È certo che il Gaudenzio ricordato in quell’inciso non è tra quelli finora conosciuti: quis hic Gaudentius sit, fateor me ignorare, scrisse il Sollier[1124].
È anche certo che il dettato di quest’inciso non ci costringe a dire che il Gaudenzio in esso ricordato sia dell’età di mezzo, giacchè l’aggiunto martyris ci fa escludere ciò, direi quasi, per natura; ed il nome Gaudenzio non è dell’età di mezzo, ma antico e non raro nei cimiterî romani, ed abbonda, dirò così, nei cimiterî della Via Nomentana, dai quali appunto uscì fuori la lapide di quel Gaudenzio di cui parliamo.
[325]
È certo eziandio ed innegabile che quest’inciso è dettato con tale laconismo e semplicità, che ci ricorda gli incisi dei martirologî più antichi, il dato caratteristico dei quali è appunto la semplice indicazione topografica, il nome del Santo e il suo aggiunto distintivo.
Ora tale è il nostro inciso (ad radicem montis Septimi. Gaudentii martyris)[1125]. Dunque quest’inciso è un brano perduto di un martirologio antichissimo, ma che, per fortuna, fu conservato dal codice di Brussels del Martirologio d’Usuardo. Esaminiamo ora questo prezioso inciso, e cerchiamo chi sia il Gaudenzio in esso ricordato.
Che questo Gaudenzio sia un martire romano me lo dice l’indicazione topografica: ad radicem montis Septimi.
In nessuna geografia, sia antica che moderna, ho potuto trovare un monte di questo nome. Soltanto Varrone[1126], allorchè parla dell’Esquilino, dice: Septimius mons quinticepsos lucum Petilium.
Questa è la lezione della maggior parte dei codici e ritenuta dai migliori interpreti, non ostante lo Sceptius dello Sprengel, che non è alla fine che una scorrezione ed abbreviazione di Septimius malamente letto e peggio interpretato. I moderni leggono Cespius[1127], ma la questione di questo passo Varroniano è questione di fatto.
Qual’è la vera lezione, l’antica o la moderna? Fino alla metà circa del secolo scorso si ritenne per vera la lezione da me seguita. Lo Scaligero, il Turnebo, l’Agostini lessero Septimius mons quinticepsos, e su questa lezione fecero i loro lavori[1128]. Il testo seguito dallo Scaligero è anche più antico di quello da me e da altri finora ritenuto, ma similissimo; ed io ho seguito l’edizione pubblicata (dopo quella della fine del secolo XVI) in Roma.
I topografi, come ad es. il Nardini e il Brocchi, seguirono quest’edizione fino alla metà del secolo scorso; il Nibby[1129] poi s’attenne a questa stessa edizione nonostante conoscesse quella del Müller e le varianti accettate e preferite dai moderni.
Come è dunque che i recenti hanno pubblicato un’edizione così diversa da quella, e, per aggiunta, mutila?
Forse han veduto e seguito un codice più imperfetto di quello veduto e seguito degli antichi, o, seguendo l’andazzo dei nostri tempi, hanno corretto il testo secondo le loro opinioni?
[326]
Lo Stara-Tedde[1130] scrive: «Nel documento degli Argei (quale la presentano e seguono i moderni) manca l’indicazione del secondo sacello, giacchè dal princeps si passa al terticeps, omettendo il biceps.... omissione che certo non dovea originariamente trovarsi nel documento[1131], ma da attribuirsi allo stato lacunoso in cui ci è pervenuto il testo varroniano». E perchè non seguire il testo Varroniano che ha l’indicazione del secondo sacello?
Nel testo ritenuto e seguito dai moderni manca parimenti quell’Esquiliae duo montes habiti, quod pars Cispius mons suo antiquo nomine etiam nunc in sacreis appellatur.
Varrone[1132] divide l’Esquilino in due prominenze principali: Esquiliae duo montes habiti quod pars Oppius (così legge il Müller), pars Cespius mons suo antiquo nomine. Tanto l’Oppio che il Cispio ci sono noti: gli archeologi ritengono concordemente che il primo risponde a quella sommità dell’Esquilino ov’è S. Pietro in Vincoli; il secondo all’altro ov’è S. Maria Maggiore. L’Oppius è diviso da Varrone[1133] in più località, ognuna delle quali aveva il suo nome speciale. Così: Oppius mons princeps lucum Esquilinum, lucum fagutalem quae sub moerum est. Oppius mons bicepsos simplex. Oppius mons tercicepsos lucum Esquilinum dexterior via in Tabernola est. Oppius mons quadricepsos lucum Esquilinum via dexterior in figlineis est. Septimius mons quinticepsos lucum Petilium. Esquilinus. A suo luogo esamineremo una per una queste località dell’Esquilino. Che il Settimio si debba collocare nell’Oppio e non nel Cispio ce l’indica, la topografia del monte.
Noi abbiamo fra questo e quello una gola che separa le due località dell’Esquilino, e senza perderci in inutili parole, metto sotto gli occhi del lettore la pianta altimetrica dell’ingegnere Francesco Degli Abbati[1134], fatta da noi parzialmente ma fedelmente riprodurre (V. Fig. 15ª).
Quindi non si può cambiare, come fanno i moderni, il Septimius in Cispius, perchè quella prominenza non si trova situata sul Cispio ma sull’Oppio.
Il nome Septimius deriva, a mio modo di vedere, dai sacrifici che si facevano in occasione del Septimontium, i quali, al dire di Festo, si celebravano (per ciò che riguardava il monte Esquilino) in quella parte del monte che si chiamava Oppio. Ed io congetturo che detto sacrificio si celebrasse precisamente in quella cima dell’Oppio che era più prossima al Palatino, centro [327] del Septimontium, e che prendesse il nome di Septimius per specificarla dalle altre cime dell’Oppio stesso. Questo viene confermato dalle parole del lodato Varrone, il quale soltanto a questa e non ad altre prominenze dell’Oppio dà un nome proprio: Oppius mons, princeps; Oppius mons, bicepsos; Oppius mons, tercicepsos; Oppius mons quadricepsos; Septimius mons quinticepsos, ecc.[1135].
È vero che ivi negli Argei si legge anche Esquilinus sexticepsos; ma ciò si spiega benissimo, perchè, la sesta cima era su quella parte dell’Oppio che, per antonomasia, era chiamata Esquilino, essendovi là il Forum Esquilinum, il Campus Esquilinus, etc.
Esaminiamo ora una per una le località suddette.
1.º Oppius mons princeps lucum Esquilinum, lucum Fagutalem sinixtra quae sub moerum est. Quel lucum Esquilinum ci fa necessariamente collocare questa parte dei monte in vicinanza alla spianata di esso monte; imperocchè è la parte che più propriamente si dice Esquilinus. Ivi è ricordata la porta Esquilina, ivi il campus Esquilinus, ivi il forum Esquilinum: in una parola, [328] la denominazione Esquilinus competeva più propriamente a quella parte che alle altre. Dunque l’Oppius mons princeps era quella parte del monte che è presso la già villa Caserta (ora chiesa di S. Alfonso all’Esquilino), ove anni indietro venne in luce il muro antichissimo della città, sinistra quae sub moerum est.
2.º Oppius mons bicepsos simplex. Questa località (senz’altro aggiunto, perchè non se ne fa menzione veruna) mi sembra che sia quella parte del monte, alla quale più propriamente fu dato, e che tuttora conserva, il nome di Oppio; ossia quella parte che è in prossimità, come si è detto, della Chiesa di S. Pietro in Vincoli.
3.º Oppius mons tercicepsos lucum Esquilinum dexterior via in tabernula est. Questa, per quel lucum Esquilinum, non potremo separarla dalla prima; ma per quel dexterior via in tabernula est, la dovremo dire rivolta al Celio, perchè la tabernula era nel Ceriolense, qua itur Coelium; e quindi è quella parte dell’Oppio che ha a sinistra l’Esquilino propriamente detto, e che è rivolta al Celio.
4.º Oppius mons quadricepsos lucum Esquilinum via dexterior in figlineis est. Per quel lucum Esquilinum non si può disgiungere dalle antecedenti; per quel dexterior poi, conviene situarla da quella parte stessa che guarda il Celio; e quindi la collocherei nella parte sovrastante alle velocia munera[1136], le quali sorsero in quel luogo già occupato, fino ai tempi di Nerone, da meschini abituri, probabilmente di figlini, come c’insegna Marziale:
«Hic ubi miramur velocia munera thermas,
Abstulerat miseris tecta superbus ager».
5.º Esquilinus. Ultimo punto dell’Oppio, a Nord, ricordato da Varrone. Per la sua denominazione assoluta (Esquilinus), e per la mancanza dell’aggiunto: mons (benchè non si ricordi alcun bosco), credo sia propriamente quella parte cui si diè e si dà tuttora il nome di Esquilino.
Per il Septimius mons quinticepsos lucum Petilium, situato, secondo Varrone, fra il quarticepsos e l’Esquilinus, non rimane dunque altra sommità dell’Oppio che quella in cui vi sono i grandi ruderi delle Terme e della Domus Titi, incontro all’Anfiteatro Flavio. E qui appunto il Nibby[1137] colloca il mons Septimius. L’autorità del Nibby è sempre grande; ma in questo caso è maggiore, perchè egli qui, non sostiene una sua opinione particolare, non difende l’autenticità di una località da lui già ammessa e da altri contrastata; ma ciò [329] che scrisse lo scrisse senza prevenzione alcuna, e soltanto per effetto della sua scienza topografica, della conoscenza che egli aveva della topografia di Roma.
Insomma: il Cispio era la sommità ove è S. Maria Maggiore: l’Oppio era diviso in più parti, delle quali l’Oppius simplex era quello ove è S. Pietro in Vincoli; Esquilinus, ov’era il campus Esquilinus propriamente detto: l’Oppius princeps, l’Oppius tercicepsos e l’Oppius quadricepsos (per il lucum Esquilinum a tutti e tre comuni) si debbono collocare in modo, che più s’avvicinino a quella parte che era detta per antonomasia Esquilinus, e che siano ben distinte le due parti; il princeps (per quel sinistra quae sub moerum est) sotto la già Villa Caserta; il tercicepsos (per quel dexterior via in tabernola est) deve collocarsi rivolto al Celio, ma non più in là delle Terme, perchè ivi (per l’aggiunto in figlineis) v’era il quadricepsos; e per il Septimius, quinticepsos, non resta che quella parte che sovrasta il Colosseo.
E questa denominazione era ancor vigente nel secolo VIII, giacchè nel Liber Pontificalis (in Leone III) si fa menzione di una basilica dedicata a S. Michele Arcangelo: S. Arcangeli in Septimo; basilica che qualcuno credè situata in milliario septimo della Via Salaria.
Ma vi sono molte ragioni per non dare a quel passo una simile interpretazione.
E primieramente, perchè quelle basiliche extramuranee, ricordate nella vita di quel Pontefice, sono basiliche cimiteriali, edificate su qualche memoria di martiri e santi celebri, e non in onore di Angeli e di Arcangeli.[1138]. Secondariamente poi, perchè manca l’indicazione della via. Dice in Septimo ma di qual via?
Al contrario, quando nella stessa vita (di Leone III) si parla di chiese extramuranee, si dice: B. Stephani primi martyris constituta via latina milliario tertio. — S. Cyriaci posita via Ostiensi. — S. Valentini in Flaminia. — B. Andreae Apostoli sita in tricesimo via Appia.
Relativamente a quel S. Marcelli sitam in quartodecimo, siccome immediatamente prima s’era parlato di S. Aurea in Ostia, potrebbe intendersi che fosse situata in via Ostiensi.
[330]
Ma la nostra basilica è posta fra due intramuranee, come or ora vedremo, e non fra le extramuranee. Infine, lo scrittore della vita di Leone III non segue già un ordine topografico nell’enumerazione delle chiese arricchite dai doni di quel Pontefice; e se anche avesse voluto non avrebbe potuto. È nondimeno certo e incontestabile che, generalmente parlando, le chiese di una regione o di una località sono aggruppate insieme. Così leggiamo che Leone III fece dei donativi alla Diaconia Beati Hadriani, et in ecclesia beatae Martinae....., et in Diaconia antiqua. — Immo et in Diaconia S. Theodori..... et in Diaconia Sanctorum Cosmae et Damiani..... et in Diaconia S. Adriani. — Et in Diaconia S. Luciae, quae ponitur in Orphea[1139]....... et in Diaconia Beati Viti Martyris quae ponitur in Marcello. E così di altre. Ora la nostra basilica è ricordata fra S. Agata[1140] e S. Agapito in Vincula, ossia fra due chiese situate nella località varroniana dell’Esquilino. Quindi diremo che la basilica S. Arcangeli quae ponitur in Septimo non è la basilica extramuranea situata al settimo miglio, o sesto secondo il Martirologio Geronimiano (codice di Berna), passo d’altronde un po’ confuso, ma una basilica intramuranea, citata cioè nella stessa guisa con cui si cita il monasterium Sancti Iohannis qui ponitur in Appentino, ossia in Aventino monte[1141].
Nello stesso Libro Pontificale[1142] in Simmaco, leggiamo: «Intra civitatem Romanam, basilicam Sanctorum Silvestri et Martini a fundamentis construxit. .... Ad beatum Iohannem et Paulum fecit gradus post absidam. Item ad Archangelum Michael basilicam ampliavit et gradus fecit et introduxit aquam. Item ad Sanctam Mariam, oratorium sanctorum Cosmae et Damiani a fundamentis construxit».
Il Duchesne[1143] dice che la Chiesa di S. Michele ricordata in questo passo non può essere quella situata al settimo miglio della Salaria, perchè qui è scritto: «intra civitatem Romanam» ed ivi si fa menzione di lavori eseguiti a cura di Simmaco alle chiese di S. Martino, dei Ss. Giovanni e Paolo, di S. Michele e di S. Maria Maggiore.
E questo significa che il Duchesne ritiene che nell’interno della città esistè una chiesa dedicata a S. Michele, situata nella stessa località ricordata nella vita di Leone III, quando si parla di S. Michele in Septimo, fra la chiesa [331] di S. Agapito, qui ponitur ad Vinculam, e quella dei santi Silvestro e Martino. Lo stesso Duchesne[1144] scrive che la chiesa di S. Agapito è quella stessa che più tardi fu detta S. Maria (ante titulum Eudoxiae) ossia il monastero (S. Mariae) ad S. Petrum in Vincula.
Dice inoltre che S. Maria in Monasterio era situata dietro la chiesa di S. Pietro in Vinculis; vale a dire più su quella cima dell’Oppio detta Esquilinus che sul Septimius. A pag. 61, n. 63, tomo II, aggiunge però che, da un documento del 1014 la chiesa di S. Maria in Monasterio è detta ANTE Titulum Eudoxiae. L’Armellini, il quale pubblicò la seconda edizione delle «Chiese di Roma» alcuni anni dopo dell’edizione duchesniana del Liber Pontificalis, dimostrò ad evidenza che la chiesa di S. Maria in Monasterio, cioè S. Agapito, era di fronte alla Chiesa di S. Pietro in Vinculis, che è quanto dire sul Settimio.
La Chiesa di S. Michele in Septimo, ricordata fra quelle di S. Pietro in Vinculis e S. Agapito, sorgeva dunque su quella parte dell’Oppio che si disse Septimius, cangiato poi in Septimus o per una delle solite alterazioni causate dal tempo e dagli uomini, od anche, e più verosimilmente, perchè il copista tralasciò una i; ed in questo caso noi dovremmo leggere senz’altro: Basilica S. Arcangeli in Septimio (monte).
Nè fa ostacolo la sentenza del Nardini, il quale, a motivo di quel Petilium lucum aggiunto al Settimio, cerca questo nell’Esquilino sì, ma verso il Viminale; e lo deduce da quel Petilinum lucum di Livio. Ma innanzi tutto Petilium o Poetelium e Petilinum o Poetelinum sono nomi ben diversi; eppoi, quel Lucus Petelinus menzionato da Livio e da Plutarco, a proposito del giudizio contro M. Manlio, trovavasi extra portam Flumentanam (così leggono ormai quasi tutti i critici, invece di frumentariam); e questa porta i topografi la collocano presso il Forum Olitorium, e cioè tra l’odierno Ponte Rotto e il Ponte Quattro Capi, presso a poco ove ora è la Via o Vicolo del Ricovero[1145].
Nemmeno fa ostacolo l’opinione del Corvisieri, il quale crede che questa parte dell’Oppio fosse detta Coliseo[1146]. Imperocchè, pur concedendo che tal nome fosse stato dato a quella collina, sarebbe sempre il nome volgare, (il nome dato al tempio d’Iside, come egli dice, situato in quel colle (!) per distinguerlo forse da qualche altro tempio dello stesso nome); ma il nome classico, il vero nome, il nome proprio sarebbe stato sempre quello di Septimius in tempi remoti, e di Septimus (se così si voglia leggere) in tempi meno antichi: e così qui verrebbe a proposito il detto del medesimo autore: che, cioè, [332] nella stessa città s’incontrano contrade e monumenti più conosciuti per un nome di volgare capriccio che per il vero dato loro in origine.
Questa soluzione però gioverebbe se vi fosse difficoltà, ma per me questa difficoltà non esiste. Imperocchè il tempio d’Iside della III regione non fu (nè deve quindi supporsi collocato) sulla collina che sovrasta all’Anfiteatro. Noi già confutammo l’opinione del Corvisieri nella Parte II, cap. I di questo studio; riputiamo quindi inutile ripetere quanto allora dicemmo.
Pertanto, conchiudendo, diremo che nessuna località geografica è conosciuta col nome di mons Septimius; e soltanto, per testimonianza di Varrone e del Libro Pontificale, si ricorda in Roma una parte dell’Esquilino così denominata.
Dunque il martire che si legge nell’inciso del codice di Brussels è un martire romano.
Ma nessun martire di nome Gaudenzio è conosciuto in Roma, ad eccezione di quello di cui si parla nella lapide che ha motivato questa lunga dissertazione. Dunque probabilmente è questo il martire ricordato nell’inciso del Martirologio d’Usuardo, codice di Brussels.
Quanto non sarebbe eloquente per la storia del nostro Gaudenzio questa località, designata dal Martirologio Brusellense, con quelle parole: «Ad radicem montis Septimi [i] passio S. Gaudentii martyris»?..... Ci direbbe insomma che Gaudenzio, liberto di Vespasiano, fu fatto uccidere nella casa del suo padrone, dinanzi alla fabbrica da lui edificata, ove appunto fu scoperto uno degli oratorî che attorniavano il Colosseo; unico oratorio (come dicemmo quando parlammo delle chiese ed oratorî che circondarono l’Anfiteatro Flavio) rimasto senza nome.
Ma, ripeto, questa non è che una mia congettura, della quale, se a qualcuno piacesse potrà servirsene per dire chi sia quel Gaudenzio che il Sollier confessava di non sapere, fateor me ignorare; e rimarrebbero soddisfatti anche coloro, i quali, col Muratori, s’auguravano che un giorno gli studiosi avrebbero fatto un po’ di luce su quel Gaudenzio ignoto.
Riassumiamo. Abbiamo visto:
1º che la lapide di Gaudenzio fu rinvenuta negli scavi praticati nel secolo XVII nel cimitero di S. Agnese sulla Via Nomentana;
2º che alla marchesa Randanini non costò l’acquistarla, e che non si può supporre una falsificazione fatta a scopo di lucro;
3º che a nessuno degli scopritori si dà lode dagli autori coevi al rinvenimento, perchè essa fu trovata a caso inaspettatamente, invece di essere stata studiosamente cercata;
4º che a quell’epoca non v’era questione di sorta sull’architetto del Colosseo; e quindi non vi potè essere chi, per far trionfare la propria opinione, [333] avesse motivo di nascondere quella lapide sotto le frane di un cimitero sotterraneo;
5º che non fanno ostacolo all’autenticità della stessa lapide la paleografia, gli apici e la dicitura;
6º che anche ai tempi di Vespasiano vi poterono essere martiri, e che vi furono effettivamente; ed abbiamo addotte le ragioni plausibili per ammettere che Gaudenzio potesse essere l’architetto del Colosseo;
7º abbiamo veduto, finalmente, che il Gaudentius menzionato nel Martirologio di Usuardo è probabilmente il nostro.
Non è dunque ormai ragionevole negare recisamente l’autenticità della lapide «Sic premia servas», basandosi soltanto sugli argomenti negativi generalmente addotti e da noi sfatati. Ed io son certo che ogni uomo di buona volontà dovrà convenire che, se i miei argomenti non sono del tutto atti a dimostrare apoditticamente la genuinità di quella lapide, sono almeno atti a suscitare dei dubbi, i quali faranno sì che i dotti, col loro studio, tornino sopra una tanto scabrosa questione.
[335]
[337]
«Colosseo, mirabile reliquia
Del romano poter. Le folte PIANTE
Lungo que’ ruinati archi cresciute,
Piegavano, ondulando, i freschi rami
Sul cupo azzurro della notte....»
Lord Byron, Manfredo (Trad. del Maffei).
L’anfiteatro Flavio fu e sarà sempre l’oggetto di universale ammirazione, ed uno dei più fecondi nuclei di serî studî ed accurate ricerche. Poeti e storici, architetti ed archeologi, numismatici ed epigrafisti gareggiarono per descriverlo ed illustrarlo; tutti, con vero amore ed entusiasmo, offrirono alla venerabile mole dei Flavî il contributo del loro ingegno. E come appunto il Fontana[1147], il Marangoni[1148], il Nibby[1149], il Tocco[1150], il Gori[1151], ecc., parlarono del Colosseo in una maniera più o meno completa; il Lipsio[1152], il Maffei[1153], il Barthelémy[1154], l’Alonio[1155], il Canina[1156], ecc., lo descrissero ora considerandolo isolatamente, ora confrontandolo con altri anfiteatri; come, [338] dico, il Marini[1157], il Fea[1158] l’Uggeri[1159], lo Hübner[1160], il Mommsen[1161], il Lanciani[1162], ecc., pubblicarono pregevoli monografie illustrando respettivamente il podio, i sedili, gli scavi, le epigrafi, ecc.; e come, finalmente il Morcelli[1163] trattò delle tessere e degli spettacoli; il Donaldson[1164] delle medaglie, e Mons. Lugari procurò rivendicare ai Martiri l’arena dell’Anfiteatro Flavio[1165]; così non mancarono studiosi i quali prendessero ad esaminare la flora e le piante, che in tempi men remoti spontaneamente nascevano e vegetavano sull’arena, sui semidiruti gradi e sulle fatiscenti pareti dell’abbandonato Anfiteatro.
L’anno 1815 un botanico romano[1166] pubblicava uno studio sulle 260 specie di piante che allora ricoprivano l’Anfiteatro[1167]. Più tardi, nel 1873, il ch. Richard Deakin[1168] pubblicava un’opera ancor più completa sulla «Flora of the Colosseum», facendola ascendere a 420 specie di piante.
Ed ora, perchè questo nostro lavoro riesca più completo che sia possibile crediamo opportuno occuparci anche noi di quel pittoresco ammanto di verdura fatto togliere nel 1871 dal comm. Pietro Rosa[1169] e seguendo la scorta del suddetto Prof. R. Deakin, passiamo senz’altro ad indicare quelle piante che già costituirono la FLORA DEL COLOSSEO.
[339]
La Flora del Colosseo.
| ORD. NAT. | ||
| GENERE | SPECIE | |
| I. | ||
| Ranunculaceae | ||
| Clematis, Linn. | Clematite Ital. | C. Flammula, Linn. |
| Anemone, Linn. | Anemone Ital. | A. Hortensis, Linn. |
| Ranunculus, Linn. | Ranuncolo Ital. | R. repens, Linn. |
| Delphinum, Linn. | Speronella Ital. | D. peregrinum, Linn. |
| II. | ||
| Malvaceae (Iuss.) | ||
| Malva, Linn. | Malva Ital. | M. Sylvestris, Linn. |
| Malva, Linn. | Malva Ital. | M. Rotundifolia, Linn. |
| III. | ||
| Crassulaceae (De Cand.) | ||
| Sedum, Linn. | Sempreviva Ital. | S. cepaea, Linn. |
| Sedum, Linn. | Sempreviva Ital. | S. gallioides, All. |
| Sedum, Linn. | Sempreviva Ital. | S. album, Linn. |
| Sedum, Linn. | Sempreviva Ital. | S. acre, Linn. |
| Sedum, Linn. | Sempreviva Ital. | S. reflexum, Linn. |
| Sedum, Linn. | Sempreviva Ital. | S. anopetalum, De Cand. |
| Umbilicus, De Cand. | Scodellina o erba bellica | U. pendulinus, De Cand. |
| IV. | ||
| Rosaceae (Iuss.) | ||
| Prunus, Linn. | Ciriegia Ital. | P. avium, Linn. |
| Pyrus, Linn. | Pero Ital. | P. communis, Linn. |
| Geum, Linn. | Erba benedetta Ital. | G. urbanum, Linn. |
| Potentilla, Linn. | Cinquefoglio Ital. | P. recta, Linn. |
| Potentilla, Linn. | Cinquefoglio Ital. | P. reptans, Linn. |
| Fragaria, Linn. | Fragole Ital. | F. vesca, Linn. |
| Rubus, Linn. | Rogo Ital. | R. corylifolius, Smith. |
| Poterium, Linn. | Pimpinella Ital. | P. sanguisorbia, Linn. |
| Agrimonia, Linn. | Agrimonia Ital. | A. eupatoria, Linn. |
| Rosa, Linn. | Rosa Ital. | R. sempervirens, Linn. |
| V. | ||
| Vitaceae (Lind.) | ||
| Vitis, Linn. | Vite Ital. | V. vinifera, Linn. |
| VI. | ||
| Celastrineae (R. Browil) | ||
| Euonymus, Linn. | Fusano Ital. | E. europaeus, Linn. |
| VII. | ||
| Paronychieae (St. Hil.) | ||
| Polycarpon, Linn. | Correggiola Ital. | P. tetraphillum, Linn. |
| VIII. | ||
| Carophilleae (Iuss.) | ||
| Sileneae | ||
| Tunica, Scop. | Tunica Ital. | T. saxifraga, Scop. |
| Dianthus, Linn. | Garofano Ital. | D. profifer, Linn. |
| Silene, Linn. | Garofano Ital. | S. inflata, Smith. |
| Silene, Linn. | Garofano Ital. | S. gallica, Linn. |
| Silene, Linn. | Garofano Ital. | S. quinquevulnera, Linn. |
| Silene, Linn. | Garofano Ital. | S. armeria, Linn. |
| Silene, Linn. | Garofano Ital. | S. italica, Pers. |
| Alsineae | ||
| Sagina, Linn. | S. procumbens, Linn. | |
| Sagina, Linn. | S. Apetala, Linn. | |
| Alsine, Wahl. | Alsine Ital. | |
| Alsine, Wahl. | Alsine Ital. | A. rubra, Wahl. |
| Alsine, Wahl. | Alsine Ital. | A. tenuifolia, Wahl. |
| Arenaria, Linn. | Arenaria Ital. | A. serpyllifolia, Linn. |
| Stellaria, Linn. | Stellaria Ital. | S. media, Whiter |
| Cerastium, Linn. | Cerazia Ital. | C. vulgatum, Linn. |
| Cerastium, Linn. | Cerazia Ital. | C. campanulatum, Vir. |
| Cerastium, Linn. | Cerazia Ital. | C. viscosum, Linn. |
| Mochringia, Linn. | M. trinervia, Clair. | |
| [340] | ||
| IX. | ||
| Lineae (De Cand.) | ||
| Linum, Linn. | Lino Ital. | L. strictum, Linn. |
| Linum, Linn. | Lino Ital. | L. catharticum, Linn. |
| X. | ||
| Cruciferae (Iuss.) | ||
| Cherianthus, Linn. | Leucoio Ital. | C. cheiri, Linn. |
| Arabis, Linn. | A. hirsuta, Brown. | |
| Cardamine, Linn. | Cardamino Ital. | C. hirsuta, Linn. |
| Cardamine, Linn. | C. impatiens, Linn. | |
| Sisymbrium, Linn. | Sisimbrio Ital. | S. officinalis, Scop. |
| Sisymbrium, Linn. | Sisimbrio Ital. | S. policeratium, Linn. |
| Sisymbrium, Linn. | Sisimbrio Ital. | S. irio, Linn. |
| Sisymbrium, Linn. | Sisimbrio Ital. | S. Thalianum, Gand |
| Diplotaxis, De Cand. | D. tenuifolia, De Cand. | |
| Diplotaxis, De Cand. | D. verna, Linn. | |
| Diplotaxis, De Cand. | D. muralis, Linn. | |
| Iberis, Linn. | Iberide Ital. | I. pinnata, Linn. |
| Lepidium, Linn. | Lepidio Ital. | L. granifolium, Linn. |
| Capsella, De Cand. | Borsa di pastore Ital. | C. bursa pastoris, De Cand. |
| Senebriera, Poir | S. coronopus, Poir | |
| Biscutella, Linn. | B. hispida, De Cand. | |
| Bunias, Linn. | Bunnio Ital. | B. erocago, Linn. |
| XI. | ||
| Cystineae (A. Brogn.) | ||
| Cystinus, Linn. | Imbrentina Ital. | C. hypocistus, Linn. |
| XII. | ||
| Geraniaceae (Iuss.) | ||
| Geranium, Linn. | Geranio Ital. | G. molle, Linn. |
| Geranium, Linn. | Geranio Ital. | G. robertianum, Linn. |
| Geranium, Linn. | Geranio Ital. | G. rotundifolium, Linn. |
| Geranium, Linn. | Geranio Ital. | G. dissectum, Linn. |
| Erodium, Linn. | E. cicutarium, L. Herit. | |
| Erodium, Linn. | E. moscatum, Sm. | |
| Erodium, Linn. | E. romanum, Willd. | |
| Erodium, Linn. | E. melacoides, Willd. | |
| XIII. | ||
| Rutaceae (Iuss.) | ||
| Ruta, Linn. | Ruta Ital. | R. bracteosa, De Cand. |
| XIV. | ||
| Oxalideae (De Cand.) | ||
| Oxalis, Linn. | Alleluia Ital. | O. Corniculata, Linn. |
| XV. | ||
| Saxifrageae (Linn.) | ||
| Saxifraga, Linn. | Sassifraga Ital. | S. granulata, Linn. |
| Saxifraga, Linn. | Sassifraga Ital. | S. tridactylites, Linn. |
| XVI. | ||
| Hypericineae (De Cand.) | ||
| Hypericum, Linn. | Pilatro Ital. | H. perforatum, Linn. |
| XVII. | ||
| Papaveraceae (Iuss.) | ||
| Papaver, Linn. | Papavero Ital. | P. rhaeas, Linn. |
| Papaver, Linn. | Papavero Ital. | P. dubium, Linn. |
| Chelidonium, Linn. | Celidonia Ital. | C. mayus, Linn. |
| XVIII. | ||
| Capparideae (Iuss.) | ||
| Capparis, Linn. | Capperi Ital. | C. spinosa, Linn. |
| XIX. | ||
| Cistineae (Dunal) | ||
| Helianthemum, Tourn. | H. gattatum | |
| Cistus, Linn. | Cistio Ital. | C. salvifolius, Linn. |
| XX. | ||
| Resediaceae (De Cand.) | ||
| Reseda, Linn. | Reseda Ital. | R. alba, Linn. |
| Reseda, Linn. | Reseda Ital. | R. phituma, Linn. |
| XXI. | ||
| Terebinthaceae (De Cand.) | ||
| Pistacia, Linn. | Lentischio Ital. | P. Terebinthus, Linn. |
| Pistacia, Linn. | Lentischio Ital. | P. Lentiscus, Linn. |
| XXII. | ||
| Violaceae (Lind.) | ||
| Viola, Linn. | Viola Ital. | V. odorata, Linn. |
| Viola, Linn. | Viola Ital. | V. canina Linn. |
| XXIII. | ||
| Fumariaceae (De Cand.) | ||
| Fumaria, Linn. | Fummosturno Ital. | F. capreolata, Linn. |
| Fumaria, Linn. | Fummosturno Ital. | F. officinalis, Linn. |
| Fumaria, Linn. | Fummosturno Ital. | F. parviflora, Linn. |
| XXIV. | ||
| Poligaleae (Iuss.) | ||
| Poligala, Linn. | Poligala Ital. | P. monspeliaca, Linn. |
| XXV. | ||
| Leguminoseae (Iuss.) | ||
| Loteae, De Cand. | ||
| Spartium, De Cand. | Sparzio Ital. | S. junceum, Linn. |
| Cytisus, De Cand. | Citiso Ital. | C. laburnum, Linn. |
| [341] | ||
| Anthyllis, De Cand. | Antillide Ital. | A. vulneraria, Linn. |
| Onosis, De Cand. | Onomide Ital. | O. spinosa, Linn. |
| Onosis, De Cand. | Onomide Ital. | O. arvensis, Linn. |
| Melilotus, Linn. | Meliloto Ital. | M. italica, All. |
| Melilotus, Linn. | Meliloto Ital. | M. indica, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. pratensis, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. ocroleucum, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. stellatum, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. scabrum, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. arvensis, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. repens, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. nigresicus, Vivian. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. hybridum, Savi |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. procumbens, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. filiforme, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. tomentosum, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. resupinatum, Linn. |
| Trifolium, Linn. | Trifoglio Ital. | T. subterraneum, Linn. |
| Lotus, Linn. | Mullaghera Ital. | L. corniculatus, Linn. |
| Lotus, Linn. | Mullaghera Ital. | L. ornithopodiodes, Linn. |
| Trigonella, Linn. | Fienogreco Ital. | T. corniculata, Linn. |
| Medicago, Linn. | Medica Ital. | M. lupulina, Linn. |
| Medicago, Linn. | Medica Ital. | M. orbicularis, Allel. |
| Medicago, Linn. | Medica Ital. | M. minima, Linn. |
| Medicago, Linn. | Medica Ital. | M. maculata, Sibth. |
| Medicago, Linn. | Medica Ital. | M. denticulata, Willd. |
| Medicago, Linn. | Medica Ital. | M. terebellum, Willd. |
| Medicago, Linn. | Medica Ital. | M. tribuloide, Lam. |
| Viceae, De Cand. | ||
| Vicia, De Cand. | Veccie Ital. | V. onobrychoides, Linn. |
| Vicia, De Cand. | Veccie Ital. | V. cracca, Linn. |
| Vicia, De Cand. | Veccie Ital. | V. gracilis, Lois |
| Vicia, De Cand. | Veccie Ital. | V. uniflora |
| Vicia, De Cand. | Veccie Ital. | V. sativa, Linn. |
| Vicia, De Cand. | Veccie Ital. | V. angustifolia, Sibth. |
| Vicia, De Cand. | Veccie Ital. | V. lutea, Linn. |
| Vicia, De Cand. | Veccie Ital. | V. hybrida, Linn. |
| Lathyrus, Linn. | Latiro Ital. | L. aphaca, Linn. |
| Lathyrus, Linn. | Latiro Ital. | L. sativa, Linn. |
| Lathyrus, Linn. | Latiro Ital. | L. pratensis, Linn. |
| Lathyrus, Linn. | Latiro Ital. | L. sylvestris, Linn. |
| XXVI. | ||
| Umbelliferae (Iuss.) | ||
| Hedysareae, De Cand. | ||
| Scorpiurus, Linn. | Scorpioides Ital. | S. subvillosa, Linn. |
| Coronella, Linn. | Coronilla Ital. | C. varia |
| Ornithopus, Linn. | Piede d’uccello Ital. | O. scorpioides, Linn. |
| Securigera, De Cand. | S. coronilla, De Cand. | |
| Sanicula, Linn. | Sanicula Ital. | S. Europaea, Linn. |
| Eryngium, Linn. | Eringo Ital. | E. campestris, Linn. |
| Agopodium, Linn. | Podagraria Ital. | O. podagraria, Linn. |
| Bupleurum, Linn. | Bupleuro Ital. | B. aristotatum, Bartb. |
| Bupleurum, Linn. | Bupleuro Ital. | B. odontites, Linn. |
| Bupleurum, Linn. | Bupleuro Ital. | B. rotundifolia, Linn. |
| Oenanthe, Linn. | Enante Ital. | Oe. peucedanifolia, Poll. |
| Foeniculum, Hoffm. | Finocchiella Ital. | F. vulgare, Gartn. |
| Ferula, Linn. | Ferula Ital. | F. communis, Linn. |
| Daucus, Linn. | Carota Ital. | D. muricatus, Linn. |
| Caucalis, Linn. | Caucali Ital. | C. daucoides, Linn. |
| Torilis, Adanson | T. infesta, Spreng. | |
| Torilis, Adanson | T. nodosa, Gartn. | |
| Scandix, Linn. | Cefolio Ital. | S. Pecten-Veneris, Linn. |
| Cheraphillum, Linn. | C. Temulentum, Linn. | |
| Smyrnium, Linn. | Macerone Ital. | S. olosatrum, Linn. |
| XXVII. | ||
| Ramneae (Iuss.) | ||
| Ramnus, Linn. | Ramio Ital. | R. alternatus, Linn. |
| Paliurus, Tourn. | Paliuro Ital. | P. aculeatus, Tourn. |
| XXVIII. | ||
| Arailaeae (Iuss.) | ||
| Hedera, Linn. | Edera Ital. | H. Helix, Linn. |
| XXIX. | ||
| Onograriae (Iuss.) | ||
| Circaea, Linn. | Circea Ital. | C. Lutetiana, Linn. |
| Epilobium, Linn. | Epilobio Ital. | E. hirsutum, Linn. |
| Epilobium, Linn. | Epilobio Ital. | E. montanum, Linn. |
| [342] | ||
| XXX. | ||
| Valerianeae (De Cand.) | ||
| Cantranthus, De Cand. | C. ruber, De Cand. | |
| Valerianella, Moerich. | V. Carinata, Loisel | |
| XXXI. | ||
| Compositae (Iuss.) | ||
| 1.º Conymbifereae | ||
| Tussilago, Linn. | Tossilaggine Ital. | T. farfara, Linn. |
| Erigeron, Linn. | E. canadensis, Linn. | |
| Senecio, Linn. | Erba calderina Ital. | S. vulgaris, Linn. |
| Inula, Linn. | Enula Ital. | I. odora, Linn. |
| Inula, Linn. | Enula Ital. | I. conyza, De Cand. |
| Inula, Linn. | Enula Ital. | I. sordida, De Cand. |
| Solidago, Linn. | Verga d’oro Ital. | S. virgaurea, Linn. |
| Pulicaria, Linn. | P. dysenterica, Cass. | |
| Bellis, Linn. | Margheritina Ital. | B. perennis, Linn. |
| Bellis, Linn. | Margheritina Ital. | B. sylvestris, Cyrill. |
| Bellium, Linn. | B. minutum, Linn. | |
| Crhysanthemum, Linn. | Crisantemo Ital. | C. leucanthemum, Linn. |
| Matricaria, Linn. | Matricaria Ital. | M. chamomile, Linn. |
| Anthemis, Linn. | La Camomilla Ital. | A. cotula, Linn. |
| Anthemis, Linn. | La Camomilla Ital. | A. mixta, Linn. |
| Anthemis, Linn. | La Camomilla Ital. | A. tinctoria, Linn. |
| Bidens, Linn. | Bidente Ital. | B. tripartita, Linn. |
| Achillea, Linn. | Achillea Ital. | A. agaratum, Linn. |
| Eupatorium, Linn. | Eupatorio Ital. | E. cannabium, Linn. |
| Chrysocoma, Linn. | Criso-coma Ital. | C. Linosyris, Linn. |
| Artemisia, Linn. | Assenzio Ital. | A. vulgaris, Linn. |
| Artemisia, Linn. | Assenzio Ital. | A. argentea, Willd. |
| Filago, Linn. | Filago Ital. | F. gallica, Linn. |
| Filago, Linn. | Filago Ital. | F. minima, Fries. |
| Filago, Linn. | Filago Ital. | F. germanica, Linn. |
| Calendula, Linn. | Calendula Ital. | C. arvensis, Linn. |
| 2.º Cynarocephaleae | ||
| Carlina, Linn. | Carlina Ital. | C. corymbosa, Linn. |
| Cardus, Linn. | Cardo Ital. | C. pycnocephalus, Iacq. |
| Cardus, Linn. | Cardo Ital. | C. leocrographus, Linn. |
| Cardus, Linn. | Cardo Ital. | C. marianus, Linn. |
| Lappa, Tourn. | Lappone Ital. | L. mayor, Gart. |
| Centaurea Linn. | Centaurea Ital. | C. nigra, Linn. |
| Centaurea Linn. | Centaurea Ital. | C. cyanus, Linn. |
| Centaurea Linn. | Centaurea Ital. | C. calcitrapa, Linn. |
| Centaurea Linn. | Centaurea Ital. | C. solstitialis, Linn. |
| 3.º Cichoraceae | ||
| Hypochaeris, Linn. | H. radicata, Linn. | |
| Chondrilla, Linn. | C. jucca, Linn. | |
| Picus, Linn. | P. hieracioides, Linn. | |
| Taraxacum Juss. | Dente di leone o soffione | T. officinalis, Wigg. |
| Taraxacum Juss. | T. dens leonis (Flora Rom.) | |
| Taraxacum Juss. | T. hirta, De Cand. | |
| Cichorium, Linn. | Cicoria Ital. | C. intybus, Linn. |
| Lactuca, Linn. | Lattuga Ital. | L. muralis, De Cand. |
| Lactuca, Linn. | Lattuga Ital. | L. saligna, Linn. |
| Lactuca, Linn. | Lattuga Ital. | L. scariola, Linn. |
| Sonchus, Linn. | S. oleraceus, Linn. | |
| Sonchus, Linn. | S. tenerrimus, Linn. | |
| Crepis, Linn. | C. biennis, Linn. | |
| Crepis, Linn. | C. pulcher, Linn. | |
| Hieracium, Linn. | Feracia Ital. | H. murorum, Linn. |
| Hieracium, Linn. | Feracia Ital. | H. Nestleri, Vill. |
| Hieracium, Linn. | Feracia Ital. | H. Pilosella, Linn. |
| Lapsana, Linn. | Lampsana Ital. | L. communis, Linn. |
| Zacintha, Tourn. | Z. verrucosa, Gart. | |
| XXXII. | ||
| Dipsaceae (De Cand.) | ||
| Knautia, Linn. | K. arvensis, Coult | |
| Scabiosa, Linn. | Scabbiosa Ital. | S. columbaria, Linn. |
| XXXIII. | ||
| Cucurbitaceae (Iuss.) | ||
| Bryonia, Linn. | Brionia Ital. | B. dioica, Iacq. |
| Momordica, Linn. | Momordica Ital. | M. elaterium, Linn. |
| XXXIV. | ||
| Campanulaceae (Iuss.) | ||
| Campanula, Linn. | Campanella Ital. | C. rotundifolia, Linn. |
| Wahlenbercia, Schrad. | W. erinus, Link. | |
| Wahlenbercia, Schrad. | W. hederacea, Reich. | |
| Wahlenbercia, Schrad. | (Campanula hederacea, Linn.) | |
| Iasione, Linn. | I. montana, Linn. | |
| Prismatocarpus, L’Heritier | P. speculum, L’Herit. | |
| [343] | ||
| XXXV. | ||
| Stellatae (Linn.) | ||
| Gallium, Linn. | Gaglio Ital. | G. verum, Linn. |
| Gallium, Linn. | Gaglio Ital. | G. cruciatum, With. |
| Gallium, Linn. | Gaglio Ital. | G. mollugo, Linn. |
| Gallium, Linn. | Gaglio Ital. | G. parisiense, Linn. |
| Gallium, Linn. | Gaglio Ital. | G. anglicum, Linn. |
| Gallium, Linn. | Gaglio Ital. | G. aparine, Linn. |
| Vaillantia, De Cand. | V. muralis, Linn. | |
| Rubia, Linn. | Robbia Ital. | R. tinctorum, Linn. |
| Sherardia, Linn. | S. arvensis, Linn. | |
| Asperula, Linn. | Stellina odorosa | A. odorata, Linn. |
| XXXVI. | ||
| Caprifoliaceae (Iuss.) | ||
| Sambucus, Linn. | Sambuco Ital. | S. Ebulus, Linn. |
| Viburnum, Linn. | Tino | V. tinus, Linn. |
| Lonicera, Linn. | Madreselva Ital. | L. caprifolium, Linn. |
| XXXVII. | ||
| Labiateae (Iuss.) | ||
| Lycopus, Linn. | Licopo Ital. | L. europaeus, Linn. |
| Lycopus, Linn. | Licopo Ital. | L. exaltatus, Linn. |
| Salvia, Linn. | Salvia Ital. | S. verbanica, Linn. |
| Salvia, Linn. | Salvia Ital. | S. clandestina, Linn. |
| Rosmarinus, Linn. | Rosmarino Ital. | R. officinalis, Linn. |
| Calminthia, Moench. | Calaminta Ital. | C. nepeta, Clar |
| Nepeta, Linn. | Ellera terrestre Ital. | N. glechoma, Benth. |
| Mentha, Linn. | Menta Ital. | M. rotundifolia, Linn. |
| Thymus, Linn. | Popolino Ital. | T. serpyllum, Linn. |
| Origanum, Linn. | Maggiorana Ital. | O. vulgare, Linn. |
| Saturneia, Linn. | Santoreggia Ital. | S. graeca, Linn. |
| Sideritis, Linn. | S. romana, Linn. | |
| Teucrium, Linn. | Camedrio Ital. | T. flavum, Linn. |
| Prunella, Linn. | Brunella Ital. | P. vulgaris, Linn. |
| Prunella, Linn. | Brunella Ital. | P. laciniata, Linn. |
| Prasium, Linn. | P. majus, Linn. | |
| Lamium, Linn. | Milzadella Ital. | L. vulgatum, Benth. |
| L. album, Benth. | ||
| L. maculatum, Benth. | ||
| Stachys, Linn. | Stachi Ital. | S. selvatica, Linn. |
| Ballota, Linn. | Marrobia Ital. | B. nigra, Linn. |
| Ballota, Linn. | Marrobia Ital. | B. alba, Linn. |
| XXXVIII. | ||
| Scrophulariaceae (Iuss.) | ||
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. beccabunga, Linn. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. chamadrys, Linn. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. officinalis, Linn. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. arvensis, Linn. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. agrestis, Linn. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. polita, Linn. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. buxabaumii, Ten. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. hederifolia, Linn. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. cymbalaria, Bodard. |
| Veronica, Linn. | Veronica Ital. | V. acinifolia, Linn. |
| Rhinanthus, Linn. | Cresta di gallo Ital. | R. crista galli, Linn. |
| Euphrasia, Linn. | Eufrasia Ital. | E. seroscrotina, Lam. |
| Euphrasia, Linn. | Eufrasia Ital. | E. lutea, Linn. |
| Trixago, Link. | T. latifolia, Reich. | |
| Linaria, Iuss. | Linaiola Ital. | L. cymbalaria, Mill. |
| Linaria, Iuss. | Linaiola Ital. | L. vulgaris, Mill. |
| Antirrhinum, Linn. | Bocca di leone Ital. | A. majus, Linn. |
| Antirrhinum, Linn. | Bocca di leone Ital. | A. orontium, Linn. |
| Scrophularia, Linn. | Scrofolaria Ital. | S. peregrina, Linn. |
| XXXIX. | ||
| Oleaceae (Linn.) | ||
| Olea, Linn. | Olivo Ital. | O. europaea, Linn. |
| Phillyrea, Linn. | Ph. media, Linn. | |
| Ligustrum, Linn. | Ligustro Ital. | L. vulgare, Linn. |
| XL. | ||
| Plantagineae (Iuss.) | ||
| Plantago, Linn. | Petacciuola Ital. | P. major, Linn. |
| Plantago, Linn. | P. lanceolatum, Linn. | |
| Plantago, Linn. | P. psyllium, Linn. | |
| XLI. | ||
| Verbenaceae (Iuss.) | ||
| Verbena, Linn. | Verbena Ital. | V. officinalis, Linn. |
| XLII. | ||
| Orobancheae (Iuss.) | ||
| Orobanche, Linn. | Orobanche Ital. | O. minor, Sutt. |
| Orobanche, Linn. | Orobanche Ital. | O. ramosa, Linn. |
| XLIII. | ||
| Acantaceae (Iuss.) | ||
| Acanthus, Linn. | Acanto Ital. | A. mollis, Linn. |
| [344] | ||
| XLIV. | ||
| Borragineae (Iuss.) | ||
| Echium, Linn. | Echio Ital. | E. vulgare, Linn. |
| Echium, Linn. | Echio Ital. | E. italicum, Linn. |
| Cerinthe, Linn. | Cerinte Ital. | C. aspera, Roth. |
| Heliotropium, Linn. | Eliotropio Ital. | H. europaeum, Linn. |
| Lithospermum, Linn. | L. arvensis, Linn. | |
| Lithospermum, Linn. | L. purpureo-coeruleum, Linn. | |
| Symphytum, Linn. | Consolida Ital. | S. tuberosum, Linn. |
| Borrago | Borragine Ital. | B. officinalis, Linn. |
| Myosotis | Orecchio di topo Ital. | M. arvensis, Hoffm. |
| Cynoglossum | Cinoglossa Ital. | C. pictum, Ail. |
| Anchusa | Ancusa Ital. | A. italica, Retz. |
| XLV. | ||
| Primulaceae (Vent.) | ||
| Anagallis, Linn. | Mordigallina Ital. | A. arvensis, Linn. |
| Anagallis, Linn. | Mordigallina Ital. | A. coerulea, Linn. |
| Cyclamen, Linn. | Pan porcino Ital. | C. hederifolium, Willd. |
| Cyclamen, Linn. | Pan porcino Ital. | C. europaeum, Linn. |
| Cyclamen, Linn. | Pan porcino Ital. | C. neapolitanum, Ten. |
| XLVI. | ||
| Convolvulaceae (Iuss.) | ||
| Convolvulus, Linn. | Il vilucchio Ital. | C. arvensis, Linn. |
| Convolvulus, Linn. | Il vilucchio Ital. | C. sepium, Linn. |
| XLVII. | ||
| Selaneae (Iuss.) | ||
| Hyoscyamus, Linn. | Giusquiamo Ital. | H. albus, Linn. |
| Verbascum, Linn. | Tasso-barbasso Ital. | V. sinuatum, Linn. |
| Verbascum, Linn. | Tasso-barbasso Ital. | V. blattaria, Linn. |
| Solanum, Linn. | Solatro-nero Ital. | S. dulcamara, Linn. |
| Solanum, Linn. | Solatro-nero Ital. | S. nigrum, Linn. |
| Solanum, Linn. | Solatro-nero Ital. | S. villosum, Lam. |
| XLVIII. | ||
| Gentianeae (Iuss.) | ||
| Chilora, Linn. | Ch. perfoliata, Lam. | |
| Erythraea, Ren. | Centaurea Minore | E. centaurium, Pers. |
| Erythraea, Ren. | E. lutea, Bertol. | |
| XLIX. | ||
| Ericaceae (Desv.) | ||
| Arbutus, Linn. | Corbezzolo Ital. | A. unedo, Linn. |
| Erica, Linn. | Scopa Ital. | E. arborea, Linn. |
| L. | ||
| Amaranthaceae (Iuss.) | ||
| Amaranthus, Linn. | Amaranto Ital. | A. clitum, Linn. |
| Amaranthus, Linn. | Amaranto Ital. | A. retroflexum, Linn. |
| LI. | ||
| Santalaceae (Browon) | ||
| Osiris, Linn. | O. alba, Linn. | |
| LII. | ||
| Euphoribiaceae (Iuss.) | ||
| Euphorbia | Euforbia Ital. | E. peplus, Linn. |
| Euphorbia | Euforbia Ital. | E. chamaesyae, Linn. |
| Euphorbia | Euforbia Ital. | E. helioscopia, Linn. |
| Euphorbia | Euforbia Ital. | E. exigua, Linn. |
| Mercurialis | Mercorella Ital. | M. perennis, Linn. |
| Mercurialis | Mercorella Ital. | M. annua, Linn. |
| LIII. | ||
| Poligoneae (Iuss.) | ||
| Rumex, Linn. | Acetosa Ital. | R. pulcher, Linn. |
| Rumex, Linn. | Acetosa Ital. | R. acetosella, Linn. |
| Polygonum, Linn. | Persicaria Ital. | P. Persicaria, Linn. |
| Polygonum, Linn. | Persicaria Ital. | P. mite, Sckrank. |
| Polygonum, Linn. | Persicaria Ital. | P. aviculare, Linn. |
| Polygonum, Linn. | Persicaria Ital. | P. dumetorum, Linn. |
| LIV. | ||
| Urticaceae (Iuss.) | ||
| Parietaria, Linn. | Erba vetriuola Ital. | P. officinalis, Linn. |
| Urtica, Linn. | Ortica Ital. | U. pillulifera, Linn. |
| Urtica, Linn. | Ortica Ital. | U. ureus, Linn. |
| Urtica, Linn. | Ortica Ital. | U. dioica, Linn. |
| Urtica, Linn. | Ortica Ital. | U. membranacea, Wild. |
| Ulmus, Linn. | Olmo Ital. | U. campestris, Linn. |
| Ficus, Linn. | Fico selvatico Ital. | F. carica, Linn. |
| LV. | ||
| Chenopodiaceae (Lind.) | ||
| Chenopodium, Linn. | C. polysmermum, Linn. | |
| Chenopodium, Linn. | C. ambrosioides, Linn. | |
| Chenopodium, Linn. | C. vulvaria, Linn. | |
| Chenopodium, Linn. | C. album, Linn. | |
| Chenopodium, Linn. | C. muralis, Linn. | |
| Chenopodium, Linn. | C. hybridum, Linn. | |
| Atriplex, Linn. | Bietolone Ital. | A. patula, Linn. |
| LVI. | ||
| Ambrosiaceae (Link.) | ||
| Xanthium, Link. | X. spinosum, Linn. | |
| Xanthium, Link. | X. strumarium, Linn. | |
| LVII. | ||
| Phitolaceae (Brown.) | ||
| Phitolacea, Linn. | Pianta lacea Ital. | P. decandra, Linn. |
| [345] | ||
| LVIII. | ||
| Orchideae (Iuss.) | ||
| Orchis, Linn. | O. pyramidalis, Linn. | |
| Orchis, Linn. | O. papilionacea, Linn. | |
| Ophrys, Linn. | O. arinifera, Huds. | |
| LIX. | ||
| Irideae (Iuss.) | ||
| Crocus, Linn. | C. minimus, Red. | |
| Triconema, Ker. | T. columna, R. | |
| LX. | ||
| Amaryllideae (Browin) | ||
| Narcissus, Linn. | Narciso | N. poeticus, Linn. |
| LXI. | ||
| Liliaceae (Linn.) | ||
| Muscaria, Tourn. | Il giacinto Ital. | M. racemosum, Mill. |
| Muscaria, Tourn. | Il giacinto Ital. | M. comosum, Mill. |
| Allium, Linn. | Aglio Ital. | A. ampeloprasum, Linn. |
| Allium, Linn. | Aglio Ital. | A. roseum, Linn. |
| Allium, Linn. | Aglio Ital. | A. vineale, Linn. |
| Allium, Linn. | Aglio Ital. | A. subhirsutum, Linn. |
| Allium, Linn. | Aglio Ital. | A. album |
| Ornithogalum, Linn. | Latte di gallina Ital. | O. umbellatum, Linn. |
| Ornithogalum, Linn. | Latte di gallina Ital. | O. narbonense, Linn. |
| Asphodelus, Linn. | Asfodelo Ital. | A. fistolosus, Linn. |
| Asparagus, Linn. | Sparagio Ital. | A. acutifolia, Linn. |
| Ruscus, Linn. | Pungitopo Ital. | R. aculeatus, Linn. |
| Smilax, Linn. | Smilace Ital. | S. aspera, Linn. |
| LXII. | ||
| Cyperus (Linn.) | ||
| Cyperus, Linn. | C. longus, Linn. | |
| Cyperus, Linn. | C. fuscus, Linn. | |
| Carex, Linn. | C. depauperata, Linn. | |
| LXIII. | ||
| Gramineae (Iuss.) | ||
| 1.º Phalarideae | ||
| Anthroxantum, Linn. | A. odoratum, Linn. | |
| Phalaris, Linn. | Falari Ital. | Ph. aquatica, Linn. |
| Phalaris, Linn. | Falari Ital. | Ph. paradoxa, Linn. |
| 2.º Phleineae | ||
| Alopecurus, Linn. | Alepecuro Ital. | A. agrestis, Linn. |
| Alopecurus, Linn. | Alepecuro Ital. | A. utriculatus, Linn. |
| Phleum, All. | Ph. michelii, All. | |
| 3.º Agrostideae | ||
| Agrostis, With. | A. vulgaris, With. | |
| Piptatherum, Beau | P. multiflorum, Beau | |
| 4.º Avenineae | ||
| Lagurus, Linn. | L. ovatus, Linn. | |
| Koeleria, Pers. | K. pheoides, Pers. | |
| Koeleria, Pers. | K. cristata, Pers. | |
| Avena | Avena Ital. | A. sterilis, Linn. |
| Avena | Avena Ital. | A. fatua, Linn. |
| Avena | Avena Ital. | A. hirsuta, Linn. |
| Avena | Avena Ital. | A. caryophylia, Wigg. |
| Avena | Avena Ital. | (avia caryophylla — Flor. Rom.) |
| 5.º Festucineae | ||
| Briza, Linn. | Briza Ital. | B. maxima, Linn. |
| Briza, Linn. | Briza Ital. | B. media, Linn. |
| Briza, Linn. | Briza Ital. | B. minor, Linn. |
| Melica, Linn. | Meliga Ital. | M. pyramidalis, Roem. |
| Poa, Linn. | Poa Ital. | P. bulbosa, Linn. |
| Poa, Linn. | Poa Ital. | P. trivialis, Linn. |
| Poa, Linn. | Poa Ital. | P. compressa, Linn. |
| Poa, Linn. | Poa Ital. | P. annua, Linn. |
| Eragrostis, Beau | E. pilosa, Beau | |
| (Poa pilosa, Linn.) | ||
| Cynosurus, Linn. | C. cristatus, Linn. | |
| Cynosurus, Linn. | C. echinatus, Linn. | |
| Dactylis | D. glomerata, Linn. | |
| Bromus | B. racemosus, Linn. | |
| Bromus | B. mollis, Linn. | |
| Bromus | B. arvensis, Linn. | |
| Bromus | B. aspera, Murr. | |
| Bromus | B. sterilis, Linn. | |
| Bromus | B. madritensis, Linn. | |
| Bromus | B. maximus, Deff. | |
| Festuca, Linn. | Festuca Ital. | F. rigida, Linn. |
| Festuca, Linn. | Festuca Ital. | F. myurus, Linn. |
| Festuca, Linn. | Festuca Ital. | (F. myurus minor, Flor. rom.) |
| Festuca, Linn. | Festuca Ital. | F. pseudo-myurus, Soyer. |
| [346] | ||
| Festuca, Linn. | Festuca Ital. | F. romana, Deak. |
| Festuca, Linn. | Festuca Ital. | F. ovina, Linn. |
| Festuca, Linn. | Festuca Ital. | F. segetum, Savi. |
| 6.º Hordenieae | ||
| Elymus, Linn. | E. europaeus, Linn. | |
| Hordeum, Linn. | Orzo Ital. | H. murinum, Linn. |
| Hordeum, Linn. | Orzo Ital. | H. pratense, Hudo. |
| Gaudinia, Beau | Gaudinia Ital. | G. frugalis, Beau |
| Triticum, Linn. | Grano Ital. | T. villosum, March. |
| Triticum, Linn. | Grano Ital. | T. repens, Linn. |
| Brachypodium, Beau | B. sylvaticum, Beau | |
| Brachypodium, Beau | B. distachyon, Boem. | |
| Brachypodium, Beau | (Bromus distachyon, Flor. rom.) | |
| Aegilops, Linn. | Egilope Ital. | Ae. ovata, Linn. |
| Lolium, Linn. | Loglierella Ital. | L. perenne, Linn. |
| Lolium, Linn. | Loglierella Ital. | L. multiflora, Linn. |
| 7.º Paniceae | ||
| Tragus, Desfont. | T. racemosus, Desf. | |
| Setaria, Beau | S. vetticellata, Beau | |
| Setaria, Beau | S. viridis, Beau | |
| 8.º Clorideae | ||
| Cynodon, Rich. | C. dactylon, Pers. | |
| LXIV. | ||
| Filices | ||
| Polypodium, Linn. | Polipodio Ital. | P. vulgare, Linn. |
| Adiantum, Linn. | Capelvenere Ital. | A. capillus veneris, Linn. |
| Asplenium, Linn. | Asplenio Ital. | A. trichomanes, Linn. |
| LXV. | ||
| Iuncaceae | ||
| Iuncus, Linn. | Giunco | I. Bufonius, Linn. |
| LXVI. | ||
| Arauceae | ||
| Arum, Linn. | Gigaro Ital. | A. italicum, Mill. |
[347]
Riputiamo far cosa grata ed utile al lettore dedicando quest’appendice alle iscrizioni e frammenti epigrafici rinvenuti nei varî scavi praticati nell’Anfiteatro Flavio; e già pubblicate nel C. I. L. VI, dallo Hübner[1170], dal Lanciani[1171], e più recentemente da Cristiano Huelsen[1172].
Fra i frammenti che siamo per trascrivere ve ne sono parecchi che ricordano personaggi illustri appartenenti all’ordine senatorio, ed il nome di clarissimi viri, i quali, come è noto, avean diritto di sedere in posti determinati.
Ma prima di trascriverli, mi sia lecito fare osservare che queste iscrizioni si dividono in due gruppi cronologici; e che il primo di essi appartiene ad un periodo anteriore alla rovina del vetusto podio, e quindi all’iscrizione che ricorda i restauri di Valentiniano. Ignoriamo il tempo preciso in cui ebbe principio l’uso di graffiare i nomi del titolare di ciascun locus e che costituiscono il secondo gruppo; ma la paleografia delle iscrizioni più antiche, incise sull’orlo dei massi della cornice, al difuori della ringhiera, indica che possan esse appartenere agli inizi del secolo IV.
«Il primo gruppo è inciso su massi, i quali recano dall’altra faccia la nota iscrizione di Valentiano. Dominano in quello le sigle indicanti gruppi di più chiarissimi personaggi, il che indica essersi incominciato a segnare non tanto il posto individuale, quanto quello delle famiglie.
«Tutte le incisioni di questo gruppo sono incise da tre mani: la prima relativamente buona; la seconda mediocre; la terza infelice assai: questa progressione di peggioramento sta in ragione diretta delle distanze delle epigrafi dall’orlo del masso.
[348]
«Le abrasioni, finalmente, e cancellature sono rarissime nelle epigrafi più vicine all’orlo; più frequenti nelle altre. Il marmo tuttavia è stato scalpellato una volta sola, mentre nel gruppo posteriore al terremoto lo scalpello ha lavorato tre o quattro volte»[1173]. Le leggende scalpellate, ma pure riconoscibili sono indicate con un punto (.).
Inscriptiones in Amphitheatro Flavio, repertae — a. 1874-75, a. 1879-80, et a. 1895. (C. I. L. VI, pars 4, pag. 3199 et segg.).[1174]
[349]
[350]
(1) Una buona metà dello spessore del marmo è consunto perchè i nomi incisi sul piano orizzontale della cornice furono poi cancellati. La cornice che in origine presentava questo profilo:
ora è scalpellato in questo modo:
Nel trascrivere a suo luogo le leggende, divideremo per mezzo di due linee orizzontali
quelle che si trovano presso l’orlo a della cornice, da quelle poste dentro la cassa delle cancellature
b, che sono meno antiche. Le leggende cancellate e quindi più antiche e appena
riconoscibili, le contradistingueremo mettendo sotto le lettere stesse un puntino, così per es.:  .
.
[351]
[352]
[353]
[354]
[355]
(1) Cf. p. 350, nota.
[356]
[357]
[358]
[359]
(1) Sotto le lettere IS v’è V, e sotto C O si vede S.
[360]
[361]
[362]
[363]
[364]
[365]
[366]
[367]
(1) Fragmentum f Huelsen non reperiit. Cf. Notizie degli scavi, Gatti, 1895, p. 204.
[368]
(1) Frammenti di base.
[369]
I frammenti che secondo il Lanciani[1175] sarebbero stati pubblicati ed illustrati dal Bruzza, neque publici iuris facta sunt neque extant inter schedas Bruzzae e Dresselis examinatas[1176].
[371]
Abaini 68.
Abdon e Sennen (Ss.) 283.
Abito di etichetta 11.
Accademia Pont. Romana di Archeologia 321.
Acqua, donde si traesse per inondare l’Anfiteatro Flavio 250; in quanto tempo si potesse inondare l’arena per le naumachie 252; che quantità si richiedesse 254.
Adinolfi 146, 157, 167, 172, 191, 193, 204, 206.
Adriano dà gli spettacoli nell’Anfiteatro Flavio 107; castigo che infliggeva ai falliti 107; trasporta il Colosso di Nerone 137; fa edificare il tempio di Venere e Roma 320.
Agostini 325.
Agrippina (morte di) 28.
Alani 115.
Albini Giorgio, notaro, 192.
Alessandro III, 151; parte da Roma 152; scomunica Federico II, (ivi).
Alessandro VI, 204.
Alexandri domus (graffito nell’oratorio di S. Felicita) 195.
Alipio 118.
Allacci Leone 157.
Alonio 335.
Altieri (Card.) 215.
Altieri Iacopo, giostratore 160.
Ambrogio (S.) 67.
Ambulacri dell’Anf. 9, 60; sotterranei 61.
Ammiano ricorda l’A. F. con maraviglia 3, 10, 41, 128.
Anacleto II (antipapa) 150; saccheggia la Basilica Vaticana, il Patriarchio di S. Maria Maggiore ed altre Chiese 151.
Andito oscuro in cui fu tentata la vita di Commodo 62.
Anemoscopio 91.
Anfiteatro 8; chi ne fosse l’inventore 4, 9; progettato d’Augusto 8; incominciato da Caligola ma non terminato 8; di legno edificato da Nerone 8, 281; detto ovum 8.
Anfiteatro d’Arezzo 9.
Anfiteatro Castrense 30, 274, 275, 279.
Anfiteatro FLAVIO 29 e seg.
Anfiteatro Nimes 8.
Anfiteatro di Pozzuoli 55.
Anfiteatro di Statilio Tauro 8, 91, 274, 275, 281.
Anfiteatro di Sutri 9.
Anicio Acilio Glab. Fausto 130.
Anicio Massimo 121.
Annali dell’Istituto 40, 74, 91.
Annibaldi edifica una fortezza presso il Colosseo 152; lotta contro i Frangipani (ivi); in possesso del Colosseo 153; varie vicende degli Annibaldeschi 154; Case degli Annibaldi presso il Colosseo 191.
Anniballi Annibale, giostratore 160.
Anno Santo (1675) 214; (1750) 221.
Anonimo Magliabecchiano 206.
Anonimo di Stuttgart 205.
Antonino Pio dà spettacoli nell’Anf. Flavio 107; lo restaura 125.
Apollinare (S.) vesc. di Ravenna 100, 316.
Apollinare (trageda) 299, 321.
Apuleio 17.
[372]
Arabi 115.
Arcadio e Onorio 119.
Architetto del Colosseo 96, 319 e segg.
Archivio Capitolino 210, 213, 232.
Archivio Lateranense 153.
Archivio di Stato 13, 167, 168, 194.
Archivio Vaticano 193; secreto Vaticano 208.
Arciconfraternita dei Raccomandati del Ss.mo Salvatore ad Sancta Sanctorum 192.
Arco di Costantino 150.
Arco di Tito 150.
Ardea (iscrizione che era sulle pareti del tempio di) 313.
Area lastricata all’Est dell’Anfiteatro Flavio 41.
Arena 9; dell’Anf. Flavio 53; sostruzione dell’arena 55, 235.
Argei (documento degli) 326.
Aringhi 97, 98, 286, 288, 295, 300.
Aristotele 117.
Arnobio 77.
Armellini Mariano 143, 191, 195, 206, 207, 208, 286, 288, 295, 306, 331.
Ascensori romani (antichi) 55.
Asconio 5.
Assomiti 115.
Athletarum certamen 56.
Atti della Pont. Accademia Romana di Archeologia 229.
Augures 70.
Augusto progetta l’edificazione d’un anfiteatro 31.
Aurelia Augurina (iscrizione di) 294, 304.
Aureliano 114.
Averano 317.
Avviso o Editto 14.
Babelon (direttore del museo Numismatico di Parigi) 38, 113.
Babucke Heinrich 130, 138, 171.
Baccelli Prof. Guido 243.
Bacci 294.
Ballhornio 310.
Balteus 69.
Baluzio Stefano 152.
Baronio 27, 114, 121, 149, 299.
Barthelémy 335.
Bartoli Sante 18.
Bartolini 286.
Basilica di S. Michele Arcangelo in septimo 329.
Bassorilievi 16.
Batone, famoso gladiatore 112.
Batraco 320.
Battriani 115.
Baudard Ferdinando 191.
Becker 76.
Bejero 310.
Belleydier (Alfonso) descrive la frenetica adunanza popolare che ebbe luogo nel Colosseo il 23 Marzo 1848, pag. 227.
Bellori 97, 113, 210, 286, 297, 306, 307, 321.
Belve Africane 5; donde si traevano 15.
Bere (vietato di) durante gli spettacoli 11.
Bernini 215.
Bevignani Augusto 225.
Bianchi Pietro 233.
Bianchini (mons.) pratica scavi nell’Anf. Flavio 218, 297.
Biondi Luigi 90; descrive la Via Crucis che facevasi nel Colosseo 226.
Biondo da Forlì 136.
Boezio 67.
Boldetti 297.
Bollandisti 98, 194, 199, 288.
Bonada 287.
Bonet 193.
Bormann 302.
Boshovitz 250.
Bonfort (Francesco) romito nel Colosseo, vittima dei malfattori 219.
Bramante Bassi 213.
Brettoni 24.
Brocchi 325.
Brunemann 317.
Buchi fatti nell’Anfiteatro Flavio 32.
Bullettino dell’Istituto 39, 315.
Bullettino Arch. Comunale di Roma 40, 41, 64, 74, 88, 127, 148, 198, 207.
Bullettino di Arch. sacra 198, 289, 297.
Buonarroti (Il), periodico, 7, 142.
Bustuarî 20.
Cacce degli elefanti 5; d’altre bestie (ivi); di tori (a. 1332) pag. 157 e segg.
Caffarello (giostratore) 159.
Calendario Filocaliano 137.
[373]
Calpurnio 8, 56, 66, 72, 90, 91, 115, 233: descrive i ludi esibiti da Caro, Carino e Numeriano 115.
Camerario Cencio 205, 206, 207.
Campo d’Agrippa (situazione del) 201 e segg.
Cancelleria Apostolica e i travertini del Colosseo 174.
Canina 21, 33, 90, 128, 195, 228, 235, 287, 314.
Capitelli 35; esistenti nell’Anfiteatro 34.
Capitolino 9, 108, 113, 114, 125, 128, 197.
Capitone (Sinnio) 13.
Capoccio Giovanni Iacopo (giostratore) 159.
Capoccio Pietro 160.
Capponi 297.
Caracalla 83; fa celebrare spettacoli nell’Anfiteatro Flavio 112.
Cardella 204.
Cardinali Luigi 74.
Carino e Caro (spettacoli dati da) 115.
Carpegna 297.
Carpoforo (bestiario) 105.
Casa Commodiana 109.
Casa Vectiliana 109.
Cassio 250 e segg.
Cassiodoro 8, 19, 31, 32, 36, 40, 49, 51, 121, 122.
Castel S. Angelo (mausoleo d’Adriano) nelle mani degli Orsini 149.
Castellini (Gualtiero) 140.
Cavalcata solenne nella presa di possesso del Pontificato (i papi passavano innanzi al Colosseo) 208.
Cavalieri (XIV ordine dei) pag. 68, 81, 82.
Cavea media 69.
Cavea summa 69.
Ceccarelli noto falsificatore di documenti 157.
Cecilio Metella 5.
Cecina F. Lampadio restaura l’Anf. Flavio 57.
Cecco della Valle (giostratore) 159.
Cecchini (G. Battista) 209.
Cencio Iacopo (giostratore) 160.
Cencio Camerario 205.
Ceriolense 32.
Cesare 8.
Cessi 63.
Charisius 38.
Chiesa dei Ss. Abdon e Sennen 199, 208.
Chiesa dei Ss. XII Apostoli (lapidi del sotterraneo della) 293.
Chiesa dei Ss. Quadraginta Colisaei 200 e segg.
Chiesa dei Ss. Quadraginta de Calcacario o de Leis 200 e segg.
Chiesa dei Ss. Quadraginta in Trastevere 200 e segg.
Chiesa dei Ss. Quadraginta sull’Esquilino 200 e segg.
Chiesa di S. Giacomo 190.
Chiesa di S. Maria de Ferraris 204.
Chiesa di S. Maria de Metrio 207; detta dal codice di Torino Sellaria de Metrio 208; da una bolla di Urbano V. S. Maria de Metrio 208.
Chiesa di S. Maria degli Angeli 211.
Chiesa di S. Maria Nuova 171.
Chiesa di S. Maria in Torre 152.
Chiesa di S. Martina 98, 287 e segg.
Chiesa di S. Niccolò de Coliseo 207.
Chiesa di S. Pietro (la basilica di) nelle mani di Federico I, 152.
Chiesa di S. Salvatore de Arcu Trasi 206.
Chiesa di S. Salvatore de Insula 205.
Chiesa di S. Salvatore de Rota Colisei 168.
Chiesa di S. Salvatore in Ludo od in Tellure 199.
Chiese che attorniarono l’Anf. Flavio 199.
Chiese più vicine all’Anf. Flavio 199; motivo della loro erezione 200.
Chimentelli 302.
Christianos ad leones! grido della plebe 196.
Cicerone 11, 14, 21, 22, 23, 50, 65, 79, 271.
Cimiere 24.
Cimitero di S. Agnese 98, 286, 290.
Cimitero di Domitilla 297.
Cimitero cristiano degli inizi del secolo VI presso il Colosseo 148, 205.
Cimitero Ostriano 309.
Cimiteri cristiani in Roma 272.
Cinti 288.
Ciofi L. 104.
Cippi di travertino 41.
Cippi del campo di Agrippa 201.
Circo 6.
Cittadinanza (classe meschina della) ove sedesse negli spettacoli 71.
Civiltà Cattolica (periodico) 313.
Claudiano 16.
Clemente V 154; invia da Avignone tre Cardinali 157.
Clemente XIII 222.
Clipei 45; ove fossero collocati 46; chi vi fosse rappresentato 257; come fossero disposti 259 e segg.
Clypeus (scudo dei glad.) 22.
Codice Barberiniano 300.
Codice di Brussels 324.
[374]
Codice di Einsiedeln 304.
Codice Marciano, latino, 321.
Codice Teodosiano 26, 50, 118, 119, 128.
Codice Torinese 205, 206, 207, 208.
Colonne (pezzi di marmo frigio) 44.
Collegi ufficiali 70.
Collegi semi ufficiali 70.
Collegi sacerdotali 82.
Collegi dei Sodali Fluviali 83.
Collegio Silvano Aureliano formato da Commodo 111.
Collegio degli arenarî, (ivi).
Collettori (gara dei) delle lapidi cristiane 297.
Colonnesi (donne) assistono alla giostra dei tori (nel 1332) 157.
Colonnesi presero possesso del mausoleo d’Augusto e delle terme di Costantino 149.
Colonna (Della) Agapito (giostratore) 160.
Colonna (Della) Aldeiano 160.
Colonna (Della) Cola 160.
Colosseo restituito alla S. Sede 154.
Colosseo posto sotto la giurisdizione del Senato e del Popolo Romano 155.
Colosseo (cade una parte del) 164.
Colosseo nido di ladri 166, 217, 218.
Colosseo in rovina 171.
Colosseo (origine di questa voce) 135 e segg.
Colosseo abbandonato (ivi) 146.
Colosseo fortezza feudale 146.
Colosseo nelle mani dei Frangipani 149.
Colosseo (progetto di adibire il) a cimitero provvisorio 225.
Colosseo illuminato a fuoco di bengala 228.
Colosso di Nerone 136, 137, 138.
Comitato romano contro il vandalismo 51.
Commodiana (casa) 109.
Commodo 22; gladiatore 108; sue stranezze 108, 111; capo dei secutores 110.
Compilatori del Corpus Inscript. 201.
Composito (ordine archit. inv. dai romani) 33.
Contelori 318.
Conti Cecco (giostratore) 159.
Controversie sull’Anf. Flavio 245.
Cornelio Nipote 320.
Corpus inscript. lat. 12, 33, 35, 40, 43, 45, 57, 73, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 129, 130, 131, 132, 312, 323.
Correra 243.
Corsetti (prof. P. Raffaele) 209.
Corsi (De’) Evangelista (giostratore) 160.
Corsini 318.
Corvisieri, sua strana opinione circa la voce Colosseo, 141, 331.
Cosa o coscia Colisaei, che cosa fosse 165, 175.
Costantino I vieta i ludi 26, 118; proibisce l’uso di marcare in fronte (ivi); sua lettera intorno alla consulta degli aruspici 128.
Costantino III depreda i bronzi 51, 135.
Costanzo ordina di non adescare i soldati col denaro 119; proibisce di ascriversi ai collegi glad. (ivi).
Costruzione degli Ipogei (a qual epoca rimonti) 233.
Costumi romani 3.
Crescimbene 288.
Crisocolla 54.
Crisso 21.
Cristiani calunniati dai giudei 267; damnati ad bestias 269.
Criterî per distinguere le lapidi vere dalle false 293.
Croce eretta sull’Anfiteatro 216.
Crocuta, che bestia sia, 107.
Cronologi 32.
Cuiacio 317.
Ctesifonte 220.
Cuneus 11.
Daru (Barone) 231.
Dazio 16.
Deakin (Richard) 336.
Decio restaura l’Anf. Flavio 128.
Decio Mario Venanzio Basilio restaura l’Anfiteatro 131; epigrafi che ricordano il restauro 131, 132.
Decreti (libro dei) 209.
De-Crosat 44.
Dedicaz. dell’Anf. Flavio 32.
Degli Abati (Ing. Francesco) e la sua pianta altimetrica 326, 327.
Deletum (ad calcem), qual sia il vero significato di questa frase 171.
Delinquenti puniti col farli discendere nell’arena 19.
Demagoghi della Rivoluzione Romana (1848) nel Colosseo 226.
Demetriano 320.
Demetrio 320.
Demstero 3.
Dennis 9.
De Petri 312.
De Rossi 83, 118, 120, 129, 132, 195, 196, 197, 198, 279, 287, 288, 290, 293, 295, 296, 300, 306, 309, 311, 314, 324.
[375]
De Rossi (mons. Ferdinando M. Vicegerente) benedice i quadri della V. Crucis 222.
De Ruggeri, Diz. Epig., 9.
De Sade 163.
Desgodetz 62.
Designatores 11.
Desinenza (la) in entius non fa ostacolo all’antichità del nome Gaudentius 314.
Detriano 320.
Dimensione dell’Anf. Fl. 41.
Diocleziano 117.
Dione 4, 7, 8, 12, 14, 18, 25, 31, 36, 61, 62, 69, 70, 76, 77.
Dione descrive le feste inaugurali 36.
Dione descrive gli spettacoli dati da Commodo 110 e segg.; 84, 105, 106, 109, 111, 112, 113, 126, 127, 197, 201, 245, 266, 281, 316.
Di Prospero 32.
Diribitorio 201.
Disertori esposti alle belve 6.
Divisione dei posti (discrimina ordinum) 73.
Domiziano termina l’Anf. Fl. 33; editto di Domiziano 80; dà giuochi sontuosi 103; assiste agli spettacoli di notte (ivi); conversa seriamente con un fanciullo (ivi); forse con Q. Sulpicio Massimo 104; fa uccidere un fautore dei Traci 104; uomo malvagio (ivi); bravo arciere (ivi); in Albano (ivi); 272.
Domus Aurea 143.
Donato Grammatico 3.
Donne ove sedessero negli spettacoli 71.
Donnello 317.
Druso (pretura di) 281.
Duchesne (mons. Luigi) 136, 163, 329.
Dumaine (P. Stefano) 227.
Durand 274.
Durando (General) nel Colosseo 227.
Ebrei condotti a Roma da Tito 32.
Eccardo 52.
Eckel 39.
Edifici antichi trascurati 147.
Edmodono 320.
Egloca di Calpurnio 116.
Egiziani 115.
Elefanti 5; nel circo 6; come si spaventassero 17; funamboli 18; s’inginocchiano davanti a Domiziano 106.
Elettro 54.
Elevatori meccanici 55.
Eliogabalo restaura l’Anf. Fl. 113, 127.
Emilio Paolo 6.
Encicl. Pascendi, Pref.
Enomao 21.
Enrico VII 154.
Epitteto 271.
Epitome libri de locis 329.
Epulones (VII viri) ove sedessero nell’Anfiteatro 70.
Erchemperto, monaco, 140.
Equites 79.
Erasmo 58.
Erma 272.
Ermete, terribile gladiatore 23.
Ermine 272.
Erodione 272.
Errori ortografici nella lapide di Gaudenzio 310.
Esame delle armi 55.
Esquilino (varie località dell’) 327.
Eugenio IV (Bulla Unionis Ecclesiarum Ss. Quadraginta etc.) 193.
Eschinardi 48.
Esposizione delle fiere 17.
Etruschi 19.
Entarico Cillica 121.
Essedarî 24.
Eudemoni 115.
Eugenio IV vieta con un breve l’asportazione dei trav. dal Colos, ecc. 171: testo della bolla 174, 175, 203.
Eumelio 118.
Eusebio 32.
Eustachio (S. e famiglia) 283.
Eutropio 32.
Falliti (ove sedessero) 11.
Falsarî di Lapidi 298.
Fanciulli incaricati di remuovere l’arena 19.
Faustina madre di Commodo 108; moglie di Ant. Pio 125.
Fea (C) 49, 75, 129, 131, 132, 233, oppugna il progetto della ricerca dell’antica cloaca 240, 286, 287.
Federico II. perseguita la Chiesa 153.
Felicita (S.) e figli (oratorio di) 195 e segg.; loro sepolcri (ivi).
Felicitas Cultrix Romanarum (matronarum) 197.
Feminae clarissimae 73.
[376]
Ferrari (General) nel Colosseo 227.
Festo 77.
Fetiales 70.
Fiere (trasporto di) 16: difficoltà d’imbarcarle 16; trasportate in carri pubblici e privati 18.
Figlio dell’Etna — ladro ecc. 17.
Filippo (spettacoli dati da) 114.
Filologo 272.
Filone 320.
Flavio M. Teod. (nel consolato di) si celeb. le venationes 121.
Flavio Biondo 49.
Flegonte 272.
Fletwood 287.
Flora dell’Anf. Fl. 335.
Fon 310.
Fontana (Domenico) riceve l’incarico di ridurre l’A. Fl. ad abitazione e lanificio 209; descrive i lavori iniziati 210.
Fontana (Carlo) progetta l’erezione di un tempietto nel Col. 216, 218, 335.
Forcellini 322.
Forma dell’Anf. Flavio. 41.
Forma Urbis 278.
Foro 7.
Foro d’Alessandria 320.
Foro di Marte 196.
Foro Traiano 320.
Fortezza feudale (il Colosseo convertito in) 147.
Foscari (Card. Pietro) 204.
Franchi 115.
Franchi dei Cavalieri e il testamento di Melazio 204.
Frangipane 49; prende possesso del Colosseo e del Settizonio di Severo 149; (case dei) presso il Colosseo 150, 155; capitani 152; in lotta cogli Annibaldi 152; fanno delle costruzioni nei portici dell’Anf. Fl. 154; in contesa cogli Annibaldi 164; non fecero lavori nell’ipogeo dell’Anf. 240.
Fratricidî (condannati ad bestias) 271.
Frisigense (Ott.) 152.
Fulmine (un) incendia l’Anf. Fl. 113, 126.
Fumi 157.
Fuscina 23.
Fusco (giostratore) 161.
Gabbie delle belve 56.
Gaetani 150.
Gara di riunire memorie sacre 289.
Garucci 195, 197, 302, 305, 308, 314.
Gatti (Giuseppe) 144, 190, 198, 207, 244.
Gaudenzio (lapide di Gaudenzio) 98; studio critico 285 e segg.
Gaudenzio (S.) martire in Africa 323.
Gaudenzio (S.) di Novara 323.
Gaudenzio (S.) di Rimini 323.
Gaudenzio (S.) di Arezzo 323.
Gavazzi (P.) nel Colosseo 227.
Gellio 17.
Germani 115.
Gerusalemme (dipinto che rappresenta) nel Colosseo 218.
Giampaoli 287.
Giostra di tori nell’Anf. Fl. (anno 1332) pag. 157 e segg.
Giovanni Crisostomo (S.) 270.
Giovanna (favolosa Papessa) 205.
Giovanni VII (casa di) 194.
Giovanni VIII (episcopio di) 150.
Giovanni Saresberiense 3.
Giovanni da Udine 44.
Giulia 272.
Giunia 271.
Giuochi Anf. 15; gladiatorî e venatorî 5.
Giuochi dati dagli Imp. 13; cessano del tutto 122.
Giuseppe Flavio 25, 32, 74, 78.
Gladiatori emeriti 15.
Gladiatori volontarî 20.
Gladiatori (salario dei) 21.
Gladiatori (nome dei) scritti su tavolette 21.
Gladiat. vinti deponevano le armi 22; (premî dei) vincitori 22; damnati ad gladium 22: ad ludum; ib.; consacravano le loro armi a Ercole 22.
Gladiat. Andabatae 25.
Gladiat. catervarii ib. (nota).
Gladiat. caesariani, ib.
Gladiat. cubicularii, ib.
Gladiat. dimachaeri, ib.
Gladiat. fiscales, ib.
Gladiat. laquearii, ib.
Gladiat. meridiani, ib.
Gladiat. pegmares, ib.
Gladiat. Postulaticii, ib.
Gladiat. supposititii, ib.
Gladiat. (Monumenti dei) 26.
Gnoli 279.
Gordiano III (spett. dati da) 113.
Gori Fabio 36, 39, 48, 52, 83, 101, 106, 110, 118, 120, 123, 152, 154, 163, 171, 190, 287, 306.
Gradatio 10.
Gradini esterni dell’Anf. 41.
[377]
Graffiti 16.
Graffiti sui gradini 75; nell’oratorio di S. Felicita 197; in un altro Oratorio 199.
Graffito rinvenuto nel Colosseo negli scavi del 1874, pag. 239; altri graffiti 242.
Gregorio IX 133.
Gregorio XIII condanna a morte Ceccarelli falsificatore di documenti 157.
Gregorio XVI 165; fa costruire sette arcate e restaura il terzo portico 224.
Gregorovius 157.
Grimano (card. Domenico) 204.
Grisar (P.) 45, 46, 120, 121, 133, 148, 190, 273, 282, 283, 288, 299.
Gronow 288.
Gruter 311.
Guarini 8.
Guattani 9, 13, 32, 37, 41, 44, 96, 191, 222.
Guerre Puniche 3.
Guerre Macedoniche 3.
Guiscardo (Roberto) 163.
Heinrichio 310.
Henzen 21, 23, 24, 25, 33, 74, 104, 106.
Hochart (P.) 272.
Home (Leon) 88.
Hoplomachi 23.
Huelsen 60, 88, 130, 131, 201, 279, 330.
Hübner 33, 40, 65, 75, 78, 81, 82, 85.
Iansoni 318.
Iberi 115.
Ignazio (S.) martire 271, 283.
Incavature nella fronte dei piloni fra le mensole dell’arena 239.
Incendio nell’Anf. Fl. 126, 128.
Innocenzo III 152.
Innocenzo IV 153.
Intagli (l’Anf. è privo d’) 43.
Ipogei dell’arena 55, 231; costruzione 233 (varie opinioni sull’epoca della), (ivi).
Iscrizioni messe nell’esterno dell’Anf. (a. 1675) 221.
Iscrizioni a musaico nella Confessione Vaticana 300, 304.
Itinerario d’Einsiedeln 136.
Jacquier (P.) 40.
Kaibel 144.
Kirchmann 50.
Kraus 283.
Kaufmann 294.
Labanio Antiocheno 119.
Laberinto di Lesurnio 320.
Laerzio 23.
Lam 287.
Lampadio (restauri di) 121.
Lampridio 24, 54, 91, 109, 127, 282.
Lanciani R. 35, 40, 60, 64, 67, 82, 101, 107, 113, 118, 119, 125, 126, 128, 131, 144, 145, 157, 164, 165, 173, 175, 194, 199, 201, 205, 232, 235, 248, 251, 274, 276, 278.
Lanistae 21.
Laocoonte 143.
Lapidi pompeiane 14; con apici 301.
Lapide modenese 111.
Lapide dedicatoria 280.
Lapide di Furfone 302; con apici sugli I come quella di Gaudenzio 303.
Lapide veliterna 57.
Laureolo 19.
Legati 14.
Legato Pont. (vescovo d’Orvieto) scrive a Urbano V 164.
Leggi riguardanti i delitti e la pena di pugnare colle fiere 265.
Legione partica ad Albano 228.
Leonardo (S.) da Porto Maurizio 222.
Leone XII p. 176; fa edificare un contrafforte nel Colos. 224.
Leoni 18.
Libro Pont. (Ed. Duchesne) 135, 136, 329, 230.
Ligorio (Pirro) 100, 131, 288; criticato dal Marini 292.
Lipsio 10, 13, 25, 31, 32, 53.
Locus 11.
Lodovico della Polenta di Ravenna (giostratore) 159.
Lonigo 205.
Lübker 320.
Lucilla sorella di Commodo trama la congiura contro il fratello 109.
[378]
Lucillo 59.
Lucrezio 89.
Ludi (collegi) loro vastità 21; principali di Roma 21.
Ludi Castrensi 279.
Lugari (G. B. Card.) 143, 274, 275, 305, 321.
Lugari (Cav. Bernardo) 321.
Lupi, suo giudizio intorno alle lapidi 294, 293, 310.
Lupi al campo Teutonico 149.
Macrino 126.
Maestri di glad. 20.
Maffei 10, 31, 37, 38, 39, 43, 46, 51, 68, 112, 113, 132; sua opinione circa la voce «Colosseo» 138; 281, 282, 292, 307, 312.
Magnan 287.
Magnificenza degli spett. 6.
Mamachi 287.
Manica (bracciale) 24.
Manzi 157.
Marangoni 36, 97, 98, 99, 126, 132, 154, 167, 168, 191, 287, 289, 311.
Marco Aurelio dà spettacoli 108, 197.
Marco F. Nobiliore 5.
Marchi (P. G.) 311.
Mareri (De) Franciotto (giostratore) 161.
Maria 271.
Marini 24, 33, 82, 100, 132, 287, 289; sue schede 292, 312.
Marliani 277.
Marmorata (marmi grezzi di) 309.
Marquardt 78.
Marsilio Onorato 99.
Martignoni 276.
Martino (S.) 283.
Martiri (l’Anf. Fl. e i) 265 e segg.
Martirologio d’Usuardo 324.
Martirologio Geronimiano 329.
Marucchi (O.) 98, 101, 195, 288, 293, 329.
Marziale descrive gli spettacoli dati sotto Domiziano nell’Anf. Flavio 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 32, 35, 36, 54, 60, 70, 80, 81, 86, 97, 103, 104, 105, 106, 138, 143, 245, 315, 320.
Masciano 50.
Masdeu 234.
Massimo 156.
Mazzolari 287.
Mazzucchelli 286.
Medaglie 37 e segg.; di Sev. Alessandro 113, 127; di Faustina 125; di Gord. Pio 128, 262.
Medicus 21.
Meeting, nel Colosseo (1870) 229.
Meier 242.
Mellini (Benedetto) 190, 192, 194.
Memorie enciclopediche romane 69.
Meniani dell’Anf. Fl. 33.
Mercurio (testa di) nel museo Chiaramonti (Vaticano) 258.
Messius 130.
Migne 324.
Milizia 71.
Mimo 54.
Mirabilia (libro delle) 145.
Myrmillones 23.
Minuzio 13.
Miseria del popolo romano 3.
Missio 22.
Mnesicle 320.
Modena 21.
Modesto e Vito (Ss.) 283.
Modiglioni 47.
Mommsen 33, 79, 301, 302, 304.
Monache (monastero di) nel Colosseo, parere degli scrittori 193.
Monaldeschi (giudizio sulla sua Historia) 157.
Monte Settimio 324; era sull’Oppio e non nel Cispio 326.
Monumenti deturpati 49, 50 (noncuranza dei) 51.
Monumenti dell’Ist. di Corrisp. Archeol. 16.
Mora (giuoco della) 3.
Morti nelle giostre dei tori (a. 1332) pag. 161.
Motivi per cui si falsificavano le lapidi 291.
Müntz 279.
Munus 20.
Muratori 17, 24, 25, 52, 97, 114, 117, 129, 152, 157, 206, 312.
Musaici del Museo Gregoriano 16; della Villa Borg. (Umberto I) 26; Albani, ib., Pamphili, ib.
Museo epigrafico Pio Lateranense 297.
Museo di Catania 297.
Museo di Ravenna (arcivescovile) 297.
[379]
Museo di Verona 302.
Muzio 320.
Nardini 277, 278, 280, 325, 331.
Narcisso 272.
Nasica 5.
Naumachia 9, 36; nell’Anf. Fl. si celebrarono 245; gli scavi l’han confermato 248.
Nereo 272.
Nerone proscrive il cristianesimo 266, 272; fa incendiare Roma (ivi), 268.
Nibby 19, 31, 37, 38, 39, 44, 45, 47; sua opinione circa la voce Colosseo 140; 49, 63, 97, 98, 120, 128, 157, 164, 173, 195, 234, 278, 280, 287, 306, 307, 314, 325, 328.
Niccolò V trasporta i travertini 173.
Nicchie arcuate nel perimetro dell’Ipogeo 236.
Nimes 8.
Nispi-Landi 9.
Noris 310.
Numeriano 115.
Ocrea 24.
Oderici 309.
Olivetani (monaci) 172.
Olimpiade ricordata da S. Paolo 272.
Olivieri 152.
Omero 19.
Onorio e Arcadio 119.
Opus spicatum 61.
Oratorio di S. Felicita 195, motivo dell’erezione 195.
Oratorî (altri) vicini all’Anf. Fl. 198.
Orazio 79.
Orelli 24.
Orfeo 106.
Origene 270.
Orsi 287.
Orsi della Dalmazia 16; della Libia 18.
Orsini (gli) nel mausoleo di Adriano e nel teatro di Marcello 149.
Orosio 269.
Orti Largiani 202.
Ospedale di S. Giacomo ad Colossaeum 167.
Ospedale Ss. Quad. 204.
Ovum (l’Anf. detto) 8.
Padri di Cappadocia (testimonianza dei) intorno ai Ss. Quaranta Martiri di Sebaste 204.
Palazzo Barberini e i trav. del Colosseo 174.
Palermo 5.
Palladio 274.
Palmireni 115.
Pandette e codice di Giustiniano 317.
Panvinio 150, 152, 153, 277, 318.
Paoli (P. Angelo) 218.
Paolo (S.) 271.
Paolo Diacono 129.
Paolo II e i trav. del Colosseo 173, 174.
Paparese, giostratore, 160.
Papi in Avignone 249.
Parisotti 136.
Parma 23, Fig. illustrata dal Rich. 3.
Parricidî (condannati ad bestias) 271.
Pasquali (P.) 149.
Passio S. Perpetuae 271.
Passio S. Pionii (ivi).
Patroba 272.
Patroclo 19.
Perezio 317.
Peridromo, cosa fosse 108.
Perni metallici 48.
Perni di legno, ib.
Perni derubati 49.
Perni (proibizione di togliere i) 50.
Persiani 115.
Perside 272.
Petnene (Paolo Liello) 206.
Petrarca 163.
Piani dell’Anf. Fl. 42.
Pietra specolare 58.
Pietre tolte dagli edifici esistenti ed usate nelle nuove fabbriche 35.
Pietre (cadute) del Colosseo messe in vendita 164.
Pietro (S.) esorta i nuovi cristiani alla costanza della fede nella persecuzione neroniana 268.
Pietro Berrettini da Cortona 287.
Pighio 131.
Pinelli (card.) 273.
Pinnirapus 24.
Pio II, 168.
[380]
Pio V (S.) 208.
Pio VII 165, 176; ordina l’edificazione del contrafforte 223; restaura l’interno 224.
Pio IX, 165, 176; restaura l’ingresso imperatorio 228.
Pizzamiglio 308.
Planesium 93.
Placido e Valentiniano 121, 129.
Plebs, ove sedesse nell’Anf. 69.
Plinio 5, 6, 7, 14, 53, 67, 79, 89, 106, 117, 138, 139, 143, 266.
Plinio giun. interroga Traiano 268.
Podio 63 (parapetto del) (ivi); forma 64.
Poggio Fiorentino 171.
Poggio Braccioli 206.
Policarpo (S.) 271.
Pollici alzati e abbassati dal popolo 22.
Pollione 6.
Pompeo 6.
Pompili Olivieri 228.
Pomponio Leto 277.
Ponte di S. Maria restaurato coi materiali, caduti, dell’Anf. Fl. 209.
Pontifices ove sedessero nell’Anf. Fl. 70.
Portico dell’Anf. convertito in deposito di letame per trarne salnitro 217.
Portico d’Ottavia 320.
Porte Anfiteatrali 9.
Porte posticiae e non posticae 56.
Posi (Paolo) rinnova le edicole della V. Crucis 221.
Posti (distribuzione dei) 74.
Posti personali 77.
Pothier 269.
Praelusio 22.
Pozzuoli (anfit. di) 55.
Pretestati 70.
Pretori 13.
Prigionieri venduti a maestri di scherma 21.
Primitivo (iscrizione del martire) 300.
Prisca ed Aquila 271.
Prisciano 320.
Prisco 22.
Probo (spett. dati da) 114.
Procurator 21.
Profumo Prof. Attilio 266.
Promoteo 19.
Promis 288.
Properzio 8.
Propilei di Atene 220.
Provocatores 28.
Prudenzio 13, 65, 107; parla delle venationes 26; descrive gli spett. 119, 269.
Quattro Santi Coronati 315.
Quintilio Sulpicio Massimo 104.
Quinziano tenta la vita a Commodo 109.
Rabirio non fu l’architetto del Colosseo 97; lodato da Marziale 320.
Randanini (marchesa Felice) 286, 300.
Reggio 21.
Reimaro 255.
Rei di lesa maestà (condannati ad bestias) 271.
Reinesio 287.
Rete 23 (di fili d’oro) 67; come difendesse gli spettatori dagli assalti delle fiere 68.
Reziario 22.
Riario (card.) e i trav. del Colosseo 174.
Ricchezze dei nobili 3.
Rich 23.
Ridolfi ab. Gaetano 253.
Rigaltius 24.
Ringhiera di bronzo 78.
Ripetta (ponte di) restaurato coi materiali, caduti, dell’Anf. Fl. 217.
Robinson (Arm.) 271.
Rodope 106.
Roet 317.
Rohrbacher 288.
Roma, sue conquiste 3; disfatta subita dai suoi eserciti pretorî e consolari 21.
Roma e l’Italia travagliate da dissensioni 157.
Romanelli 89.
Romani (cittadini) prima esenti per legge dalla pena della damnatio ad bestias 270. Più tardi anche essi condannati a quella pena 270.
Rosa (Comm. Pietro) fa togliere le piante che ricoprivano il Colosseo 229.
Rosini 3.
Rossino (Pietro) 32.
Rovere (matrona) 157.
Rudiarii 22.
Rufo Cecina Felice Lampadio restaura l’Anf. Fl. 129, epigrafe (ivi).
[381]
Rufo ricordato da S. Paolo 272.
Ruinart 271.
Rulli d’avorio 67.
Sabatici 242.
Sabatini (F.) 151.
Sacerdotali (dignità) ove sedessero nell’Anf. 65, 70.
Sadeler (Marco) 150.
Sancta Sanctorum (compagnia di) al Colosseo 166; dona al Pop. Romano il prezzo di certe pietre ecc. 169.
Sarmati 115.
Savella Orsina assiste alla giostra di tori (a. 1332) 168.
Savello (d’Anagni) giostratore 159.
Scacchi 3.
Scaglia (P. Sisto) 98, 100, 273, 288, 295, 307, 313.
Scalaria 11.
Scale 9.
Scavi (gli) eseguiti nell’Anf. Fl. 231; hanno rivelato essere l’arena sostrutta e l’antico livello 236; oggetti rinvenuti nel 1874, pag. 241.
Scevola 50.
Scialoja (Senatore) 229.
Scipione Africano 6.
Schola dei venatores 281.
Scoperta importante a Nord dell’Anfiteatro Flavio sul declivio dell’Oppio 244.
Scudo d’argento 24.
Scutillo (Gius.) 111.
Sebastiani (Antonio) 336.
Secutores 22.
Sedili 11, 76; a chi spettassero (ivi); come si perdesse il diritto di occuparli (ivi).
Segno d’abbrevazione sulle lettere 312.
Sempronio e compagni (Ss.) 283.
Senatori, ove sedessero 65, 76.
Seneca 3, 5, 6, 12, 19, 23, 25, 37, 60.
Sepolcro Apostolico dell’Appia (iscrizione damasiana) 304.
Septi 281.
Serlio 96.
Settimio (monte) 324.
Settimio Severo fa celebrare spettacoli 111.
Settizonio di Severo nelle mani dei Frangipani 149.
Severano 288.
Severo Ales. restaura l’Anf. 113.
Sezione dell’Anf. Fl. 52.
Sica 23.
Sifilino 255.
Signore (nomi delle) che visitarono gli scavi del cim. di S. Agnese 290.
Signorili Niccolò 194, 205, 207, 208.
Silla 6.
Silloge di Closterneubourg 272.
Silloge di Göttwel 272.
Silloge (mariniana) 133.
Silloge di Tours 272.
Silverio (S.) 121.
Simmaco 16.
Simonetti Mons. Raniero pubblica un editto per ordine di Benedetto XIV. 219.
Sisto III 272.
Sisto IV 204.
Sisto V 175; progetta grandiosi lavori nell’Anf. Fl. 209.
Sodalizio degli Amanti di Gesù e Maria nel Colosseo 222.
Soldati (Ss.) CCLXII 283.
Sollier 324.
Sotterranei dell’Anf. Fl. 55, 231.
Spagna e Portogallo (iscrizioni della) hanno i punti sugli I. 300.
Sphaeromachia 3.
Sparsiones 12.
Spartaco 21.
Spese (somme) nell’edificazione dell’A. F. 40.
Spettacoli bramati dal popolo 34; dati nell’Anf. Flav. dall’inaugurazione al secolo VI 103.
Spettacoli circensi 4.
Spettacoli gladiat. 4, 5, 19, 20.
Spettacoli sacri agli dei 12; occasione in cui si celebravano 14; proibiti da Costantino 26; da Arcadio 26; cessazione (ivi).
Spettacoli (ultimi) dati nell’Anf. 147.
Sprengel 325.
Spugna 23.
Stachyn 271.
Stalli (giostratore) 160.
Statue 44; di bronzo raffigurate sulle medaglie di Gordiano 135; nella cavea 68.
Stazio 266.
Stemma del Senato e della Confr. di Sancta Sanctorum 168.
Sterbini nel Colosseo 227.
[382]
Stevenson 279.
Strabone 23.
Strepsicerota, che bestia sia 107.
Stucchi del sepolcro pomp. di Scauro 16.
Stucchi disegnati da Giovanni da Udine 44.
Suarez 154.
Subsellia 63.
Suggesti 64; divisi per cunei 77; separati dalla cavea 76.
Summa cavea 69.
Suetonio 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 25, 31, 32, 36, 45, 54, 63, 64, 65, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 103, 104, 138, 140, 143, 266, 279, 280, 299, 320.
Sulpizio Severo 269.
Suppositizî (gladiatori) 23.
Svevi 115.
Tabernacolo (di bronzo sulla confessione di S. Pietro) 300.
Tabulationes 69.
Tacito 8, 12, 45, 66, 70, 73, 81, 83, 84, 85, 266, 272.
Tarquinia (soldati di) 19.
Taziana (S.) 283.
Teatro ligneo 7.
Teatro circolare 7.
Teatro di Scauro 7.
Teatro di Marcello nelle mani degli Orsini 149.
Telemaco (monaco) ucciso in Roma nell’Anf. Fl. 27, 120.
Temistocle 48.
Tempio di Cerere 320.
Tempio di Diana in Efeso 320.
Tempio di Giove Olimpico 320.
Tempio di Marte al Circo Flaminio 320.
Tempio dell’Onore e della Virtù 320.
Tempio di Piazza di Pietra, se fosse dedicato a Nettuno 302.
Tempio di Venere e Roma 60, 320.
Teodorico 122, sua lettera diretta al console Massimo (ivi).
Teodoro (architetto) 320.
Teonio 220.
Terme di Tito e di Traiano 175.
Terme di Tito 143; differenza fra le Terme di Tito (private) e le velocia munera di cui parla Suetonio 143.
Terremoto 57, 129, 148, 163, 165, 217.
Terribilini 287.
Tertulliano 10, 12, 13, 20, 23, 25, 196, 270, 271, 272.
Teti e Galatea (dee marine) 246, 254, 255.
Thermae Titianae 38.
Tigri 18.
Tito inaugura l’Anf. Fl. 32.
Tito Livio 5, 6, 19, 24, 45, 77, 79.
Tivoli 151.
Tocco 335.
Toga 11.
Tolomeo 287.
Tolomeo (F.) vescovo di Torcello 150.
Tomassi (P. Carlo) 214.
Traci 23.
Traiano dà spettacoli grandiosi nell’Anf. Fl. 106.
Traiano edifica un teatro non un anfiteatro 107; sue parole al Prefetto del Preterio 318.
Travi della rete di bronzo 53.
Trebell. 45.
Triboniano 15.
Tribuni, ove sedessero 69.
Tripodi per bruciare essenze odorose 68.
Tridente 23.
Trifena 272.
Trifosa (ivi).
Trionfo di C. Metello su Cartagine 5.
Trochus 4.
Tucidide 48.
Turba pulla (ove sedesse) 72.
Turbo (trottola) 4.
Turnebo 325.
Uggeri 335.
Ulderico Card. Carpegna 214.
Unni 129.
Uomini immolati ai defunti 20.
Urbano ricordato da S. Paolo 271.
Usuardo (martirologio di) 324.
Vaglieri 88.
[383]
Valadier 231.
Valentiniano e Valente, vietano che si condannino i cristiani ai ludi glad. 119.
Valentiniano III, 129; restauri avvenuti sotto il suo impero (ivi).
Valerio Massimo 6, 11, 20, 76.
Valerio Ostiense 320.
Valesio Francesco 193.
Vandali 115.
Vasari 44.
Velario 12, 47, 89 (antenne del) 47.
Velletri (lapide di) 57.
Velocia munera 138.
Venationes 4, 15; varietà degli spettacoli venatorî 17.
Venatio, intrapresa ordinariamente libera 19, 265.
Venatores 18; loro coraggio (ivi).
Venatores (magistri dei) 18.
Venationes (cessazione delle) 127.
Vendettini 151.
Venuleio 50.
Venuti 13, 97, 98, 136, 287; Venuti-Piale 316.
Vero (L.) 22.
Verona (Anf. di) 8.
Versione letterale dell’iscrizione di Gaudenzio 317; libera (ivi).
Vespasiano attua il progetto d’Augusto 8, 32, 299.
Vestali (ove sedessero) 65.
Vettori 297.
Via Sacra 61.
Via Lata 202.
Via crucis nel Colosseo 176; edicole della via crucis 218, 221; quando furono abbattute 243.
Vico (Iacopa di) assiste alla giostra di tori nel 1332 158.
Vipsania Pola (portico di) 201.
Viri clarissimi ove sedessero 65; consulares (ivi).
Visconti (C. Ludovico) 98, 105, 157.
Visconti P. E. segret. dell’Accademia di arch. romana, invita gli accademici al Colosseo per vedere i restauri 229, 242, 287, 292, 300.
Viri (VII epulones) 70.
Viri XIV (sacris faciundis) 70.
Vito e Modesto (Ss.) 283.
Vitruvio 8, 10, 11, 33, 48, 63, 71, 95, 320.
Vittoria Aziaca 281.
Vivarium 17; lapide in cui è ricordato (ivi); 277, 278.
Vizio delle iscrizioni cristiane sospette 290.
Volcanali (ludi) 127.
Volticelle a sesto scemo 238.
Vomitorî 63.
Wilpert 200.
Witige re dei goti assedia Roma 121, 275.
Xengeimester 309.
Xiphilinus e Dione 22, 318, 320.
Zenobia regina dei Palmireni 114.
[385]
ERRATA-CORRIGE.
| Pag. | linea | leggi | ||
| 10 | (Nota) | 1 | aremam | arenam. |
| 24 | (Nota) | 16 | Varrone, L., 1. | Varrone, L. L. V. |
| 26 | 32 | Fulla | Nulla. | |
| 46 | 10 | levassero» osservando | levassero». Osservando | |
| 54 | 10 | inter | iter | |
| 60 | 41 | (2) | (3) e viceversa. | |
| 60 | 25 | sincere | vincere | |
| 61 | 17 | Esquilo | Esquilino | |
| 64 | (Nota 2) | V. Tav. II | Tav. I. | |
| 70 | 2 | Tribonorum | Tribunorum | |
| 73 | (Nota) | 8 | 1002 | 1902 |
| 75 | (Nota 1) | Otc. | Oct. | |
| 115 | (Nota 2) | 17 | ex gemmis. | on gemmis |
| 128 | (Nota 6) | chion. | chron. | |
| 129 | 15 | e | è | |
| 150 | 9 | dimostrarono | dimorarono | |
| 150 | 19 | possedevamo | possedevano | |
| 152 | 18 | costruzione | sostruzione | |
| 171 | 7 | oratori | oratorî | |
| 174 | 23 | Senotorio | Senatorio | |
| 204 | (Nota 4) | 4 | Franco | Franchi |
| 252 | 16 | impteto | impleto | |
| 274 | 5 | ciciter | circiter | |
| 285 | 27 | genuità | genuinità | |
| 292 | 22 | genuità | genuinità | |
| 333 | 14 | genuità | genuinità | |
| 313 | (Nota) | 3 | idiotimis | idiotismis |
| 318 | (Nota) | 2 | quella | quello. |
| 325 | 16 | interpretati | interpreti. | |
[386]
FR. PACIFICUS MONZA
TOTIUS ORDINIS FRATRUM MINORUM MINISTER GENERALIS ET HUMILIS IN DOMINO SERVUS
DECRETO
Avendo Noi da persone competenti fatta esaminare l’Opera «L’Anfiteatro Flavio nei suoi venti secoli di storia» scritta dal R. P. Mariano Colagrossi della nostra Provincia di S. Maria in Aracoeli, ed avendola i censori riputata degna di singolare encomio; quanto è da Noi, non solo permettiamo che possa essere data alle stampe, ma ci congratuliamo altresì coll’Autore, lo incoraggiamo nei prediletti suoi Studii e facciamo voti, perchè le sue fatiche abbiano da conseguire sempre un prospero e felice successo,
Roma, dal Nostro Collegio di S. Antonio, il dì 8 Gennaio 1912.
L. S.
Fr. Pacifico Min. Gen.
Per comando di S. Paternità Rev.ma
Fr. Marco Della Pietra
Secr. Gen. dell’Ord.
NIHIL OBSTAT
D. Fid. Tarani, Ord. Vallisumbrosae
Abb G.lis, Censor.
IMPRIMATUR
Florentiae, die 4 Octobris 1912.
A. Can. Cassulo, Vic. Gen.
1. Enc. Pascendi.
2. Attento a non fare oltrepassare il prefisso termine al trigon, alla pila velox, alla pila paganica, all’harpastum ecc.
3. Dal greco μωρόν, idest stultorum lusus (Micare digitis).
4. Latrunculorum ludus. Dal tedesco Scach; latro. — Cf. Antiquitatum Rom. l. V, p. 306. Iohannis Rosini, cum notis doctissimis et locuplentissimis Thomae Demsteri I. C. ecc. Pyrrhus Epirota stratagematum peritissimus, primus, quemadmodum ea disciplina traderetur per calculos ostendit in tabula. (Donatus Grammaticus in P. Terentii Eunuchi, act. 4, sc. 7, ad illud: Idem hoc iam Pyrrhus factitavit). — Ammian. Marc., (l. XXIV) e L. Seneca, (De ira, c. XIV) attribuirono l’invenzione del giuoco dei scacchi a Chilone. Giovanni Saresberiense (Poligraf., l. VI) ad Attico Asiatico. Ma più probabilmente ne fu l’inventore Palamede, figlio di Nauplo, nell’assedio di Troia, come dimostra l’autore Antiq. Rom. già citato.
5. Dionisio d’Alicarnasso, l. VII, c. LXXII.
6. Mentre la moneta era in aria, pueri exclamabant: — «Capita!» aut «Navim!».
7. Giov., Sat. X, v. 81 et seg.
. . . . . . . . . . . . . . Nam qui dabat olim
Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se
Continet atque duas tantum res anxius optat:
PANEM ET CIRCENSES.
Era tanta la passione del popolo romano per i pubblici spettacoli, che, fin dalla mezzanotte precedente ai giuochi, incominciava ad occupare i posti gratuiti (Suetonio, in Calig. 26).
8. Dio., 66, 25.
9. Plinio, l. VIII, c. VII.
10. Seneca, De brev. vitae, c. XIII.
11. Ascon., In Pisonian.
12. Dio., l. XXXXIII.
13. Tito Livio, l. XXXIX, c. XXII. Athletarum quoque certamen tum primo Romanis spectaculo fuit, et venatio data leonum et pantherarum.
14. Id., l. XLIV, c. XVIII.
15. Loc. cit. Et iam magnificentia crescente notatum est ludis circensibus, L. Cornelii Scipionis Nasicae et P. Lentuli edilium curulium sexaginta tres africanas et quinquaginta ursos et elephantos lusisse.
16. Epist. di Liv., l. XXI.
17. L. II, c. VII, § 13-14.
18. Lett. di Pollion. a Cic., a. 710 d. R. XXXII, l. X delle famigliari.
19. Plinio, l. VIII, c. XVI, § 20.
20. Sen., De brev. vitae, c. XIII. Primus L. Sulla in circo edidit solutos, quum alioquin alligata darentur, ad conficiendos eos missis a rege Bocco iaculatoribus. — De Pompeii ludis. Cf. Dio., c. XXXVIII-XXXIX. Plin., Hist. Nat. VIII, 23.
21. Plin., Hist. Nat., l. VIII, c. VII.
22. Suet., In Caes., c. XXXIX, Plinio, loc. cit.
23. Plinio, loc. cit., c. XVII, § 24.
24. Nel circo la visuale era impedita non solo dalla sua forma eccessivamente prolungata, ma anche dalle méte, dagli obelischi e da tutto ciò che sorgeva sulla spina, ingombrando buona parte del circo stesso.
25. Dio., 43-22.
26. Id. 43-23.
27. A. d. R. 701.
28. Il teatro di Scauro, per quanto fosse provvisorio, pure pareva (dice Plinio) dovesse sfidare i secoli. Aveva 360 colonne in tre ordini soprapposti: il primo di marmo, il secondo di vetro, il terzo di legno dorato; la sua capacità fu di 80.000 spettatori. (Cf. «Il Buonarroti» Serie II, vol. V, Marzo 1870. — Anfit. Flavio per l’architetto L. Tocco).
29. Plinio, Hist. Nat., l. XXXVI, c. XV.
30. Coll’aiuto, forse, di ruote, rulli e palle metalliche. Ecco le parole di Plinio (Hist. Nat., l. XXXVI, c. XXIV):
C. Curio, qui bello civili in Caesarianis partibus obiit, funebri patris munere, cum opibus aparatuque non posset superare Scaurum.... Ingenio ergo utendum fuit, operae pretium est scire quid invenerit, et gaudere moribus nostris, ac nostro modo nos vocare maiores. Theatra duo iuxta fecit amplissima e ligno, cardinum singulorum versatili suspensa libramento, in quibus utrisque antemeridiano ludorum spectaculo edito inter se se aversis, ne invicem obstreperent scenae; repente circumactis ut contra starent, postremo iam die discendentibus tabulis et cornibus in se coeuntibus faciebat AMPHITHEATRUM, et gladiatorum spectacula edebat ipsum magis auctoratum populum Romanum circumferens.
31. Loc. cit.
32. Questa maraviglia oggi a noi sarebbe incredibile se, oltre ad altri autori, non l’accertasse Cicerone, che forse fu nel numero degli spettatori; in quel teatro, dice Plinio, tutto il popolo Romano fu esposto a poter perire come dentro una gran nave in mare. (Dal Period. «Il Buonarroti» loc. cit.).
33. Dio., XLIII, 22. Fino agli ultimi tempi della Repubblica in Roma gli anfiteatri erano di legno. (Vitr., 10, pref. 3; Dio., 37, 88.) Innalzati nel Foro, Cic., Pro Sest. 58. — Prop., 4, 8, 76; Livio, 23, 30; 31, 50. — Vitr., 5, 1; Plut., C. Grac., l. II, etc.
34. In Bucolico de venat. Carini. Et geminis medium se molibus alligat ovum. — Due teatri uniti insieme dànno appunto la figura di un uovo.
35. L. I, c. 7.
36. In met. 11, 25.
37. Loc. cit.
38. Dio., 51, 23; Suet., Aug. 29.
39. I più famosi, dopo il Flavio, furono quelli di Verona, Capua, Nimes, etc.
40. Suet., in Vesp., c. IX.
41. V. Guarini, Fasti duumvir., p. 32.
42. Suet., Calig., 21.
43. Tac., Ann. XIII, 31. Suet., Ner., 12.
44. Nel Dizionario epigrafico del De Ruggieri leggesi: «Nella Campania gli anfiteatri esistettero prima che in Roma. In Pompei si costrusse nel 684 d. R.». (Lett. A. Roma 1895). Allude senza dubbio agli anfiteatri stabili. Il Guazzesi, in una dissertazione tenuta in Cortona sugli anfiteatri etruschi e particolarmente su quello di Arezzo, cercò dimostrare che i Romani appresero dagli etruschi l’idea ed il modello per fabbricare anfiteatri. (Cf. Saggi di dissertazioni accademiche lette nell’accademia di Cortona. Roma 1738, p. 9). Ma il suo lavoro incontrò molte critiche, alle quali egli rispose con un Supplemento alla dissertazione degli anfiteatri toscani ecc. Venezia 1739. (Cf. Raccolta di opuscoli scientifici e filologici. Tom. XX, p. 427). Il Guattani (Roma descritta ed illustrata. Tom. II, p. 2) crede che i Romani apprendessero dagli Etruschi l’uso e la forma tanto dei teatri quanto degli anfiteatri. — Similmente e più recentemente, il Nispi-Landi (Storia dell’ant. città di Sutri, p. 527, Roma 1887), seguendo l’opinione del Dennis, scrisse di ritenere come molto probabile che gli anfiteatri sorti a Roma si modellassero massimamente su quello di Sutri, come più vicino. Noi siamo intimamente persuasi di quanto affermiamo nel testo.
45. Le naumachie si diedero nell’anfiteatro rarissimamente e come spettacoli straordinarî. A suo luogo parleremo diffusamente di questi navali combattimenti.
46. Talvolta il volgo chiamò l’anfiteatro arena, ed anche, come vedremo, cavea. Tacito scrisse: Spectacula gladiatorum idem ille annue habuit, pari magnificentia ac priora: sed faeminarum Senatorumque illustrium plures per ARENAM faedati sunt. — Giovenale:
. . . . et municipalis ARENAE
Perpetui comites.
In Suetonio leggiamo: Equestrem ordinem ut scenae ARENAEQUE devotum assidue procedit. In Capitolino: Multus qui secum in ARENA pugnassent, se Praetores videre. E nell’editto degli Edili: Quive in ARENAM depugnandi caussa ad bestias intromissus fuerit. — E qui ci domandiamo: Perchè l’anfiteatro si disse pur anche arena? Non v’erano per avventura strati d’arena anche sul suolo degli stadî, ecc.? Una sagace risposta ce l’offre Lipsio (De Amph. lib. III): Strata: sed non admissa, cave credas, quotiensque damnari in arenam, arena mitti, taliaque in Iurisconsultis sive historicis legis? caute accipias de ferro tantum, aut cultro, idest, gladiatoribus: aut VENATIONE, et magis pro ista. Imperator quidem clare discriminat ecce a circo. (Lege VIII, Cap. de repudiis): Nec ullo modo uxorem expellet nisi adulteram, vel circensibus, vel theatralibus, vel ARENARUM spectaculis se prohibente gaudentem. Anche il circo, benchè più raramente, si disse arena (v. Maffei, loc. cit., p. 98).
47. Eziandio la voce cavea fu usata in luogo di anfiteatro. In Ammiano (l. XXIX) leggesi: Alter in amphitheatrali CAVEA, cum adfuturus spectaculis introiret. In Tertulliano: (Contra Marcion.): Quid? non in omnem libidinem ebullis? non frequentas solemnes voluptates circi furentis et CAVEAE saevientis, et scenae lascivientis? Salviano scrive: Quidquid immoderationis in circo, quidquid furoris in caveis. G. Firmico: Nati subsidere caniculae, erunt venatores, arenarii, parabularii, et qui sub conspectu populi in CAVEIS cum feris pugnent. E Prudenzio:
Quid pulvis CAVEAE semper funebris et illa
Amphitheatralis spectacula tristia pompae?
Alle Vestali poi, che si portavano ad assistere ai gladiatorî spettacoli, rivolge queste parole:
Inde ad consessum CAVEAE pudor almus et expers
Sanguinis et pietas.
Apuleio dice: Dies ecce muneri destinatus aderat, et ad conseptum CAVEAE, prosequente populo, pompatico favore deducor. Tertulliano finalmente: si lectio recta est (dice Lipsio, loc. cit., c. II) CAULAM etiam in libello De Spectaculis dixit, nove magis quam improprie: ceterum qualia illa sunt quae nec oculus vidit, nec auris audivit? credo circo et omni stadio gratiora. Ubi ea voce includit etiam Theatrum nisi sit legendum cavea.
48. L’uso della voce gradatio per indicare il complesso dei gradi di un teatro non è mio ma di Vitruvio, il quale, parlando del teatro (l. V, c. III), dice: Insuper fundamenta lapideis et marmoreis copiis GRADATIONES ab substractione fieri debent. E al l. V, c. VI: Tectum porticus quod futurum est in summa GRADATIONE cum scenae altitudine libramentum perficiatur. Ora essendo il complesso dei gradi di un teatro e di un anfiteatro della stessa natura, ho creduto di poter rettamente adoperare quella parola.
49. Vitruv., l. V, c. III, (Praecinctiones) neque altiores quam quanta PRAECINCTIONIS ITINERIS sit latitudo.
50. Val. Max., V, 51.
51. Suet., in Aug., c. XLIV.
52. Cic., Phil. 2.
53. Quint., l. VI, c. III.
54. Cf. Martial., IV, 2; Cic., in Pison. Ap. Lips. Sat. I, 13.
55. Quint., l. VI, c. II.
56. Dio., l. LIX.
57. Suet., c. XLIII. — Commissione ludorum quibus Theatrum Marcelli dedicabat, evenit ut laxatis SELLAE CURULIS compagibus (Augustus) caderet supinus.
58. Dio., l. IILX.
59. L. I, Ep. 6.
60. Leggesi in Dione che fra gli onori decretati a Giulio Cesare v’era: «Deinde ut semper curuli sella sederet, esceptis ludis» (Dio., c. XLIIII). A quei tempi era dunque proibito agli spettatori l’uso di dette sellae. Più tardi però si collocarono queste nei luoghi dei pubblici spettacoli anche per onorare personaggi assenti, nonchè la memoria dei defunti (v. Lips., De Amph. lib., c. XI). Tacito (2, 83) narrando del S. C. per le onoranze funebri a Germanico dice: «honores decreti.... ut sedes curules sacerdotum augustalium locis, superque eas querceae coronae statuerentur». — V. etiam il framm. epigr. VTIQVE etc. (c. I. l. VI, 912).
61. Nat. Quint., l. II, c. IX, ep. 90.
62. Contr., l. V.
63. Marziale usa la voce Diana per Venatio: Inter Caesareae discrimina saeva Dianae. La caccia era pur dedicata a Giove, tanto Laziale quanto Stygio o Infernale. Del primo ce ne parla Tertulliano (Apolog.): Ecce in illa religiosissima Aeneadarum urbe est Iupiter quidam, quem ludis suis humano sanguine proluunt. Sed bestiariorum, inquitis, opinor hoc minus quam hominum. — Ed altrove (Adv. Gnost.) dice: Sed enim Scytharum Dianam, Gallorum Mercurium, Afrorum Saturnum, victima humana placari apud saeculum licuit. Et Latio ad hodiernum Iovi media in urbe humanus sanguis ingustatur. F. Minuzio aggiunge: Iupiter cum Hammon dicitur, habet cornua: et cum Capitolinus, tunc gerit fulmina, et cum Latiaris cruore perfunditur. — Di Giove Stygio o infernale ce ne parla Prudenzio:
Quid pulvis Caveae semper funebris? et illa
Amphitheatralis spectacula tristia pompae?
Hae sunt deliciae IOVIS INFERNALIS, in istis
Arbiter obscuri placidus requescit Averni.
Il sullodato Minuzio dice pur anche: Hodieque a Romanis Latiaris Iupiter homicidio colitur, et, quod Saturni filio dignum est, mali et noxii hominis sanguine saginatur. Per mali et noxii uomini il Lipsio (loc. cit., c. IV) intende i bestiarî, appoggiato in Tertulliano, il quale, come si è detto, opina che i bestiarî si debbano considerare minus quam homines. Per quanto sembra, anche a Saturno facevasi prender parte alla tutela degli anfiteatrali spettacoli. Lattanzio lo afferma, adducendo la sentenza di Sinnio Capitone: venationes et quae vocantur munera Saturno attributa sunt: ludi scenici Libero: circenses Neptuno.
64. Martem et Dianam utriusque ludi praesides novimus (Tert., De spect.). Lo conferma Claudiano nel panegirico scritto pel consolato di Manlio Teodoro:
Amphitheatrali faveat Latonia pompae:
Audaces legat ipsa viros qui colla ferarum
Arte ligent, certoque premant venabula nisu.
Il Lipsio (De Amphith., c. IV) crede che, oltre agli spettacoli, anche l’anfiteatrale edificio fosse dedicato a Diana; e dai versi del poeta cristiano:
Funditur humanus Latiari in munere sanguis
Confessusque ille spectantem solvit ad ARAM
Plutonis fera vota sui; quid sanctius ARA
Qua bibit egestum per mistica tela cruorem?
deduce che negli anfiteatri eravi eziandio l’ara. Dello stesso parere sono molti archeologi, e fra essi il Guattani (Roma descritta ed ill., Tom. II, p. IX), il quale cita Giuseppe Fl., (Antich. Giud., l. XIX, c. II); il Venuti (Roma ant., part. I, p. 28); il Morcelli (de Stilo inscript. lat. p. 101); ecc.
65. Epist. ad Quint. fratrem, I, 9.
66. Paolo Giuric. De legatis, I, 122.
67. Dio., 54, 34; Tacito, Hist. II, 95.
68. Mors Sciani ut quotannis venationibus celebraretur decrevit Senatus (Dio., 52, 12).
69. Cf. De foro Caesaris (Dio., 43, 22); De templo Qirini ab Augusto dedicato, Dio., 51, 19; Augusti a Calig. Dio., 59, 7. Huic pertinet inscriptio in thermis reperta pubblici iuris facta in Mus. Borb. — Tom. II, relaz. degli scavi. Cf. c. I, l. IV, 1180.
70. Dio., 44, 6. — Pro salute Caligulae Atanius secundus eques tamquam gladiatorem se pugnaturum voverat (Suet., Cal. 27); Claudius proetoribus gladiatores dare vetuit nisi pro ipsius salute (Dio., 69, 8). — Cfr. Inscript. apud Murat., 612, 3; 614, 4; — Pro salute domus Augustae, Guarini, Fasti decemvirali, cet. p. 172, 7; Bull. dell’Istit. archeol. 1831, p. 12; Gruter., p. 475, 3, c. I, l. IV, 1180.
71. Suet., Nero 7.
72. Abbiamo alcune iscrizioni pompeiane che ci rendono certi di questi editti.
1ª
A . SVETTI . CERTI
AEDILIS . FAMILIA . GLADIATORIA . PUGNABIT . POMPEIS
PR . K . IVNIAS . VENATIO . ET . VÉLA . ERUNT
OMNIBUS NERO ERIBVS. FELICITER
(c. I, l. IV, n.º 1190).
2ª
PRO SALVTE
CAESARIS . AVGV ... LIB .. RVMQV
DEDICATIONEM . ARAE CN EI NIGIDI MA
FLAMI .... CAESARIS . AVGVSTI . PVG . POMPEIS SINE VLLA DILATATIONE
IIII . NON . IVL . VENATIO VELA ERVNT
(c. I, l. IV, n.º 1180).
V. anche i numeri 1183, 1186, 1187, 1189 ecc., vol. IV, dello stesso C. I. L.
Oltre ai pubblici editti fissati sui muri, l’editor, il dì che precedeva lo spettacolo, faceva circolare dei libelli, coi quali rendeva di pubblica notizia il numero ed i nomi dei gladiatores e venatores. Quest’atto dicevasi pronuntiare munus. Suetonio (In Iulio) scrive: Munus populo pronuntiavit in filiae memoriam. Dicevasi pur anche ostendere munus. Cicerone: Etsi munus flagitare, quamvis quis ostenderit, ne populus quidem sol et nisi concitatus (Cfr. Lips., De Sat., l. II, c. XVIII). Se fra i gladiatori che doveano esibirsi alla pugna v’era qualcuno famoso, il suo nome veniva accompagnato da una laudatoria (Trebon. Pollio, Claudio, V. p. 361); e presentavasi eziandio il suo ritratto in atteggiamento di pugnare coll’avversario, dipinto o lineato con carbone (Horat., Sat. II, 7, 95).
73. Plinio, l. VIII.
74. Loc. cit. — Nec praeter marmoris numidici ferarumque proventum aliud insigne.
75. Epigram, CV, l. I.
76. Mart., De spect., Epig. XIX, l. XXII; S. Cipr., Ep. CIII, ed altri.
77. Claudiano, Secund. Cons. Stilichonis, v. 322 e segg.:
Haec laqueis innexa gemunt haec clausa feruntur
Ilignis domibus. Fabri nec tigna polire
Sufficiunt: rudibus fagis texuntur et ornis
Frondentes caveae. Ratibus pars ibat onustis
Per freta, per fluvios. Exanguis dextera torpet
Remigis, et propriam metuebat navita mercem.
Per terram pars ducta rotis, longeque morantur
Ordine plaustra vias, montani plena triumphi:
Et fera sollicitis vehitur captiva iuvencis,
Explebat quibus ante famem; quotiesque reflexi
Conspexere boves, pavidi temone recedunt.
78. Simm. a Paterno, Lett. LXV: Quadragesimae portorium sive vectigal non recte poscitur a senatoribus candidatis.... Quaeso igitur ut humanitatem.... nostri ordinis editoribus dignanter impertias, et ursorum transvectionem cupiditati mancipium subtrahas.
79. Loc. cit.
80. Monum. dell’Ist. di corrisp. archeol. 1842.
81. Simm., Epist. XIX, l. X: Plures de Dalmatia ursos in apparatum domus nostrae proxime venturos fides asserit nunciorum: quorum subvectionem dispositis vehiculis etiam privatim debemus instruere.
82. Horus., l. XII; Sen., de ira.
83. Apuleio, Met. l. IV.
84. Gellio, Noct. attic.
85. Murat., p. 654, I; Vop., Prob. 19.
86. Procop., Guerra Gotica, l. I, c. XXII.
87. La lapide dice:
PRO S . IMP . M . ANTONII . GORDIANI . PII
FELICIS AVG . ET TRANQVILLINAE SABI
NAE AVG . VENATORES IMMVNES . CVM CV
STODE . VIVARI . PONT . VERVS . MIL . COH .
VI PRAE . CAMPANIVS VERAX . MIL . COH . VI
PR . FVSCIVS . CRESCENTIO ORD . CVSTOS
VIVARI . COHH . PRAETT . ET VRBB .
DIANA AVG . D . S . EX . V . P .
DEDICATA XII . KAL . NOV .
IMP . D . N . GORDIANO . AVG . ET PONPEIANO . COS .
(c. I, l. VI, 130).
88. Elephanti et tauri, Mart. in Amphith. 17. rhinoceros et tauros, 9; et ursus 19.
89. L. I, epig. XV, XXIII, XLII, et LXXXVI.
90. Mart., Epig., XV, XXIII: XLII et LXXXVI.
91. Elephas introductus in theatrum, in summum eius fornicem conscendit, atque inde vehens hominem in fune ambulavit. — Xiph. e Dione, p. 511. Basileae apud Ioannem Oporinum. — Cf. L’Italia descritta e dipinta. Tomo III, p. 65. Roma.
92. Talvolta i venatores indossavano galea, scudo e lorica. Cf. Sante Bartoli, Pitt. ant. delle grotte di Roma, II, 27, 28. Cf. la moneta in cui è rappresentata la venatio e col nome di L. Regolo, ecc.
93. Mart., loc. cit., VII. — Cassiodoro tratta diffusamente di queste lotte: ecco le sue parole: «Primus fragili ligno confisus currit ad ora belluarum, et illud, quod cupit evadere magno impetu videtur appetere. Pari in se cursu festinat et praedator et praeda, nec alter tutus esse potest, nisi huic, quem evitare cupit, occurrerit. Tunc in aëre saltu corporis elevato quasi vestes levissimae supinata membra iaciuntur, et quidam arcus corporeus supra belluam libratus, dum moras descendi facit, sub ipso velocitas ferina descendit. Sic accidit ut ille magis possit mitior videri, qui probatur illudi. Alter angulis in quadriferia mundi distributione compositis rotabili facilitate praesumens non discedendo fugit, non se longius faciendo discedit; sequitur insequentem, poplitibus se reddens proximum, ut ora vitet ursorum. Ille in tenuem regulam ventre suspensus irritat exitialem feram. Alter se gestibili muro cannarum contra saevissimum animal ericii exemplo receptatus includit . . . . . sic iste consutili crate praecinctus munitior redditur fragilitate cannarum. Alter labenti rota feris offertur eadem alter erigitur, ut periculis auferatur. Alii tribus, ut ita dixerim, dispositis ostialis, paratam in se rabiem provocare praesumunt, in patenti area cancellonis se fortibus occulentes, modo facies, modo terga monstrantes, ut mirum sit evadere, quos ita respicis per leonum ungues dentesque volitare». Cass., Variar., 42.
94. Cf. Suet., Claud. 34; Ovid., Metam., XI, 26; Sen., ad Lucil. 8; Cf. etiam Bulenger, De venat. circi.
95. Lib. II, Epig. LXXV.
96. Cassiodoro fa menzione delle cacce date nell’anfiteatro Flavio l’anno 519 e 523 dell’era volgare, gli ultimi che siano ricordati nella storia. — V. Nibby, Roma nel 1839, parte ant., p. 389.
97. Omero, Iliad. 23, 175, 176.
98. Tito Livio, VII, 15. Cf. Aen., l. XI, v. 81 et segg.
99. Tert., de spect. XII.
100. Serv., ad Virg. Aen. X, 519: Sane mos erat in sepulchris virorum fortium captivos necari, quod postquam crudele visum est, placuit gladiatores ante sepulchra dimicare, qui a bustis bustuarii dicti sunt.
101. Gladiatorum munus primum Romae datum est in Foro Boario Ap. Claudio, M. Fulvio coss. — Dederunt M. et D. Bruti funebrii memoria patris cineres honorando (Val. Mass., l. II, c. V; T. Livio, Ep. l. XVI.)
102. In origine, come è noto, gli spettacoli gladiatorî erano privati. Divenuti pubblici, si eseguirono nei fori, nei circhi, nei teatri, ecc.: e finalmente negli anfiteatri, i quali come si disse, sono, per ragion di età, gli ultimi edificati pei pubblici spettacoli.
103. Invaghiti, senza dubbio, dalla gloria passeggiera di vedersi applauditi dagli innumerevoli spettatori. Questa gloria effimera, non poche volte, chiamò nel numero dei gladiatori anche, come dicemmo, uomini liberi, senatori, patrizî, magistrati, e finanche qualche donna; e, finalmente, pure qualche imperatore, come, per es., Commodo.
104. I gladiatori volontarî venivano sottoposti ad un giuramento speciale, col quale s’obbligavano di obbedire al loro padrone, ancorchè questi ordinasse la loro uccisione. Una formola di questo giuramento la trovo nel Satyricon (cap. CXVII) di Petronio. Eccola: «Uri, vinciri, verberari, ferroque necari, et quidquid aliud Eumolpus iussisset, tamquam legitimi gladiatores, domino corpora, animisque religiosissime addicimus».
105. Suet., Iul. 26; Cic., pro Roscio Amer. 40; Iuv., VI, 16; XI, 8. I lanistae facevano esercitare i loro discepoli (familiae di gladiatori. Suet., Aug. 42) con spade lignee (rudes). Suet., Calig. 32, 54.
106. Serv., ad Virg. Aen. X, 519. — L’Henzen dice che tutti i gladiatori che pugnavano ad sepulchra si chiamarono bustuarii; loc. cit., p. II.
107. In Roma i principali collegî gladiatorî erano: il Matutinus, il Gallicus, il Dacicus, ed il Magnus. Di quest’ultimo ludus si conserva il disegno nella pianta marmorea di Roma, che trovasi in Campidoglio. V. Canina, Arch. Rom., Tav. CXXXIV.
108. L. VII, Epist. XIV.
109. Quest’atto, come è noto, i latini lo denotavano colla frase proponere, pronunciare, ostendere munus.
110. Componebat, comparabat, committebat gladiatores.
111. Cic., De orat. 11, 78, 80; Ovid., Ars Am. III, 515. Sen., Ep. 117.
112. Di qui, a quanto pare, nacque la voce battaglia.
113. Ed allora i gladiatori si dicevano Catervarii. Suet., Cal. 30.
114. Ulpiano fa distinzione fra i gladiatori condannati ad gladium, e fra quelli condannati ad ludum. «Nam, dice, ad gladium dannati, confestim consumuntur, vel certe intra annum debent consumi; enimvero qui in ludum damnantur, non utique consumuntur, sed etiam pilleari et rudem accipere possunt post intervallum. Siquidem post QUINQUENNIUM pilleari: post TRIENNIUM autem rudem induere iis permittere». I Rudiarii (ossia i gladiatori che avevano riacquistato la libertà) non tornavano a pugnare nisi pretio aut sponte inducti; ed eran soliti di consacrare le loro armi (e talvolta anche i premî) a Ercole gymnasiorum deo.
115. Xiphil., LXXII, 19. — A questa classe di gladiatori apparteneva Commodo, il quale si vantava di essere il primo fra i secutores, e di aver ucciso molti reziarî (Lampr., in Comm. XV).
116. Isid., Orig. XVIII, 52; Cf. Artemid. Oneicr. II, 33.
117. Iuv., VIII, 210; Suet., Calig. 30.
118. Is., Or. XVIII, 57. — Probabilmente l’uso della rete ebbe origine dal fatto di Pittaco, del quale parlano Laerzio (l. I) e Strabone (l. XXIII). Essendo Pittaco capitano dei Mitilenei combattè col capitano degli Ateniesi in figura di pescatore; e, dopo aver avvolto l’avversario nella rete che seco avea portata nascosta, lo ferì col tridente e col coltello. In un medaglione di Gordiano Pio, illustrato dal Bonarroti, si ha l’effigie di un reziario che tira a sè il competitore, il quale ha il capo avvolto in una rete. Questo stesso s’osserva in un bassorilievo affisso presso la tomba di Cecilia Metella.
119. Terribile era il gladiatore Ermete, ricordato da Marziale. Costui pugnava in tre diversi modi: all’uso, cioè, dei Sanniti, dei Reziarî, degli Andabati; e non avea bisogno di suppositizi, ossia di gladiatori che supplissero a lui stanco o ferito (Mart. lib. V, Epig. LII). Il tridente era un’arme micidialissima. Una volta cinque reziarî restarono soccombenti ad altrettanti secutori, ma al momento di esser trafitti, uno di essi, ripreso il tridente, uccise con questo tutti i vincitori. Lo stesso Caligola deplorò la fierezza di quell’atto (Suet., Cal. 30). Ad Arnobio, quando vedeva l’immagine di Nettuno col tridente in mano, sembrava di vedere un gladiatore (l. 6).
120. Sen., Q. N. IV, 1.
121. Un esempio l’abbiamo in una lampada figulina illustrata dal Rich. (Dictionary of Roman and Greek antiquities. London 1860, v. Thrax.).
122. Retiarii, dice l’Henzen, committebantur cum omnibus... gladiatoribus, praeter Threcem, de cuius certamine contra eum certe mihi notum non est. Cf. Explicatio Musivi in villa Burgh. asserv., Parte II.
123. Cic., Sent. 64.
124. Mart., VIII, 24.
125. Tertulliano ci parla di questa spugna: «poterit et de misericordia moveri defixus in morsus ursorum et spongias retiariorum» (De Spect., lib. c. X, De munere). Questo passo, dice il Maffei (loc. cit., pag. 147) «indica, che ne’ reziarî così chiamavasi qualche arme da offesa, non da difesa;.... leggo moneri e non moveri, com’hanno le stampe..... perchè non fa senso. Ora una coperta del petto non sarebbe tanto a pietà opposta nè ben corrisponderebbe al morso degli orsi. I reziarî inoltre combatteano senza armatura, ed in tunica, e senza ascondere in celata la fronte come si legge in Giovenale (Sat. 8). Potea darsi per certa somiglianza alla rete, e poteva alla corta spada ancora, forse perchè il suo manico traforato fosse e lavorato a guisa di spugna. Inclino a credere questo per quel motto d’Augusto riferito da Suetonio (c. 26): Aiacem suum in spongiam incubuisse. Era questa una tragedia da lui cominciata, che non riuscendogli a suo modo, l’annullò cancellandola, al quale ufizio serviva presso gli antichi la spugna. Ma fredda facezia sarebbe stata quella d’Augusto, intendendo semplicemente, come Casaubono e tutti gli altri hanno fatto (fra i moderni V. Manuale della letteratura latina, G. Vitelli e G. Mazzoni, p. 301. Editore Barbera, 1907) senza che doppio senso potesse avere quella voce, l’istrumento da cancellare, per cui dovesse acquistar grazia tal detto. Parmi però potersene ricavar con certezza ch’anco alcune armi da punta portasse il nome di spugna, per lo che si venisse ad intendere, aver la tragedia avuto simil fine ad Aiace stesso che si diede la morte abbandonandosi sopra una spada».
126. Giov., VI, 256. Queste particolarità si riscontrano anche in un bassorilievo di stucco, rinvenuto in Pompei ed illustrato dal Mazois.
127. Tito Livio, IX, 40.
128. Varrone L., l. V, 142.
129. Ecco quanto l’Henzen, (Expl. Musivi etc. Tip. della Rev. Cam. Apost., 1852, p. II) scrive relativamente ai velites o provocatores: «De velitibus ac provocatoribus Maffei sententiam sequendam esse putaverim, quippe qui pro iisdem fere eos habeat. Velitum pugna erat ut ultro citoque tela obiectarent (Isid., Orig. XIII, 54): et quum in re militari velites ad proelia incipienda adhiberentur, eundem in arena eorum usum fuisse probabile est, qua cum dimicandi ratione optime congruit provocatorum nomen. Quod praeterea Artemidorus (Oneicron, II, 33), ubi emendatio vocabuli προβακτωρ in προβοκάτωρ certissima est, dicit significari somnio de provocatore, coniugem εὔμορφον μὲν καὶ χαρίεσσαν, λαμυράν δὲ καὶ ἒρωτικήν, ad eandem certaminis rationem spectare videtur, quae varia erat, spectantibus vero gratior quam reliquae (Isid., Orig. XVIII, 54). Levem certe armaturam provocatorum quoque fuisse iam Ciceronis loco apparet, qui Clodium narrat servos ex ergastulis emptos, sortito alios samnites, alios provocatores fecisse, ita puto, duo genera maxime diversa indicans, ut hominis negligentiam ac levitatem eo severius perstringeret. Nomine provocatoris loco, quod apud Ciceronem legitur ceterae inscriptiones omnes nihil nisi PROVOK (Orell. 2508) vel PROV (Orell. 2566, ex Marin inscript. Alb. p. 12) exhibent. Velites inter gladiatores, fuisse negavit Fabr. inscript. 203, p. 39: Vel. velarios interpretatus sed velarii ipsi non erant gladiatores sed milites plerunque navales (Lamp. Comm. 15), neque eos inter gladiatores recenseri credere possum. Praeterea habemus Isidori testimonium haud dubium, et si recte emendaverit Rigaltius (in notis ad Artemid. Oneicr. II, 38); ibi quoque pro vocabulo ὀρβήλος, quod nullum est, οὐήλης legimus».
130. Giov., Iorn. c. II; Cic., ad Georg. l. III. In un’iscrizione si legge: assidarium. V. Muratori, 613, 3.
131. Un esempio degli Andabatae l’abbiamo nel monumento di Scauro. Cf. Henzen, loc. cit. L’Andabata usava l’hasta e la parma rotunda. Portava un elmo dorato (Isid., Orig. XVIII, 50), senza apertura nella visiera (Hieron., ad Iov. I, 36).
132. Se ne fa menzione da Artemidoro (Oneic. II, 33) e nell’iscrizione 603, 3 riportata dal Muratori. Dymachaeri sono queste due statue del Museo Borbonico rappresentanti due uomini morenti, che impugnano una spada per mano.
133. I gladiatores fiscales si chiamarono anche Caesariani; e poichè eran essi «eximii viribus, arte, ornatu (Lips., Sat., l. II, p. 959) e spesso il popolo domandava agli Imperatori il favore di vederli combattere nell’arena, furon detti eziandio Postulaticii. Seneca (Epist. VII) scrisse: «Hos plerique ordinariis et postulaticiis paribus praeferunt».
134. Seneca, Epist. ad Lucil. 8; cf. 96; Tert., Apol. 15. — Dione Cassio biasima quegli inumani spettatori, i quali mentre pranzavano, summo studio, assistevano a quella orrenda carneficina. Dio., 60; Suet., 34.
135. V’era pur anche una classe di gladiatori detta Catervarii, «a modo pugnae, scilicet cum non singuli cum singulis, ut moris, sed confusi mixtique pugnant per catervas» (Lips., Saturn. Serm. l. II, p. 960). In Giuseppe Flavio (De Antiq. l. VII) leggiamo: che Tito «Multis e captivis illic consumpti, aliis bestiis obiecti, alii catervatim, et plures, more hostium, depugnare inter se iussit». Questo spettacolo fu dato da Tito in Cesarea.
I Pegmares (Pegmatici o Pegmatarii, come più piace chiamarli) erano quei gladiatori i quali «pegmatis impositi depugnabant» (Lips., loc. cit.). Suetonio dice: Gladiatorio munere reductis interdum flagrantissimo Sole velis, emitti quenquam vetabat, remotoque ordinario apparatu, rapidis feris vilissimos senioque confectos, gladiatores quoque PEGMARES, patreffamiliarum notos, sed insignes debilitate aliqua corporis subiiciebat» (Suet., in Calig. XVI). Il Lipsio (loc. cit.) crede doversi leggere «gladiatoribus quoque pegmares», in questo senso: «Rabidis feris bestiarios viles, invalidosque: et gladiatoribus operas pegmares fabrosque subiiciebat». Secondo altri avrebbero preso questo nome da pegma, specie di torre, che veniva eretta nel mezzo dell’Anfiteatro. La sommità della torre sarebbe stata ricoperta di scudi, elmi ed armi, da darsi in premio ai vincitori. I gladiatori, divisi in due schiere, dovevano chi attaccare e chi difendere la torre. Sarebbe stata una rappresentazione dell’assalto ad una fortezza.
136. Cod. Teodos., Lib. XV. Tit. XII; l. 1; Quapropter, qui omnino gladiatores esse prohibemus; eos qui forte delictorum caussa hanc conditionem, atque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine suorum scelerum paenas agnoscant.
137. Conf., VIII.
138. Contra Symm., l. I, v. 379 e segg.
139. Lib. V, cap. XXVI.
140. A. 403, secondo Tillemont, 404 secondo altri.
141. V. nota quasi alla fine del Capitolo IV, Parte I, di questo lavoro. — V’ha chi crede che questo monaco di nome Telemaco sia quello stesso che dal Martirologio Romano (v. I Ian. colle note del Baronio) vien detto Almachio. Tillemont (Empereurs, Honoré, art. 20, p. 533 sgg.) fa queste osservazioni: «Il est difficile de ne pas reconnaître que tout ce qu’on dit de s. Almaque est ou faux ou très altéré».
142. Nei Cataloghi s’aggiunge il Castrense, ma questo, come vedremo nella PARTE IV, Quest. 3ª, fu un anfiteatro privato, non destinato, cioè, ai pubblici spettacoli.
143. Parvum lapideum condidit. Isid.
145. Dio., p. 709. Ed. Leunel.
146. Verona illust., Parte IV, l. I, p. 50. Verona MDCCXXXI.
147. Suet., in Vesp. c. IX.
148. «Struxit autem Vespasianus in consulato suo octavo: idest, vix biennio, ante vitae finem» (Lips., De Amphith., c. VI). Vespasiano morì l’anno 79 d. C.
149. I trionfi della Guerra Giudaica furono celebrati colla dedicazione del vicino Arco di Tito, sulla Via Sacra (Cass., Variar. l. V, epist. XLII).
150. Suet., in Vesp. c. IX.
151. Varr., de L. Lat., l. IV, c. VIII. — V. Guattani, Tom. II, p. 3.
152. Suet., in Ner. 31. Stagnum maris instar circumseptum aedificiis ad urbium speciem.
153. Epig. 2.
154. Facevan capo a questo centralissimo luogo, oltre al Vico Sandalario, le tre celebri e frequentate vie: la Saburra, la Salaria e la Trionfale detta anche Nuova perchè rinnovata da Caracalla, allorchè edificò le Terme.
155. Mercurio volante, p. 153.
156. De Bello lud., l. VII, c. XXIV (Coloniae Alobrog. MDCXI. Ex Typ. Iacobi Stoer).
157. Loc. cit., l. VII, c. XVI.
158. Non è però improbabile che vi lavorassero, attesa la grandiosità dell’opera ed il tempo, relativamente breve, in cui fu portata a compimento, molte migliaia di schiavi; ma non è possibile assicurarne, come fa il Rossino, il numero preciso e, molto meno, accertare che essi fossero tutti Ebrei.
159. Vix biennio. Cf. Lips., loc. cit.
160. Chronicon A. 334. A tribus gradibus patris sui duos adiecit. (Cf. Frick, Chronica minora, Lips. 1892. Vol. I, p. 116).
161. Lips., (loc. cit.) dice a questo proposito: «non male S. Rufus ambigue inscripsit, Flavii Amphitheatrum, etsi fama et vulgus Tito magis adiudicavit: sive favore quodam in illum, sive potius ex romano ritu, quo receptum opera censeri a dedicante».
162. Frick, loc. cit. p. 117: — Domitianus Imp...... Amphitheatrum usque ad clypea.
163. Bull. della Comm. arch. comun. di Roma, p. 272 e sgg. Anno VIII, serie seconda, 1880. Sui loca adsignata in amphitheatro ai fratelli Arvali, nella prima assegnazione dell’anno 80 fatta da Tito, abbiamo uno splendido documento negli atti del Collegio dell’anno medesimo. V. Marini, Arvali p. 224; Canina, Edif. 3, 26; Hübner, Ann. Inst. 1856, 62 sg.; Mommsen, Ann. Inst. 1859, 125; Henzen, Arv., p. 106 et sg.; C. I. L. VI, p. 506. — Ecco l’importantissimo documento, inciso, disgraziatamente, da uno scalpellino idiota o poco meno:
164. Vitruv., De arch., l. IV, c. V, 12: Sunt autem, quae iisdem columnis imponuntur capitulorum genera, variis vocabulis nominata: quorum nec proprietates symmetriarum, nec columnarum genus aliud nominare possumus, sed ipsorum vocabula traducta et commutata ea Corinthiis et pulvinatis et Doricis videmus, quorum symmetriae sunt in novarum scalpturarum translatae subtilitatem.
165. L’Arco trionfale di Tito sulla Via Sacra. V. Nibby, Roma Ant. Part. I, p. 295.
166. Nell’interno dell’Anfiteatro si veggono tuttora 26 capitelli di quest’ordine. Essi sono semplici, senza intagli, ma di discreta proporzione e di una ben intesa esecuzione. E se alcune parti secondarie di questi capitelli furono lasciate in abbozzo, fu senza dubbio in considerazione della grande altezza in cui si dovean collocare, e della vastità dell’edificio. Presento al lettore la riproduzione di un capitello tratta dalla fotografia che io stesso ho fatto fare. (Vedi Fig. 1ª).
167. E qui sorge una difficoltà. Uno dei capitelli marmorei del colonnato del sommo meniano è ricavato da un blocco di marmo che ha incisi i residui di un’iscrizione monumentale. Come spiegare questo fatto? — I restauri ingenti fatti da Eliogabalo e da Severo Alessandro nell’ultimo piano dell’Anfiteatro (ove la parete di travertini è internamente rivestita di una cortina laterizia dell’epoca di quei Cesari) mi pare possano far dileguare questa difficoltà. In quella vasta riparazione (resa necessaria dai danni causati dall’incendio del 217), alcuni dei capitelli furono certamente rinnovati. D’altra parte, l’uso comune in quell’epoca, di adoperare pietre appartenute ad altri edifizî, è a tutti noto; e il timpano, a mo’ d’esempio, del Portico d’Ottavia, nonchè alcuni punti della muraglia di travertini dell’ultimo piano dello stesso Anfiteatro Flavio ce ne sono una prova patente. — D’altronde quel capitello, coi residui della monumentale iscrizione, potrebbe anch’essere dell’epoca Domizianea; giacchè una parte dei materiali appartenuti ai distrutti edificî neroniani furono senza dubbio adoperati nell’edificazione dell’Anfiteatro. — Il frammento d’iscrizione rimasto sulla faccia superiore del capitello, ha (tra le poche parole tronche) queste tre lettere: NER (Nero?). Generalmente si supplisce NER (vae?). V. Lanc., loc. cit., p. 217; c. I, l. VI, part. 4ª, n. 32255. Ma del resto si presta pur anche al supplemento da me proposto. Vicino a questo capitello ve n’è un altro con quattro testine rappresentanti Medusa.
168. Nell’anno 80 d. C., Tito occupava il consolato per l’ottava volta, insieme a Domiziano, il quale era console per la settima volta.
169. De Spect., Epig. I.
170. Loc. cit. Epig. III.
171. Suet., in Tito c. VII: Amphitheatro dedicato, thermisque iuxta celeriter extructis, munus edidit apparatissimum, largissimumque. Dedit et navale praelium in veteri naumachia; ibidem et gladiatores: atque uno die quinque millia omne genus ferarum.
173. Chron.
174. Ecco come ragiona Nolli: «L’arena, nel suo maggior diametro, era lunga palmi architettonici 450 per 305. Tutta l’area dell’arena sarebbe 107,795 palmi quadrati; e sulla supposizione che il sito occupato da un orso o leone o tigre ben grande sia di palmi quadrati 16, l’arena risulterebbe capace di 6737 fiere. Ma poichè non tutte le fiere hanno la stessa grandezza, così, calcolando a ciascuna fiera 10 palmi quadr., l’arena sarebbe capace di 10,779 fiere. — Il numero dunque di 5000 esposte da Tito, e di 9000 esposte da Probo, non è esagerato. Ma, s’intenda, non per farle giuocare tutte uno die nell’Anfiteatro, ma per mostrarle tutte UNO DIE al popolo». (Cf. Marangoni, Anf. Fl. p. 50).
175. Dio., l. XVI, 25, Trad. del Bossi, Milano 1823.
176. Il Casaubono corresse il testo di Sifilino, sostituendo alle gru, «Γεράνοις», i germani, «Γερμανος». — Il Reimaro si oppose a questa correzione. — Il Gori (Memorie storiche ecc., Roma 1875), ed altri dicono che, come è favoloso il combattimento delle gru coi pigmei, così è inconcepibile che quelle combattessero fra di loro.
177. Detto Nemus Caesarum.
178. ἐφ’ ἑκατον ἡμἐρας ἑγἐνετο.
179. La Mèta Sudante era una «fontana celebre, esistente in Roma prima dell’Anfiteatro Flavio» (Nibby, Del Foro Rom. p. 245). In Seneca leggiamo: Essedas transcurrentes pono, et fabrum inquilinum, et serrarium vicinum, aut hunc, qui ad Metam Sudantem tubas experimur et tibias; nec cantat sed exclamat (Ep. LVII). «Domiziano, prosegue il Nibby (loc. cit.) la ristabilì, forse perchè Nerone l’aveva distrutta, e questa seconda Mèta Sudante fu assai bella e decorata».
180. Cf. Nibby, loc. cit., p. 402.
181. Loc. cit., p. 43.
182. Roma descritta ed illustrata, Tom. II, p. 5.
183. Del Foro Romano, p. 239: «Tra il numero XXXVIII e XXXVIIII è l’ingresso imperiale, quindi l’arco ivi è più grande degli altri (?) e non ha numero.... Questo luogo, riservato alla famiglia imperiale, si trova affatto separato dal resto, e forse quest’ingresso era più decorato degli altri, e v’ha chi suppone che di là cominciasse un portico di colonne che andava a finire al palazzo di Tito sull’Esquilie; ma di ciò non può darsi altra prova, se non che negli ultimi scavi si sono in questo luogo trovati frammenti di colonne scanalate di marmo frigio, che ivi ancora si veggono, e sopra l’arco manca il cornicione con tutti gli ornati, e nelle medaglie si vede indicato un tal portico».
184. Maffei, loc. cit., l. I, p. 45.
185. Id., ibid., p. 45.
186. Id., ibid., p. 45.
187. Nibby, Del Foro Romano, p. 245.
188. Cf. Charisius, I, 73: «Titus ut lupus. Thermas Titinas, ut pelles lupinas non dicimus, sed Titianas».
189. V. la nota verso la fine del Capitolo I, Parte II, di questo lavoro.
190. Cohen, II ediz., Titus, Vol. I, p. 461, n. 400.
191. Id., Ibid., n. 399.
192. Roma antica I, 403.
193. Archit. Numism. or, architectural models of classic antiquity, London 1859 n. 79, pag. 294.
194. Vol. III, pag. 340.
195. F. Gori, Mem. storiche, i giuochi ecc. Roma 1875.
196. «Bull. della Ist.» 1861, p. 33.
197. La medaglia illustrata dal Donaldson e da lui detta grande bronzo, conservasi nel Museo Britannico.
198. V. Maffei, loc. cit., Tav. I.
199. Nell’anno 80 di C. furono battute altre medaglie, come ad es., quella in cui è rappresentato Vespasiano in quadriga e recante (nel dritto) l’iscrizione: DIVO AVG. VESP. S. P. Q. R. (Cf. Cohen, loc. cit.); ma poichè non è certo che siano commemorative, tralascio di riportarle.
200. Variar. l. V, Epist. XLII: Hoc Titi potentia principalis divitiarum profuso flumine cogitavit aedificium fieri, unde caput urbium potuisset etc.
201. Voyage en Italie, Paris 1801, p. 385 e sgg.
202. «Bull. Comm.» loc cit. p. 215.
203. «Ann. dell’Ist.» 1850, p. 68-71, Tav. XII.
204. Il Guattani (Roma descritta ed illustrata. Tom. II, pag. 3) si domanda: «Perchè non dare agli anfiteatri una forma perfettamente sferica? Due, a mio credere, prosegue egli, ne furono le ragioni. Una la trovo nel vantaggio di accorciare la visuale degli spettatori, in guisa che, o empiendosi l’anfiteatro la maggior parte, o non empiendosi tutto, il popolo vedeva più comodamente lo spettacolo; tanto più che essendovi la necessità di coprirlo, illanguidivasi necessariamente la luce. Inoltre la forma elittica riesce appunto più facile a coprirsi, restando la lunghezza del maggior numero delle tele e delle gomene dalla linea circolare interiore all’esteriore più corta».
205. Amm., l. XVI, c. XVI, scrisse: Amphitheatri molem solidatam lapidis tiburtini compage, ad cuius summitatem aegre visio humana conscendit. — Non v’ha dubbio che la venerabile mole dei Flavî, veduta da vicino e dal piano antico, sia sommamente imponente.
206. Cinque di questi cippi furono scoperti nel 1895 all’Est dell’Anfiteatro, di contro alle arcate XXIII, XXIIII e XXV («Bull. Comm.» 1895, n. 3, p. 117 e segg.).
207. Verona illust. p. 186.
208. Questi stucchi furono disegnati da Giovanni da Udine ed incisi nella Raccolta di De-Crosat. (Vasari, Vita de’ Pittori p. 30, part. 3, q. 2).
209. Dalle medaglie apparisce che su gli archi che trovavansi nei grandi ingressi v’erano delle quadrighe. Il Guattani (loc. cit. Tom. II, p. 5), invece scrive: «Nella parte settentrionale verso l’Esquilino, fra gli archi corrispondenti al mezzo dell’ovale, ve n’è uno che non ha numero fra il XXXV e il XXXVIII (?). Ivi da un capitello all’altro delle colonne, manca tutto il cornicione sino al piano del portico superiore. Tal mancanza indica a maraviglia l’attacco di un ponte che dava il passaggio all’Imperatore dal suo palazzo e terme sull’Esquilie all’Anfiteatro». A p. 16 (nota) il Guattani principia a dubitare di questa sua asserzione, e scrive: «Questa quadriga non si vede affatto (?) in nessuna medaglia a mia notizia; bensì impresso in tutte, e chiarissimamente visibile in quella di Gordiano, sta l’attacco del ponte, seppure, in vece di ponte non fosse un vestibolo dell’Anfiteatro». È evidente che al Guattani non eran note le medaglie di Domiziano, ecc.
210. Loc. cit. pag. 424.
211. Opusc. De Amphith.
212. Roma alla fine del mondo antico, p. 174.
213. Roma ant. Tom. I, p. 425.
214. Domitianus Imp.... Amphitheatrum usque ad clypea.
215. Tac., Ann. 2, 83; Suet., Calig. 16; Dom. 23. — Trebell., Claud. Goth. 3; Liv., 25, 39; 35, 10; c. I, l. XIV, 2794.
216. C. I, l. XI, 6481 — c. I, l. XIV, 2410.
217. C. I, l. V, 1829 — c. I, l. IX, 5177 — Ib., XIV, 2215.
218. V. P. Grisar, Roma alla fine del mondo antico, p. 174, Roma 1908.
219. Loc. cit., p. 222.
220. Nella descrizione che faremo dell’interno dell’Anfiteatro, vedremo che cosa fosse il velario, e come fosse disposto.
221. Loc. cit., pag. 425.
222. Almeno in gran parte.
223. Memorie storiche del Colosseo, p. 124, Roma 1875.
224. L. I.
225. Agro Romano, p. 162.
226. Vestigia e rarità di Roma, p. 39.
227. Arch. l. II, c. VIII.
228. Altre opinioni sull’origine di questi buchi, non credo necessario riportarle perchè del tutto inammissibili.
229. Cassiod., Variar. l. III, 31.
230. Rom. istit., l. III, c. V, p. 261.
231. Antiq. Rom., l. III, c. XII.
232. Roma ricerc. nel suo sito.
233. Loc. cit., p. 412.
234. Ap. Winckelmann, p. 496 e sgg.
235. Cicerone, in Ant. Philip. 9 ed in Pison. c. 38, n. 93; Paolo, l. Si statua, 27, ff. De iniur.; Ulpiano, l. Si sepulchrum, 2, ff. De sepulcri viol.
236. Scevola, l. Cuiusque 4 § Hoc crimen, ff. ad leg. Jul. Maiest.; Masciano, l. Non contrahit, 5; Venuleio, l. Qui statuas, 6.
237. Ulpiano, l. Raetor. ait. 3 ff. De sep. viol.; Paolo, l. ult. cod.
238. V. il Kirchmann, De funer. Rom. lib. 3, c. 14.
239. Scevola, l. Medico 40. Cf. Mulier 2, ff. De auro, arg. etc.
240. L. XXVII, c. III.
241. Prefetto di Roma nell’anno 367.
242. L. XV, tit. I, leg. 37.
243. S. Girolamo, Epist. 1-7, ad Principiam virg. op. Tom. I, col. 954, n. 13.
244. Cassiod., l. II, epist. 7.
245. Dico deputare e non creare, perchè pare dalla formola che già vi fosse prima. La formola d’investitura, che a tal uopo fu spedita a quel magistrato, ce l’ha conservata Cassiodoro, lib. 7, form. 13.
246. Come pure nell’anfiteatro di Verona, in quello di Pola, Nîmes, etc.
247. Loc. cit., l. II, p. 195.
248. I perni di solo ferro, come è noto, non sono di lunga durata, ma presa questa precauzione, rivestendoli cioè di piombo, questo li preserva dalla ruggine, e così dànno un ottimo risultato. Prima di mettere una pietra sopra l’altra, lasciavano abilmente nella pietra di sotto un piccolo canale, per potervi infondere il piombo e saldare il perno.
249. Ap. Winckelmann, Tom. XI, p. 494. Prato MDCCCXXXII
250. V. A. Musato, De gest. Henr. VII Imp. l. 8, rubr. 4, col. 455; la vita di Cola di Rienzo l. II, c. XIV. Presso il Murat., Ant. med. aevi, Tom. II, col. 1867; l’Infessura dell’anno 1404; presso l’Eccardo, Tom. II, col. 1867; e presso il suddetto Murat., Tom. III, part. 2, col. 1116.
251. Vedi Tav. II.
252. Gori, loc. cit., p. 125
253. Cf. Parte III, c. V.
254. Prima che l’arena venisse trasformata, l’ipogeo, come in breve vedremo, riceveva luce in altro modo.
255. Cf. Lips., De Amph., c. III.
256. Plinio, H. N. l. XXXVI: Invenere et alium usum (SPECULARIS LAPIDIS) in ramentis quoque Circum Maximum ludis circensibus sternendi, ut sit in commendatione candor.
257. Suet., in Calig. XVIII: Edidit et circenses.... et quosdam praecipuos, minio et chrysocolla constrato circo. Plinio (Hist. Nat. l. XXXIII) scrive: Visumque iam est Neronis principis spectaculis arenam Circi chrysocolla sterni, cum ipse concolori panno aurigaturus esset. È noto che per chrysocolla intendevasi la borrace, quel nitro fossile cioè che proveniva dall’Armenia, dalla Macedonia e da Cipro.
258. Lamprid., in Heliog.: Scobe auri porticum stravit et argenti, dolens quod non posset et electri. L’electrum non era se non quella qualità di oro naturale che conteneva una quinta parte d’argento. Omni auro, dice Plinio (Hist. Nat., l. XXXIII, c. IV) inest argentum vario pondere.... Ubicumque quinta argenti portio est, ELECTRUM vocatur. Lo stesso Plinio (loc. cit.) ci assicura che l’electrum si componeva anche artificialmente, facendo che il composto contenesse i due metalli in quella stessa proporzione in cui trovavansi nell’elettro naturale.
259. Lamprid., ib.
260. Epig. l. II, ep. LXXV.
261. V. Tav. I, lett. A-Y.
262. Lamprid., in Comm. 16; Dio., cap. XXI.
263. Queste si regalavano quasi intieramente ai bestiarî, i quali, dopo averle trasportate al Castrense, si dividevano fra loro le carni mangiabili, le pelli di lor pertinenza (quelle cioè di minor conto), e le ossa, delle quali, fattele seccare nei sotterranei dell’edificio, ne facevano traffico. Negli scavi ivi eseguiti nella prima metà del secolo XVIII (V. Ficoroni, Le Vestigia di Roma antica, p. 121) se ne trovarono una gran quantità.
264. Parte III, c. V.
265. Vedi Tavola IV.
266. Nel giornale «L’Osservatore Romano» (11 Settembre 1909) leggo: «Gli Antichi Ascensori Romani. Neppure l’ascensore, entrato da non molto tempo negli usi della vita moderna, è una novità. Fin dai tempi di Giulio Cesare i Romani avevano costruito dei solidi e forti elevatori verticali per uso degli spettacoli. Questa scoperta dovuta al prof. Boni, direttore degli scavi del Foro, è importantissima. Dodici erano gli ascensori in azione nell’ultimo periodo della Repubblica. Essi servivano per elevare dai sotterranei alla superficie del foro i gladiatori e le belve. Una galleria longitudinale sotterranea moveva dai rostri di Cesare in direzione del tempio dedicato a questo dittatore, e aveva nel suo percorso (come anche oggi è dato vedere) quattro minori gallerie traversali, in ciascuna delle quali erano tre camere per gli argani e altrettante camerette di comando per la manovra degli ascensori. In ciascuna delle dodici camere si vedono i dadi di travertino su cui erano infitte le aste, e dal logoramento della buca circolare si conosce la direzione del tiro di ogni argano. Si calcola che sopra ogni elevatore potessero stare comodamente cinque o sei persone, in modo che, essendo dodici gli elevatori, oltre settanta persone venivano innalzate in un tempo solo alla superficie del Foro. Di quanto si conosce», prosegue l’«Osservatore Romano», «l’invenzione dei Romani della Repubblica non ebbe seguito sotto l’Impero (?).... I primi tentativi dei Romani contemporanei di Cesare rimasero sepolti per venti secoli nel sottosuolo del Foro, e per singolare coincidenza vengono in luce oggi che l’ascensore è alla sua più perfetta applicazione». Così La Casa. Ci rallegriamo di cuore coll’illustre direttore degli scavi del Foro, ma facciamo osservare al ch.º scrittore dell’articolo, che gli elevatori s’usarono costantemente negli anfiteatri per elevare dagli ipogei dell’arena belve, gladiatori e quant’altro era opportuno a render variato lo spettacolo. Non è esatto perciò asserire che quest’invenzione, sotto l’Impero non ebbe seguito. Oltre all’attestarci questo fatto gli antichi scrittori, ne rimangono tuttora chiarissime tracce nell’Anfiteatro Flavio e negli anfiteatri di Capua, Pozzuoli e Siracusa.
267. Petronio, Satyr. c. IX. Calpurnio, Eclog. VII, c. 69.
268.
DD NN VALENTINIANO ET VALENTE SEMPER AV
LOLCYRIVS PRINC CVR ET ERITOR DVODENA DE PROPRIO / V /
VETVSTATEM CONLAPSVM AT STATUM PRISTINUM RED ////
AMPHITHEATRVM CVM PORTIS POSTICIIS ET HOMNEM FABR ////
ARENE NEPVS LOLCYRI PRINC CVR ET ANTE ERETORIS FILIVS
CLAVDI PRIC ET PATRONI CURIAE PRONEPOS MESSIGOR
PRINC FELICITER
L’epigrafe da noi riportata trovasi nel Museo comunale di Velletri mia città natale. Fu già trascritta dal Fabbretti, dal Fea, ecc., ma poco correttamente. Con più diligenza fu ripubblicata dal Mommsen, e trovasi inserita nel vol. X, 6565, del Corpus. Io l’ho copiata sull’originale, e la presento senza correzioni e supplementi.
Nel vestibolo dell’Anfiteatro Flavio (Ingresso Ovest) vi sono i frammenti della seguente iscrizione:
Nel capitolo V, Parte I, di questo lavoro riporteremo l’illustrazione di quest’epigrafe, ed il supplemento che generalmente ne dánno gli archeologi.
Io leggerei le ultime due linee così:
HA(re)NAM AMPHITEATRI A NOVO UNA CUM PO(rtis, instauratis)
P[ost]ICIS SED ET REPARATIS SPECTACULI GRADIBUS (restituit).
Quell’arenam a novo restituit non può intendersi della sostruzione dell’arena, perchè ancora vi vediamo tracce delle primitive, restauri dell’epoca di Eliogabalo e Severo Alessandro, ed alcune riparazioni dei secoli posteriori. Opino quindi che quell’arenam a novo si riferisca al pavimento ligneo con gli sportelli dei postica, ai quali postica furono fatte delle riparazioni: sarebbe insomma una seconda edizione dell’epigrafe Veliterna: Amphitheatrum ad statum pristinum cum portis posticiis et omnem fabr(icam) arene (sic).... I pavimenti di legno erano infatti quelli che più d’ogni altra cosa doveano andare in deperimento.
Nella riparazione poi fatta spectaculis gradibus potrebbe esser compreso il rinnovamento del parapetto a transenna del podio, abbattuto forse dalla caduta di statue o d’altro, e fatto precipitare giù per la cavea dal terremoto del 422. Dico il solo parapetto, perchè non è ammissibile che il terremoto avesse fatto cadere il muro di fronte del podio: muro situato nella parte infima dell’Anfiteatro, non più alto di metri 3,50, di forma curvilinea concava, dello spessore di un metro circa, collegato col muro interno per mezzo di un soffitto sostenuto da robuste travi; e credo che nessuno possa coscenziosamente applicare al muro del podio che fronteggia l’arena la frase A NOVO dell’epigrafe di R. Cecina Felice Lampadio. Le altre osservazioni su di questa lapide le faremo al capo quinto, Parte I, di questo lavoro.
269. Flavii Vopisci Siracus. in Probo. Vitae Caes. Basileae MDXLVI, p. 303. Additit alia die in amphitheatro una missione centum iubatos leones, qui rugitibus suis tonitrua excitabant: qui omnes contificiis interempti sunt, non magnum praebentes spectaculum cum occidebantur. Neque enim erat bestiarum impetus ille, qui esse ab eis egredientibus solet. Occisi sunt praeterea multi, qui diripere volebant, sagittis. Editi deinde centum leopardi Libyci, centum deinde Syriaci, centum laenae, et ursi simul trecenti: quarum omnium ferarum magnum magis constat spectaculum fuisse quam gratum.
La maggioranza dei dotti del rinascimento, come Erasmo, Egnazio, Casaubono, ecc. lessero contificiis e contifigiis. Salmasio fu l’unico che, appoggiandosi al manoscritto Palatino, lesse e posticis. La grave autorità di quegli scrittori imporrebbe la loro lezione, ed in tal caso il passo di Vopisco non avrebbe influenza sulla nostra questione. Se poi si volesse ammettere la variante del Salmasio, allora il passo favorirebbe la mia opinione, perchè confermerebbe che nella decadenza dell’Impero le cellette dalle quali si facevano sbucare le fiere sull’arena, si dicevano postica: omnis e posticis interempti sunt.... Neque enim erat bestiarum impetus ille qui esse AB EIS egredientibus solet; vale a dire: qui esse solet bestiis egredientibus ab eis posticis. L’uccisione di cento leoni, in tale ipotesi, si sarebbe voluta effettuare per mezzo di uomini nascosti nelle cellette, i quali, con venaboli o lance spinte fuori per una fessura lasciata fra i due sportelli, dovevano trafiggere le fiere allorchè passavano incautamente sulla postica. Ed invero, quelle povere bestie non avrebbero trovato scampo, giacchè si aggiravano in un campo irto di settantadue lance, quante cioè erano le cellette nell’ipogeo dell’Anfiteatro Flavio. Questo spiegherebbe come molti dei leoni fossero stati uccisi con le saette, perchè per uscir fuori da quel terribile agguato tentarono di aprirsi un varco, forse nelle reti che difendevano il podio. Il Maffei (loc. cit. pag. 244) sul citato testo di Vopisco osserva quanto segue: «La falsa prevenzione intorno alla struttura degli anfiteatri, fece che il Salmasio sopra Vopisco disse significarsi con questa voce le porte da cui da’ lor sotterranei uscivan nell’arena le bestie, e pretese di emendar un oscuro passo dell’autor suo riponendovi tal voce nell’istesso senso. Della medesima opinione fu il Valesio sopra Ammiano.... per Postice non altro si può intendere, se non le porte delle lor gabbie, quali alcuna volta riusciva alle bestie di rompere. Forse si dicean Postice per usarsi di farle non nella fronte ma nella parte posteriore». Ma la lapide Veliterna getta giù di un tratto l’opinione del Maffei, il quale si vide nella necessità di ricorrere ad altro, e scrisse: AMPHITHEATRVM CVM PORTIS POSTICIIS etc. Par (!) si parli di restaurazioni; e se il marmo dice veramente Amphitheatrum, le porte posticae non possono qui intendersi di quelle delle gabbie». E conchiude: «la voce posticcio in lingua volgare esprime ciò che non è fisso.... e viene indubitamente da posticus, che avrà però avuto anche tal significato in latino. Credibil da ciò si rende, che così si chiamassero nell’anfiteatro le porte che tenean serrati gli archi esteriori d’ingresso, le quali.... non eran fisse, ma si levavano i giorni di spettacolo, onde venivano ad esser posticcie (!). Queste adunque può credersi fosser rifatte da colui di cui parla la lapide». L’opinione del Maffei non ci soddisfa affatto. Ciò che si è detto nel Testo e nelle Note, e ciò che siam per dire ci sembra che sia per annullare qualsiasi altra congettura.
270. Pers. 3, 3, 30.
271. O cessi.
272. Sat. lib. VIII.
273. Lanciani, loc. cit., p. 222. «Non s’intende che cosa abbiano a fare col Colosseo (le portae posticae), cioè con un monumento il quale non aveva nè fronte nè schiena, ma che invece era uniforme in tutto il perimetro, e contava 80 archi d’ingresso.... Le portae posticae si possono immaginare facilmente in quegli anfiteatri i quali stanno sul limite estremo di una città, come il pompeiano; ovvero a metà incassati sotterra, come il tuscolano; ovvero in quelli che, come il tuscolano ed il pompeiano avevano o uno o due o quattro soli ingressi. Le sigle dell’iscrizione romana (che parla dei restauri fatti da R. Cecina Felice Lampadio) si prestano del resto, ad altri supplementi come sarebbe, per esempio PublICIS etc.». Il parere del ch.º Huelsen lo riporteremo al c. V, parte I.
274. Seneca, Epist. 61.
275. V. la Tavola IV fuori testo.
276. Epig. LXXI, l. I.
277. Dio., in Adr.
278. Le varie opinioni degli archeologi sull’epoca di queste costruzioni le esporremo alla parte III, c. V.
279. Cf. Supplemento all’opera del Desgodetz, Part. I, c. XXI. — L’Anfiteatro Flavio, p. 60. — Tav. VI.
280. Similmente a piano inclinato.
281. L. LXXII, c. IV.
282. V. Tav. II fuori testo.
283. I gradi dovean essere talmente larghi da potervisi assidere una persona, e posarvi i piedi l’altro che sedeva nel grado superiore. La misura prescritta da Vitruvio soddisfa pienamente allo scopo. Egli vuole che i «gradus ne minus alti sint palmopede ne plus pede et digitis sex: latitudines eorum ne plus pedes duo semis ne minus pedes duo constituantur». In misura metrica equivarrebbe, poco più poco meno, a dire: i gradi siano non meno alti di m. 0,37, nè più di m. 0,41; e larghi non più di m. 0,75, nè meno di m. 0,60. Le misure dei gradi dell’Anfiteatro Flavio, prese su quei pochi residui che sfuggirono alla devastazione, sono le seguenti: altezza m. 0,40 — larghezza 0,72.
284. Nel podio vi dovette essere l’ordo subselliorum per i Senatori, giusta la legge di Augusto (Suet., in Aug. XLIV); e vi fu anche una gradinata, giacchè Suetonio dice che Domiziano quingenas tesseras in singulos cuneos equestres et SENATORII ORDINIS pronunciavit (Suet., in Dom. IV).
285. Roma ant., p. I, pag. 427.
286. Suet., in Aug., XLV.
287. V. Tav. I, lett. V-X.
288. Loc. cit. pag. 423-424.
289. V. Tav. 21-22, fig. 2, del «Bull. Comm.» ann. VIII, serie 2. 1880.
290. Suet., in Aug. XLIV — Facto igitur decreto patrum ut quoties quid spectandi usquam publice ederetur primus subselliorum ordo vacant senatoribus.
291. Alle Vestali non era lecito di assistere a tutti i giuochi. Esse entrarono manifestamente nel divieto imposto alle donne di assistere ai giuochi atletici. Le parole che Suetonio fa immediatamente seguire al racconto della disposizione data da Augusto circa il posto che doveano occupare le donne nell’assistere ai ludi, ed il luogo speciale concesso alle Vestali, non lasciano dubbio di sorta. «Athletarum vero spectaculo (dice) muliebrem sexum OMNEM adeo summovit.... edixeritque mulieres ante horam quintam venire in theatrum non placere». Suetonio (come bene osserva il ch. Lanciani) ricorda come una singolarità di Nerone l’aver egli invitate ad athletarum spectaculum et virgines vestales, quia Olympiae quoque Cereris sacerdotibus spectare conceditur (cap. XII).
292. Cic., pro Mur. 35, 73.
293. Prud., Contr. Symm. II, v. 1109.
294. Hübner, Ann. delle Ist. p. 59.
295. Più tardi, come vedremo, anche l’Imperatrice fu esclusa dal pulvinare.
296. Suet., in Tito, IX.
297. Suet., in Domit. IV.
298. Id. in Aug. XLIV.
299. Questo decreto fu emanato nell’anno 776 d. R.
300. Tacit., Annal. IV, 16.
301. Tra breve procurerò dimostrare che la legge Augustea non colpì soltanto le plebee, ecc.; ma tutte indistintamente le donne.
302. «Il rito fu ordinato nei primi anni di Roma con quattro sole sacerdotesse. Tarquinio Prisco (v. Dionisio, III, 67) o Servio Tullio (Plut. 10) accrebbero il numero delle Vestali fino a sei, e questa cifra si mantenne costante fino al secolo IV dell’era volgare. Nell’ultimo periodo del paganesimo si ha notizia di sette Vestali (Cf. Ambrosii, epp. ed. Parei p. 477; Müller, Geog. gr. min. II, 525); ma è incerto quando e perchè sia stata in tal guisa cambiata la consuetudine antica del numero senario». Lanciani, Notizie degli Scavi, C. I, Delle Vergini Vestali, pag. 436.
303. Böetius, De consolatione philosophiae, lib. II, prosa III.
304. Plinio, Hist. Nat. XXXVII, c. III, 43 — «DC. fere M. passuum a Carnunto Pannoniae abest littus Germaniae ex quo invehitur (succinum) percognitum nuper. Vidit enim eques Romanus missus ad id comparandum a Juliano curante gladiatorium munus Neronis principis, qui haec commercia et littora peragravit, tanta copia invecta, ut retia arcendis feris podium protegentia succinis nodarentur» — (per ornamento).
305. Calpurn., Eclog. VII.
«...... Nec non ubi finis arenae
Proscina marmoreo peragit spectacula muro
Sternitur adiunctis ebur admirabile truncis,
Et coit in rutulum, texti qua lubricus axe
Impositos subita vertigine falleret ungues,
Excuteretque feras. Auro quoque torta refulgent
Retia quae totis in arenam dentibus extant,
Dentibus aequatis, et erat (mihi crede Lycota,
Si qua fides) nostro dans longior omnis aratro».
306. Tom. I, pag. 4.
307. Varr., De L. L. 4, 24. Quod cingulum e corio habebant bullatum balteum dictum.
308. Tert., (De Spect. 3) chiamò cardines balteorum i vomitorî aperti nelle praecinctiones.
309. La numerazione delle tabulationes doveva seguire quella delle arcate terrene.
310. Lib. XLIV.
311. Dio., l. XLIX.
312. Ann. l. XVI, c. 12.
313. V. p. 33.
314. Suet., in Augusto.
315. V. XLII.
316. De arch., l. V, c. IX.
317. Calpurnio, loc. cit.
318. «Bull. della Commissione Archeol. Com. di Roma» 1880, p. 236 e sgg. Anno VIII, serie seconda. Tutti i frammenti epigrafici rinvenuti nei diversi scavi fatti nell’Anfiteatro Flavio sono stati più recentemente (anno 1902) pubblicati e con molta cura dall’Huelsen, Inscriptiones Urbis Romae Latinae. Partis quartae, fasciculus posterior. — Additamenta, pp. 3199 e sgg. Berolini, apud Georgium Reimerum, MCMII. — Noi li riporteremo alla II Appendice. E questo volume del Corpus è quello che citiamo in quest’opera.
319. Tacito, Ann. 13, 54.
320. Ap. Henzen, Arv. p. CVI.
321. Ann. Inst. 1856, p. 62.
322. Ioseph., Iud. 7, 7.
323. Henzen, Arv. CVI, 8.
324. Diplomi 153.
325. Oeuvres, 3, 69.
326. Oct. 44.
327. Lo Hübner nega che il senatusconsulto di Augusto si riferisca ad ogni genere di spettacoli, perchè in quello si nomina fra le altre cose il cuneus praetextatorum, che è divisione non ammissibile nel circo privo di cunei. «Questo fatto» egli dice «può servire per nuova prova, i regolamenti di Augusto non essere stati generali per tutti e tre i generi di spettacoli». Ora se Augusto giudicò utile, opportuno, morale dividere i pretestati dalla restante folla nel teatro, identiche considerazioni di moralità, di opportunità, di convenienza avranno fatto adottare uguale misura pel circo. Sarebbe stato puerile rinunciarvi per la sola ragione che nel circo non c’era divisione per cunei.
328. Suet., Octav. 44.
329. Val. Max., 2, 4, 3.
330. Röm. Alterth. 2 l., 282.
331. 33, 44.
332. 55, 22, 4.
333. Suet., Claud. 21.
334. Dio., 60, 3 e Jordan, Forma p. 18.
335. 1, 9.
336. 4, 35, p. 151 Hild.
337. C. I, l. p. 860 n. 78.
338. Domit. 4, cf. Dione, 66, 25.
339. Cf. Livio, 2, 31; Festo, p. 344 Muell.
340. Cf. l’elogio di Manio Valerio Massimo dittatore ap. c. I, l. I, p. 284.
341. Phil., 9, 7, 16, cf. Marquardt, Staatsw., 3, 471.
342. Ad Att. 2, 1, 4.
343. Suet., oct. 35, Giovenal., 2, 178.
344. Id. Caes. 76. Claud. 25, 76. Nero 12; Joseph, Jud. 19, 13.
345. Plin., H. N. 37, 3, 11, 2; Gioven., 2, 144.
346. Cf. il parvis foraminibus spectare, Suet., Nero 12.
347. Loc. cit. p. 63.
348. Cf. Ritschl, Parerga, v. I, p. 227.
349. Cic., pro Mur. 19.
350. Liv., Epist. XCIX.
351. Plut., Cic. 13; Plinio, H. N. 7, 31.
352. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 3, 97.
353. Plut., C. Gracch. 12, 3.
354. Cic., Phil. 2, 18; Giovenal., 3, 153; Orazio, Epod. 4, 16.
355. Cf. Suet., Oct. 40.
356. Id. ibid. 14.
357. H. N. 8, 21.
358. Loc. cit.
359. Forma p. 18.
360. Cf. Marziale, 6, 8.
361. Domit. 4.
362. Dei XIV ordini.
363. Cf. Tac. Ann. 2, 82.
364. Cf. Ovidio, Fasti 4, 381.
365. Cf. Hübner l. c. p. 56 a.
366. Id. l. c. p. 56, 2.
367. Hübner l. c. p. 68, n. 8.
368. Cf. cap. I, pag. 33. Solamente farò qui notare collo stesso ch. Lanciani «che tutti i posti accennati nell’iscrizione arvalica spettavano ai ministri inferiori del collegio, e non agli arvali stessi, ai quali, siccome al più bel fiore della nobiltà (Marini, 153), competeva il posto senatorio».
369. Cf. pag. 65 di questo capitolo.
370. Domit. 4.
371. Ann. 2, 83-4, 9.
372. C. I. L. VI. 912.
373. Dom. 4.
374. Suet. Nero, 20; C. I, Gr. 5898; Ignarra, De palestr. neap. 23.
375. Gori, Colosseo p. 131.
376. Il Lanciani scriveva queste parole nel 1880.
377. C. I. L. VI, 1682; De Rossi, Piante 53.
378. Suet. Octav. 44.
379. Suet. Claud. 25.
380. Tacito, Ann. 13, 54.
381. Dione, fragm. 68, 15.
382. Cf. Justin. 43, 5, 10.
383. Suet. Octav. 43.
384. Cf. pag. 70 di questo lavoro.
385. Ann. 16, 12.
386. Hübner, loc. cit. 61.
387. Jordan, Forma 19.
388. Suet. Octav. 44.
389. Cf. Scamna maritorum di Marziale 5, 41.
390. Sat. 11, 202.
391. Plut. Silla 24.
392. De har. resp. 12, 24.
393. Amores l. 3, el. 2, v. 40; De art. am. 1, 135 sg.
394. Am. 2, 7, 3 sg.
395. Paris 1900, pag. 15.
396. I quali, come dicemmo, guardavano gli spettacoli dall’alto del portico.
397. Sui gradini del meniano primo.
398. V. Bull. di Arch. Com. Anno XXII, p. 312-324.
399. Cf. Tav. I.
400. Cf. Introd., p. 12.
401. Hist. Nat., l. XIX, c. I.
402. Lib. IV, v. 73.
403. Loc. cit.
404. Loc. cit.
405. Loc. cit.
406. Romanelli, Viaggio a Pompei, ecc. Napoli 1811, p. 47. (Cf. le epigr. da me riportate nell’Introd., p. 14).
407. Calp., loc. cit.
408. In Comm.
409. Di Traiano. Ann. dell’Istit. 1862, p. 64.
410. 5, 2, 47.
411. Questo fatto fu inventato da Plauto, ma verisimile; nè può dirsi cosa che non potè accadere, o che non fosse mai accaduta.
412. Cosa peraltro non necessaria ad un nocchiero, cui (posti i quattro punti cardinali) bastava vedere l’indice fermato in uno qualsiasi dei lati della faccia dodecagogana superiore dell’anemoscopio, per sapere quale dei dodici venti soffiasse; e neppure gli era necessaria per raggiungere lo scopo suddetto, giacchè bastava che egli conoscesse la direzione del vento (qualunque esso si fosse) per dare gli ordini opportuni.
413. Vitruv. De arch. lib. I, cap. VI, 55. Tum per angulos inter duas ventorum regiones, et platearum et angiportorum videntur debere dirigi descriptiones. His enim rationibus et ea divisione exclusa erit ex habitationibus et vicis ventorum vis molesta. Cum enim plateae contra directos ventos erunt conformatae, ex aperto coeli spatio impetus ac flatus frequens conclusus in faucibus angiportorum vehementioribus viribus pervagabitur.
414. Loc. cit., Tom. II, p. 7.
415. Cfr. Lanciani, loc. cit., p. 274.
416. Loc. cit., p. 400.
417. V. Aringhi, Rom. Sott. Tom. IV, p. 1878, n. 4. — Marangoni, Memorie storiche dell’Anf. Flavio, p. 27. — Venuti, ecc.
418. Bellori, Vestigia Vet. Rom. Tav. XXVIII.
419. Loc. cit.
420. Loc. cit., p. 11.
421. Loc. cit., p. 25.
422. Epig. già citato.
423. Loc. cit.
424. Loc. cit., p. 28.
425. Euseb., Hist. Eccl., l. 3, c. 15.
426. Bar., Ad Ann., 74.
427. Dio., l. 67.
428. Marini, Apud Mai, Script. vet. nov. coll. Tom. V, p. 380.
429. Vol. I, pars prior, p. 418.
430. Elém. d’archéol. chrétienne, vol. I, p. 20. Cf. Delehaye, L’amphithéâtre Flavien, etc. ap. Analecta Bollandiana, t. XVI, 1897, p. 216.
431. Parte IV, Questione 4.
432. Loc. cit.
433. In Domit., c. IV.
434. Suet. in Dom. c. V.
435. Suet., loc. cit.; Mart. De spect. ep. IV, XXII.
436. Suet. in Domit. 4. «Spectacula assidue magnifica et sumptuosa edidit non in Amphitheatro modo, verum et in circo; ubi praeter solemnes bigarum quadrigarumque cursus praelium etiam duplex, equestre ac pedestre commisit; at in Amphitheatro navali quoque. Nam venationes gladiatoresque et noctibus ad lychnuchos; nec virorum modo pugnas sed et feminarum..... Ac per omne gladiatorum spectaculum ante pedes eius stabat puerulus coccinatus portentoso parvoque capite, cum quo plurimum fabulabatur, nonnumquam serio.... Edidit navales pugnas paene iustarum classium, effosso et circumstructo iuxta Tiberim lacu, atque inter maximos imbres perspectavit».
437. Cf. Visconti C. Ludovico. Il sepolcro del fanciullo Q. Sulpicio Massimo. — G. Henzen, Sepolcri antichi rinvenuti alla Porta Salaria. «Bull. dell’Ist.» 1871, p. 98. — L. Ciofi, Inscript. Lat. et Graec. cum carmine graeco extemporali Q. Sulpicii Maximi, Roma 1871. — E. Parker, Tombs in and near Rome, Oxford, 1877, p. X. — Lanciani, Pagan and Christian Rome.
438. Suet. ibid., 10. — «Patrem familias, quod Threcem Myrmilloni parem munerario imparem dixerat, detractum spectaculis in arenam, canibus obiecit, cum hoc titulo: Impie locutus parmularius».
439. Se pure fu egli che lo scrisse.
440. Suet., loc. cit.
441. Suet., in Dom. 19: «Armorum nullo, sagittarum vel praecipuo studio tenebatur. Centenas varii generis feras saepe in Albano secessu conficientem spectavere plerique; atque etiam ex industria ita quarumdam capita figentem ut duobus ictibus quasi cornua efficeret. Nonnumquam in pueri procul stantis, praebentisque pro scopo dispensam dextrae manus palmam, sagittas tanta arte direxit, ut omnes per intervalla digitorum innocue evaderent».
442. Iov., Sat. IV, V. 99, et segg. — Secondo Dione (l. LVII, 14) Acilio trafiggeva i leoni.
443. Mart., l. VIII, ep. LIII.
444. Mart., l. VIII, ep. VI.
445. Epig. VII.
446. Epig. VIII.
447. Epig. IX.
448. Ibid., ep. X.
449. Ibid., ep. XIV, XXII et XXV.
450. Ibid., ep. XV.
451. Ibid., ep. XVI.
452. Ibid., ep. XVIII.
453. Ibid., ep. XX.
454. Ibid., l. v., ep. XXXII.
455. Plinio, Paneg. 33, 34; Dio., 68, 10.
456. Dissert. della Pont. Acc. d’Archeol. Tom. XI, p. 80.
457. Dio., l. LXVIII, 15.
458. Loc. cit. p. 25.
459. Pausania, Descriz. della Grecia, lib. V, c. XII: καὶ θέατρον μέγα κυκλοτερὲς παυτακόθευ.
460. Spart., Script. Hist. Aug. Edit. Iord. Berolini 1864, in Hadriano, 9: in Campo Martio posuerat, contra omnium vota destruxit.
461. Loc. cit. p. 217.
462. Salvo in qualche caso eccezionale, come ad es. mentre l’Anfiteatro veniva restaurato per danni subiti e causati da incendi, fulmini, terremoti, ecc.
463. Spart., in Hadr. VII et XIX; Dio., l. LXIX, 8.
464. Spart., ibid. XVIII.
465. περιστεφ., 10, 696.
466. Hyaena crocuta, è la iena macchiata dei naturalisti, più piccola della hyena striata.
467. Sorta di gazzelle avente le corna in forma di lira.
468. In Anton. Pio c. X,
469. A. d. C. 170.
470. In Marco Aur. l. XVII.
471. Ibid., c. XIX.
472. Lamprid. in Comm. XV. Spectator gladiatoria sumpsit arma: panno purpureo nudos humeros advelans.... Sane cum illi saepe pugnanti, ut Deo, populus favisset, irrisum se credens, populum romanum a militibus classiariis, qui vela ducebant, in amphitheatro interimi praeceperat. Urbem incendi iusserat utpote coloniam suam: quod factum esset nisi Laetus praefectus praetorio Commodum deteruisset. Appellatus est sane, inter cetera triumphalia nomina, etiam sexcenties vices Palus primus Secutorum.
473. Lamprid. in Comm. XVI: De palatio ipse ad Coelium montem in Vectilianas aedes migravit, negans se in palatio posse dormire..... Ipse autem prodigium non leve sibi fecit: nam cum in gladiatoris occisi vulnus manus misisset, ad caput sibi detersit: et contra consuetudinem penulatos iussit spectatores, non togatos, ad munus convenire, quod funebribus solebat: ipse in pullis vestimentis praesidens. Galea eius bis per portam Libitinensem elata est.
474. Hist., l. I, c. VIII. Ed. Bekker Lips. 1855, p. 15. — Dione Cassio (l. LXXII c. IV, delle storie romane compendiate da G. Sifilino) dice, che il congiurato chiamavasi Claudio Pompeiano.
475. Cap. XVII e segg.
476. Sotto il nome di diametro vogliono indicarsi linee, o piuttosto i corridoi diagonali coperti ed accessibili: il che in questo luogo significa la parola PERIDROMO, formata da INTORNO e da CORSO, e mal intesa talvolta dagli architetti. Bossi.
477. Cioè s’incrocicchiavano ad angolo retto, tagliando in quattro parti l’anfiteatro a modo di croce. Gori.
478. Il Bulanger stima che questa somma equivalga a 3000 zecchini incirca.
479. Dio., c. XXI. — Trad. del Bossi.
480. Iosephi Scutilli. De Colleg. Gladiat. seu in geminas inscriptiones gladiatorias nuperrime effossas commentarius. Romae 1756.
481. V. Muratori, Thes. Inscript. p. DXI, 3.
482. LXXVI, 1.
483. Traduzione dello stesso Bossi.
484. Il Bossi crede che questa bestia fosse una rarissima specie indiana di cignale.
485. Il Maffei (Verona illust. l. I, p. 35) scrive: «Credo doversi leggere quaranta in Sifilino, perchè segue che se n’uccisero in tutto cento al giorno, onde non quattrocento in un solo. Si rappresenta quella nave in una medaglia di Severo riferita dal Mezzabarba». In questa medaglia si legge: LAETITIA TEMPORVM.
486. Dio., l. LXXVII, 6.
487. Questo cavallo-tigre è a noi incognito.
488. Dio., l. LXXVII, 6.
489. De Columna Traiani, Romae 1683, c. 8, p. 258.
490. Monum. ined. Roma 1821, tom. II, p. IV, § 2, p. 260 e n. 199.
491. Bellori, Lucern. p. I, tav. 21.
492. Dio., lib. LXXVIII, 25.
493. Forse è un ippopotamo od un rinoceronte.
494. Donaldson, Arch. numismat. n. 79; Maffei, Tav. I, n. III; Cohen, Alex. Sev. IV, pag. 447, n. 468 Ediz. II. — Cf. pag. 38 di questo lavoro. Quelle medaglie sono state riprodotte dai calchi gentilmente inviatimi dal Sig. E. Babelon, Direttore del Gabinetto Numismatico della Biblioteca Nazionale di Parigi, cui porgo i miei più sinceri ringraziamenti.
495. L’iscrizione PONT . MAX . etc., prova che gli spettacoli si fecero effettivamente l’anno 223; quando, cioè, cadde la seconda potestà tribunizia, marcata in questa moneta.
496. V. Capit. in Gord.
497. Loc. cit.
498. In Gordiano, III, 38.
499. Secondo il Baronio sarebbe accaduto l’anno 249 di Cristo. — Il Nibby crede esser avvenuto il 248.
500. Ann.
501. Cap. XIX.
502. Vop., in Aurelian. XXXIII.
503. Vop., loc. cit.
504. Calpurnio, Eclog. VII (Poetae Latini Minores. — Ed. Wernsdorf, tom. 2, p. 166, V. 33 et seqq).
«Vidimus in coelum trabibus spectacula textis
Surgere, Tarpejum prope despectantia culmen,
Immensosque gradus et clivos lene jacentes
Venimus ad sedes ubi pulla sordida veste
Inter femineas spectabat turba cathedras.
Nam quaecumque patent sub aperto libera coelo
Aut eques aut nivei loca densavere tribuni.
Qualiter haec patulum contendit vallis in orbem
Et situata latus resupinis undique sylvis
Inter continuos curvatur concava montes:
Sic tibi planitiem curvae sinus ambit arenae.
Et gemmis medium se molibus alligat ovum.
Quid tibi nuc referam, quae vix suffecimus ipsi
Per partes spectare suas? sic undique fulgor
Percussit. Stabam defixus et ore patenti,
Cunctaque mirabar, nec dum bona singula noram.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balteus ex gemmis, en illita porticus auro
Certatim radiant. Nec non ubi finis arenae
Proxima marmoreo peragit spectacula muro,
Sternitur adjunctis ebur admirabile truncis,
Et coit in rotundum, tereti qua lubricus axe.
Impositos subita vertigine falleret ungues,
Excuteretque feras. Auro quoque torta refulgent
Retis quae totis in arenam dentibus extant,
Dentibus aequatis, et erat (mihi crede, Lycota,
Si qua fides) nostro dens longior omnis aratro.
Ordine quid referam? vidi genus omne ferarum
Hic niveos lepores et non sine cornibus apros,
Manticorum, sylvis etiam quibus editur alcen
Vidimus, et tauros quibus aut cervice levata
Deformis scapulis torus eminet, aut quibus hirtae
Jactatur per colla jubae, quibus aspera mento
Barba jacet, tremulisque rigant palearia setis.
Non solum nobis sylvestria cernere monstra
Contigit: aequoreos ego cum certantibus ursis
Spectavi vitulos, et equorum nomine dignum
Sed deforme pecus quod in illo nascitur amni.
Qui sata riparum venientibus irrigat undis.
Ah! trepidi quoties nos descendentis arenae
Vidimus in partes, ruptaque voragine terrae
Emersisse feras: et eisdem saepe latebris
Aurea cum croceo creverunt arbuta libro».
505. Circa gli animali descritti da Calpurnio, è da notarsi quanto segue: I candidi lepri sono rari. Plinio (H. N. l. VIII, 55) riferisce che si erano visti sulle Alpi. Il medesimo scrive (l. VIII, 32) che i cinghiali cornuti trovansi nell’India. La Manticora o Mantichora fu descritta da Aristotele (Dell’Anima, l. II, c. 11), da Plinio (VIII, 21), da Eliano (IV, 21) e da Pausania (Boet. c. 21), il quale sostiene che era una specie di tigre, e che molte cose le quali narravansi di essa erano favolose. L’alce venne descritta da Cesare (Bell. Gall. VI, 27), da Plinio (VIII, 15) e da Pausania (loc. cit.). I tori multiformi sono i tori siriaci e carici, dei quali parla Plinio (VIII, 45), che descrive ancora (VIII, 15) i bisonti colle folte giubbe. I vitelli marini sono le foche (Plinio, IX, 13; Aelian. IX, 9 et 50). — Il cavallo marino è l’ippopotamo del Nilo (Plinio, VIII, 25; Solinus c. 31 et 36). Dal Gori, loc. cit. p. 52.
506. Ann. d’Italia, Tom. II, part. I, Roma 1786, p. 297.
507. De Rossi, B. A. C. 1867, pag. 86.
508. Cod. Theod. 15, 12, 1.
509. Istit. Divini. l. VI, c. 20.
510. Loc. cit. p. 220.
511. Gori, loc. cit. p. 74.
512. Cod. Theod. l. XV, t. XII, De Glad. l. I.
«Imperator Costantinus A. MAXIMO P. E. P. Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter, qui omnino gladiatores esse prohibemus, eos qui forte delictorum causa hanc condicionem adque sententiam mereri consueverant, metallo magis facis inservire, ut sine sanguine, suorum scelerum poenas agnoscant. P.P. Beryto, Kalend. Octobr. Paulino et Juliano Coss.»
513. Conf. c. 8. l. VI.
514. Nella sua vita, p. 3.
515. Codex Theod. l. XV, t. XII, De Gladiat. 1-2.
516. Loc. cit. p. 220.
517. Allude alla costituzione costantiniana del 325.
518. Ibid. l. IX, De poenis 1, 8. et 11. Di qui si deduce che prima di quell’epoca i cristiani si condannavano agli spettacoli anfiteatrali. Ma di questo tratteremo alla parte IV, quest. 3.
519. Cod. Theod., l. XV, t. XII, De Gladiat.
520. Prud., l. II, contra Symmach. — Edit. Dressel. Lipsiae 1860 v. 1109 e seg.
521. Non certo perchè a Prudenzio piacessero le venationes, nelle quali v’era sempre pericolo di spargere sangue umano, ma perchè egli comprese che sarebbe stato inutile esigere in quel tempo l’abolizione di tutti gli spettacoli anfiteatrali.
522. Teodoreto, 5, 26.
523. Cf. Tillemont, Hist. des Emp. 5, 533, seg.; il Nibby, Roma ant., I, 88; il De Rossi, Bull. Arch. crist. 1868, p. 84. — V’ha chi dice (Gori loc. cit. p. 78) essere molto difficile che Onorio si facesse convincere dagli argomenti di Prudenzio; e che non ha ombra di storica verità il racconto del monaco Telemaco, inventato (sic) da Teodoreto. Per potere asserire ciò, fa di mestieri provare che i ludi gladiatorî non ebbero fine sotto «QUEL PRINCIPE RELIGIOSISSIMO», e l’assoluta insussistenza dell’uccisione di Telemaco; e che Teodoreto, scrittore del V secolo, e quindi coevo al fatto da lui narrato, fosse o un ignorante o un falsario, o ambedue le cose insieme. In ogni modo le ragioni addotte dai contradittori non mi persuadono. Qualche argomento negativo, i punti esclamativi, le ironiche espressioni e qualche invettiva, se sono sufficienti per far prorompere in applausi coloro che non vissero IN TEMPI DI ECCESSIVA CREDULITÀ, sono argomenti affatto invalidi per una mente sana e non preoccupata, benchè pensante in tempi di eccessiva incredulità.
Il ch. P. H. Grisar (Roma alla fine del mondo antico, p. 33, Roma 1908) è dello stesso mio parere. Ecco le sue testuali parole: «Tuttavia sì barbaro sollazzo doveva sotto Onorio essere l’ultimo in Roma. Un pio monaco messosi per entro la calca del popolo era penetrato nel Colosseo. Gli spettatori, intenti ai certami, avran fatto poca attenzione ad un semplice asceta, forestiero, ignoto e comparso là in quelle sue grosse e povere vesti. Or mentre ferve la pugna ed il sangue comincia a scorrere, lanciasi d’improvviso il monaco sul parapetto, e corre difilato a separare i combattenti. Tutti collo sguardo si rivolgono a lui solo, che a gran voce in nome di Gesù Cristo ingiunge di desistere ed appella ai diritti della religione, che vuole bandita tanta crudeltà. Era da prevedersi che subito dopo il primo stupore la vampa degli animi accesi si sarebbe rivolta contra di lui. Il magnanimo diviene incontanente bersaglio al furore non meno degli spettatori che dei lottatori. Egli cade trafitto in mezzo a coloro che voleva salvi. Il sacrificio della sua vita suggella in tal guisa i suoi ammonimenti. — Non sappiamo, prosegue, se lo spettacolo finisse tosto che il cadavere fu trascinato fuori dell’arena; ma possiamo credere, che quando al delirio della passione, onde era stata invasa la radunanza, successe la tranquillità e la riflessione, si cominciò a sentire pietà dell’animoso pellegrino. Fatta indagine, si scoprì che il monaco trucidato, il quale, a quanto pare, chiamavasi Telemaco, abbandonata la sua patria in Oriente, avea pellegrinato a Roma, guidato dall’idea di levarsi contro i giuochi de’ gladiatori, sperando che, ove fossero tolti in Roma, sarebbero senza dubbio aboliti nel resto del mondo cristiano. Il suo scopo fu raggiunto: l’imperatore, tutto commosso per un atto sì eroico, emanò severissima legge che proibiva per sempre tali giuochi in Roma».
In nota poi aggiunge: «La narrazione è presso lo storico Teodoreto il quale scrisse circa l’a. 450. Hist. eccl. 5. c. 26, ed. L. Schultze, p. 1067 — Acta SS. Boll. 1 Jan. 1.31 — Analecta Boll. 1897 p. 252, ove senza fondamento viene messa in dubbio l’identità dello στάδιον di Teodoreto col Colosseo».
524. De Consul. Manlii Theod.
525. Cassiod. Variar. l. V. Epist. 142: Muneribus Amphitheatralibus diversi generis feras, quas praesens aetas pro novitate miraretur exhibuit, cuius spectaculi voluptates etiam exquisitas Africa sub devotione transmisit.
526. Baronio, ad. ann. 538.
527. Cassiod., Variar. l. V. epist. 42. — «Maximo Viro Illustri, Consuli Theodoricus rex.
«Si Consularem munificentiam provocant qui peruncta corporum flexibilitate luctantur, si organo canentibus redditur vicissitudo praemiorum: si venit ad pretium delectabilis cantilena; quo munere venator explendus est, qui ut spectantibus placeat, suis mortibus elaborat? Voluptatem praestat sanguine suo, et infelici sorte constrictus festinat populo placere qui eum non optat evadere. Actus detestabilis, certamen infelix cum feris vel contendere quas fortiores se non dubitat invenire. Sola est ergo in fallendo praesumptio, unicum in deceptione solatium. Qui si feram non mercatur effugere, interdum nec sepulturam poterit invenire. Adhuc superstite homine perit corpus; et antequam cadaver efficiatur, truculenter absumitur. Captus esca fit hosti suo et illum (proh dolor!) satiat quem se perimere posse suspirat. Spectaculum tantum fabricis clarum, sed actione deterrimum, in honore Scythicae Dianae repertum quae sanguinis effusione gaudebat.... Hoc Titi potentia principalis divitiarum profuso flumine cogitavit aedificium fieri, unde caput urbium potuisset. Cum theatrum quod est hemisphaerium, grecae dicatur Amphitheatrum, quasi in uno juncta duo visoria, recte constat esse nominatum: ovi specie eius arenam concludens, ut concurrentibus actum daretur spatium; et spectantes omnia facilius viderent, dum quaedam prolixa rutunditas universa collegerat. Itur ergo ad talia quae refugere deberet humanitas. Primus fragili ligno confisus currit ad ora belluarum; et illud quod cupit evadere, magno impetu videtur appetere. Pari in re cursu festinat et praedator et praeda; nec aliter tutus esse potest, nisi huic quem vitare cupit, occurrerit. Tunc in aëre saltu corporis elevato quasi vestes levissimae supinata membra iaciuntur, et quidam arcus corporeus supra belluam libratus, dum moras discedenti facit, sub ipso velocitas ferina discedit. Sic accidit ut ille magis possit mirior videri qui probatur illudi: alter angulis in quadrifaria mundi distributione compositis, rotabili facilitate praesumens, non discedendo fugit, non se longius faciendo discedit, sequitur insequentem, poplitibus se reddens proximum ut ora videt ursorum; ille in tenuem regulam ventre suspensus invitat exitiabilem feram; et nisi periclitatus fuerit, nil unde vivere possit acquirit: alter se gestabili muro cannarum contra saevissimum animal, ericii exemplo, receptatus includit, qui subito in tergus suum refugiens, intra se collectus absconditur; et cum nusquam discesserit, eius corpusculum non videtur. Nam sicut ille veniente contrario revolutus in sphaeram naturalibus defensatur aculeis: sic iste consutili crate praecinctus, munitior redditur fragilitate cannarum: alii tribus, ut ita dixerim, dispositis ostiolis paratam in se rabiem provocare praesumunt: in patenti area cancellosis se postibus occulentes, modo facies, modo terga monstrantes, ut mirum sit evadere quos ita respicis per leonum ungues dentesque volitare: alter labenti rota feris offertur: eadem alter erigitur ut periculis auferatur».
528. Loc. cit., p. 85.
529. Cap. VIII.
530. Ant. Pii.
531. Ancient Rome p. 219.
532. Loc. cit. pag. 56.
533. Ai 23 d’Agosto dell’anno 217.
534. Lib. LXXVIII e XXV; Cronicon. ann. 334.
535. Τό τε θέατρόν τὸ κυνηγετικὸν κεραυνοἷς ἔν αὔτᾗ τῶν Ἡφαιστείον ἡμέρᾳ βλαδέν, οῦτω κατεφλέχθη, ὥστε τήν τε ἂνω περιβολὴν αὑτοῦ πᾶσαν, καὶ τὰ ἔν τᾧ τοῦ κύκλου ἑδάφει πάντα κατακαυθῆναι, κἅκ τούτου τὰ λοιπὰ πυρωθέντα θραυσθῆναι. ὄυδὲ ἐπήρκεσεν αὔτᾦ οῦτε ἀνθρωπίνη ἡ πικουρία, καίπερ παντὸς, ὥς εἴπεῖν, ὔδατος ῥέοντος, οὔθ’ ἤ τοῦ οὔρανίου ἐπιῤῤοια, πλείστη τε καί σφοδροτάτη γενομένη, ἥ δυνάμεως ἁνηλίσκετο. καί ἔν μέρει καί ἀυτὸ τοῦτο περιεγένετο, ὅθεν ἤ θεὰτῶν μονομάχῶν ἔν τᾦ σταδιᾥ ἐπί πολλά ἐτη ἐτελέσθη.
536. Traduzione del Nibby; Roma nell’anno MDCCCXXXVIII. Parte I, Antica p. 405. Roma, Tipografia delle Belle arti, 1838.
537. «Ancient Rome» p. 219.
538. «Bull. Com.» loc. cit., p. 218.
539. Cf. Dio., loc. cit.; Hieron. in Chron. ad a. 218; C. I. L. I, p. 400.
540. Lamprid., in Heliog. c. 17.
541. Lamprid., in Alex. Sev. c. 28.
542. Lamp., in Alex. Sev. c. 4. — Anche nel nostro Anfiteatro v’erano luoghi d’infamia. Lampridio descrive l’immoralità di Caracalla, e dice: Fertur una die, ad omnes Circi et Theatri et Amphitheatri et omnium urbis locorum meretrices tectus cucullione mullonico, ne agnosceretur, ingressus.
543. Cohen, Alex. Sev. IV, p. 447, n. 468-469, ediz. II. — V. la riproduzione n. 2, p. 38 di quest’opera.
544. Cohen, Gord. Pio, V, p. 37, n. 165-166. Ed. II, V. n. 3, p. 38, di quest’opera.
545. Nibby, loc. cit. p. 420.
546. Edifizii 3, 24.
547. Loc. cit. p. 220.
548. Capit., Gordian. 32.
549. Hieron. Chron, edit. Roncalle, p. 475.
550. Cod. Theod. l. XVI, tit. VIII, l. I.
551. L. XVI, c. X.
552. Il Muratori, nei suoi Annali, fissa quest’irruzione nell’anno 442.
553. De gestis Longob. 4, 47. Cf. De Rossi, Ann. Inst. 1849, 338.
554. Notizie degli scavi anf. fl. R. 1813, p. 5; c. I. l. 6, 1763.
555. Nella tav. fotogr. n. 1337.
556. Fea, loc. cit. p. 3, segg.
557. Cf. Part. I, c. III. Altri archeologi, fra i quali il ch. Huelsen (Inscript. Urb. Romae, Part. quartae fasc. post. add., pag. 32214, n. 32089), basandosi sul passo di Vopisco, in Probo, da noi già riportato, sostengono (contro il Lanciani) che nell’Anfiteatro Flavio vi furono portae posticae. Sotto un aspetto hanno ragione i primi, sotto l’altro il Lanciani; e a me sembra che la mia opinione concilii le due opposte sentenze. Le porte dei postica, v’erano certamente: le portae posticae, nel senso di portae posterulae, no; tanto per la ragione addotta dal ch. Lanciani, quanto, perchè (come ho già fatto notare) non si possono chiamare posticae (posterulae) quelle porte che sono davanti.
Nella sezione dell’Anfiteatro Flavio pubblicata da varî archeologi e riprodotta nell’anno 1899 dal Dr. Heinrich Babucke (Geschichte des Kolosseums, Königsberg. Ostpr.), si vede disegnata (nel muro del podio) una porta coll’indicazione: Portae posticae. È una loro supposizione. Che cosa vi fosse sotto il ripiano del podio, già lo dicemmo a pag. 63.
558. Dal Lanciani, «Bull. comm.» loc. cit., p. 229. Quando scriveva il Lanciani il frammento c era inedito, ma nell’anno 1902 questo e tutti i frammenti inediti furono pubblicati dall’Huelsen, C. I. L. pars. 4, Additamenta, pag. 3203.
559. Pighio, cod. Berl. 121. Nel Coliseo, Ligorio; cod. Nap. I, 34, p. 156; L. I. L. VI, 1716; Addit., n. 32094
560. Fea, Fasti, LXV; C. I. L. VI, 1716 c, 1115.
561. Fea, Fasti, XLV; C. I. L. VI, 1716 b.
562. C. I. L., v. 2, VC; v. 5 ABO: v. 6 MO:  v. 9 RE.
v. 9 RE.
563. Marini, Difesa, 157; cf. il Fea: Ammonizioni, 31; il De Rossi, Ann. Inst., 1849, 340 etc.
564. Loc. cit., p. 44, n. XLV.
565. Lib. I, c. V.
566. Il ch. Grisar (Roma alla fine del mondo antico, Roma 1908, pag. 466) scrive: Nell’anno 508 Teoderico fa riparare il Colosseo, che da un terremoto aveva patito dei guasti».
567. Cf. la Silloge mariniana, n. 149 e seg.
568. Lib. Pont. edit. Duchesne, in Vitaliano, p. 343.
569. «Quella testa di bronzo, d’Augusto, e la gran mano che tiene la palla, mi fu detto essersi trovata avanti il Colosseo appresso la Mòta Sudante». Vacca, Memorie n. 71.
570. Si conserva nel Campidoglio. Nel 1440, per testimonianza di Biondo da Forlì, trovavasi nel Laterano.
571. Descriz. topog. delle antichità di Roma, part. I, c. 1, p. 45.
572. Duchesne, Lib. Pont. tom. I, in vita Stephani III, nota 23, p. 482: «Colosseo — La primière mention du Colisée sous ce nom, si toutefois, le biographe a voulu parler de l’amphithéâtre, lui-même et non pas du colosse voisin, d’où il tire son nom. L’ouvrage de Bèda, d’où l’on cite (Nibby, Roma antica part. I, p. 410) une prophétie sur la durée du Colisée, de Rome et du monde, est manifestement apocryphe: Quandiu stat Colisaeus, stat et Roma; Quando cadet Colisaeus, cadet et Roma: Quando cadet Roma, cadet et mundus, (Migne, P. L. tom. XCIV, p. 543)».
573. Urlichs, Codex Urbis Romae, topog. p 74.
574. In vita Steph., III, Edit. Duchesne, p. 472.
575. Cf. Jordan, Topogr. 2, p. 510.
576. Cf. Parisotti, Del culto d’Iside e Serapide in Roma, Tip. Vat. 1888; Corvisieri, ap. «Il Buonarroti» serie II, vol. V, Marzo 1870, p. 68 e segg.
577. Ciascuno di quei raggi era lungo 12 piedi e mezzo.
578. «Transtulit (Adrianus) et colossum stantem atque suspensum per Decianum (altri leggono Detrianum o Demetrianum) architectum de eo loco in quo nunc templum Urbis est, ingenti molimine, ita ut operi etiam elephantes vigint. quatuor exhiberet».
579. Tralascio di riportare le leggende ridicole del medio evo sull’origine della parola Colosseo. Il lettore le potrà trovare nell’opuscolo «Geschichte des Kolosseums» pag. 41. del Dr. Heinrich Babucke; Königsberg Ostpr. 1899.
580. Verona Illust. vol. V, p. 29.
581. Suet., Nero. cap. 13; Plin. l. 34, cap. 7.
582. Epig. 2.
583. Lib. XXXIV, c. VII.
584. Lib. XXXIV, c. VII.
585. Suet., Calig. c. XXXV.
586. Un esempio recente e che corrisponde a capello a quanto io asserisco, lo trovo in un articolo scritto dal ch. Gualtiero Castellini nel periodico «Il Secolo XX» (Giugno 1910, pag. 478). Questo scrittore narra che vedendo in Tunisia l’anfiteatro d’El Giem (già appartenente all’antica città di Thysdrus), esclamò: «Il Colosseo!» E prosegue: «Questo Colosseo maestoso, di grandezza poco inferiore a quella dell’Anfiteatro Flavio di Roma, conteneva circa settantamila spettatori: è lecito dedurre da questa cifra l’importanza che Thysdrus doveva avere, l’importanza che tutta l’Africa romana doveva aver conseguito negli ultimi secoli dell’impero.... Il sole brillava su i grandi archi maestosi, che luccicavano per una tinta dorata superba. È la pietra africana, è il sole che dà a questo Colosseo un aspetto aureo così glorioso?» — A pag. 481 poi, a piè della riproduzione dell’interno del suddetto anfiteatro romano, leggesi: «Interno del Colosseo d’El Giem».
587. Si riferisce al passo di Beda ed al brano del Liber Pont. già da noi citati.
588. Cf. Mabillon, Mus. Ital., Tom. II, p. 144.
589. Dal Periodico «Il Buonarroti» Serie II, vol. V, Marzo 1870, p. 68-69.
590. Hist. Nat., XXXVI, 37.
591. Fra gli edificî che sorsero sulla parte dell’Oppio che guarda l’Anfiteatro, non ho ricordato le Terme di Tito, perchè, secondo il mio umile modo di vedere, credo si debbano queste ricercare, giusta l’opinione del Piale, non sul colle ma nel basso, nell’area occupata dai giardini di Nerone. E per verità, se ben si legge l’epigramma 2º di Marziale (De Spect.), apparirà chiara la situazione di quelle Terme. Marziale esordisce in quell’epigramma, indicandoci l’atrio della Domus aurea, il sito appunto ove sorgeva il Colosso Neroniano, vale a dire sull’altipiano della summa sacra via (Cf. anche l’ep. LXXI ad librum); e descritta con enfatico fraseggiamento l’immensità dell’edificio:
Unaque iam tota stabat in urbe domus, ne dà nel penultimo distico il termine, dicendo: che là, ove al tramonto si distendevano le ombre allungate del Claudio portico, erano le ultime lacinie incompiute dello sterminato edificio:
Claudia diffusas ubi porticus explicat umbras,
Ultima pars aulae deficientis erat.
Determinata così la posizione dell’immenso fabbricato, passa ad insegnarci il luogo dello Stagno di Nerone:
Hic ubi conspicui venerabilis amphitheatri
Erigitur moles, stagna Neronis erant.
E segue immediatamente:
Hic ubi miramur velocia munera thermas,
Abstulerat miseris tecta superbus ager.
Le Terme di Tito, prossime all’Anfiteatro, Amphitheatro dedicato, thermisque IUXTA celeriter extructis (Suet. in Tito), noi dobbiam dunque ricercarle non sul colle, ove positivamente sorgeva il vasto fabbricato, ma nel basso ove dispiegavasi il superbus ager.
Sennonchè si presenta una difficoltà: la mancanza, cioè, di ruderi in quel tratto della pianura che si distende a levante del Colosseo. Ma questa difficoltà è più apparente che reale. Nella «Cronachetta» dell’Armellini (Fase. II, an. 1885) leggo una comunicazione del Lugari intorno ad alcuni ritrovamenti fatti all’angolo della «Via di S. Giovanni in Laterano» e della «Via Ostilia» mentre innalzavasi in quel sito una fabbrica dal sig. Gioacchino Costa. Ecco le parole del Lugari: «Sotto il piccolo fabbricato che esisteva nella località suddetta, io vidi alcuni anni indietro i resti di una fabbrica antica tuttora ben conservati, fra i quali una piccola stanza, la cui parete orientale correva parallela alla via di S. Giovanni. In questa s’apriva un vano interrato fino all’imposta dell’arco, che ricordo essere di bella costruzione. Ora cavandosi i fondamenti del nuovo fabbricato si rinvennero altri muri contemporanei ai già descritti, con restauri di età più tarda.... In un cavo apparve una parte di fascia di un pavimento a mosaico semplice bianco e nero. Tra le terre venne fuori un frammento d’iscrizione in caratteri dell’età degli Antonini. La lastra è grossa 0,06. Questo frammento di lapide, che il Sig. Costa mise gentilmente a mia disposizione perchè ne potessi prendere il calco, dice così:
. . . . . . . . CI . COMI . . . . . .
. . . . NINI . AVG . SEI . . . . . .
. . .VLANVS . ET . SOD . . . . . .
. . . . LENDIDISSIMAM . . . . . .
Il Lugari giudicò quei muri dell’età degli Antonini; con tutto ciò, ritenendo col Piale che ivi fossero le Terme di Tito, pensò che la splendidissima donazione fatta ad un Sodalizio da uno degli Antonini, non fosse altro che la donazione delle Terme stesse, rese ormai inutili e per la lor piccolezza e per le vicine Terme di Traiano, e forse anche per l’erezione delle Commodiane; facendovi, il donatore, delle nuove opere onde ridurle ad uso di quel Sodalizio. Non v’ha dubbio che la scoperta di un ampio piazzale avanti all’Anfiteatro, dalla parte del Laterano, analogo a quello del lato opposto ove avea origine la Via Sacra (Gatti, Bull. Arch. Com. 1893, p. 117), ci fa ragionevolmente opinare che in quella parte sorgesse un importante edificio. Lo spazio poi che v’è fra le vie Maior e Merulana è tale, da poter contenere una fabbrica eguale a quella detta oggi comunemente le Terme di Tito. Non intendo con ciò dire che le terme disegnate dal Palladio, e da lui dette di Vespasiano, siano da adattarsi qui: no; la scala monumentale espressa in quel disegno, per la quale si ascendeva dalla pianura alla spianata che aprivasi dinanzi alla Terma, stabilisce quell’edificio indubitabilmente sul colle. Soltanto mi limito ad asserire che nell’area da me indicata, v’era lo spazio sufficiente per una Terma di limitate proporzioni, eguale a quella detta dal Palladio «di Vespasiano». Se poi fosse certo che il sito dei Castra Misenatium fu ove li ha collocati il ch. Lanciani nella Forma Urbis, dovremmo, per l’indicazione ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΤΙΤΙΑΝΑΣ (Kaibel, Inscript. Gr. sic. 956, B. 15), ritenere le Terme di Tito sorte senz’altro in quel posto. E lì appunto ce lo indicherebbero e la medaglia di Domiziano e quella fatta coniare da lui stesso in onore di Tito e di Vespasiano, se fosse plausibile la mia idea di sopra accennata, e che consiste in credere che il portico a doppio ordine di colonne rappresentato in quei monumenti numismatici raffiguri le velocia munera. Più ragioni m’inducono a ravvisare in quel portico le Terme di Tito. E queste ragioni sono: 1.º Perchè in quello non posso riconoscere col Donaldson un passaggio che congiungeva il Palatino coll’Anfiteatro, poichè quel portico trovasi in tutt’altra posizione; dalla parte, cioè, del Laterano. 2.º Perchè non si può ammettere col Guattani e col Nibby che fosse quello un porticato che salisse alla casa di Tito sull’Esquilie; giacchè l’Anfiteatro, veduto com’è inciso sulle medaglie, guarda il Celio, e quindi, avrebbe esso impedito assolutamente la veduta di quel portico. 3.º Perchè nessuno degli antichi scrittori ricorda ivi alcun edificio non termale, la cui esistenza escluderebbe senz’altro da quel posto le Terme di Tito. Oltre a ciò, l’essere stato preferito nelle medaglie il prospetto dell’Anfiteatro che guarda il Celio, ci dice che quella scelta dovè aver avuto uno scopo. Ecco la ragione per cui io accennai l’opinione che in quei bronzi commemorativi si siano volute esprimere, nella loro reale positura, le tre opere dei Flavî: la Mèta Sudante, riedificata sontuosamente da Domiziano, la venerabil mole di Vespasiano e le velocia munera di Tito. Finalmente il non vedersi più quel portico nelle medaglie di Severo Alessandro e di Gordiano, dimostra che a questi Imperatori non più interessava quell’edificio, il quale, per aggiunta, fu ridotto ad altro uso (come v’è fondamento di credere) fin dai tempi di Commodo.
Ma che sono adunque le terme designate dal Palladio e che positivamente si trovano sul colle? Io opino che siano la parte termale della Domus aurea, divenuta poi domus Titi Imperatoris. Difatti la parete esterna dell’abside della sala maggiore (i ruderi della quale abside si vedono tuttora dietro la caserma delle Guardie di Pubblica Sicurezza) è parallela ai muri della Domus aurea, scoperti sotto le Terme di Traiano, e la sua cortina presenta caratteri di un’epoca anteriore ai Flavî, come pure a questa stessa epoca ci riportano gli avanzi del portico a pie’ della scala.
Giustamente nota il Lanciani che, a fine di dare significato pratico e materiale all’indicazione dei Cataloghi: thermae Titianae et Traianae, convien supporre che quell’edificio fosse stato unito alle Terme di Traiano con qualche braccio di porticato o almeno di passaggi sotterranei (Lanciani, Bull. Arch. Com. anno 1895, p. 112). Ma, a parer mio, con quel Thermae Titianae si alluse dai Regionarî alle Terme private della Domus Titi, forse allora rese pubbliche, facendole divenire con quel congiungimento un’appendice delle Traiane; e non già si volle alludere alle velocia munera, che verosimilmente nel IV secolo non più esistevano.
592. Urlichs, Codex Urb. Rom. Topogr. p. 136.
593. Loc. cit., p. 110.
594. Ibid. p. 121.
595. Adinolfi, Roma nell’età di mezzo. Tom. I, p. 356, nota 4.ª
596. Possessi, p. 97, nota 4.
597. Cf. Grisar, Histoire de Rome et des Papes, l. II, c. II, p. 23.
598. Bull. Com. arch. Comun. An. XXIII, p. 121.
599. I tronchi di colonne ed i capitelli di quel portico, rinvenuti nel basso dell’Anfiteatro, ne sono una chiarissima prova.
600. Baronio, Ann.
601. Cf. Pasquali, S. Maria in Portico. Roma 1902. Introd. p. 35.
602. Panv. De Gente Frang., l. I, c. IV; Gaetani, Vita di Gelasio II, p. XI; Massimo, Mem. stor. della Chiesa di S. Benedetto in Piscinula, 7.
603. Vi fu chi credè che questa torre si elevasse sopra l’Arco di Tito; ma in una stampa di Marco Sadeler, pubblicata in Praga nel 1606, osserviamo detta torre diroccata, benchè ancor visibile per poterne precisare il posto. La torre Chartularia era sul pendio del colle Palatino (ms. della Bibl. Angelica, segn. D. V, 13), e riunita all’Arco di Tito per mezzo di un muro. L’Arco era fortificato anch’esso e congiunto con altro muro alla Chiesa di S. M. Nuova.
604. I fratelli del Papa erano i Guidoni Papareschi, nobili di Trastevere.
605. Di nome Pietro, figlio di Pier Leone e discendente d’Ebrei; il quale, dopo la morte di Callisto II, avea rialzata la testa.
606. Apud Murat., De script. Rerum Ital. Tom. 3.
607. Tomo II.
608. V. Agnello Anast., Ist. degli ant. Tom. II, p. 35; Corti, De Sen. Rom., l. VII, c. 9, § 168; Vendettini, De Sen. Rom., l. II, c. 1, n. 2, p. 120.
609. V. F. Sabatini, La fam. e le torri dei Frang. in Roma 1907, p. 24, Roma 1907.
610. Nel 1165, secondo il Gori, (loc. cit.), o nel 1166 secondo il Baronio ed altri.
611. Ott. Frisigense, De gestis Frid. I. l. I, c. 28 al brano della lettera scritta dal Senato Romano a Corrado, ove dice: nam pacem et justitiam. «Questo fatto di guerresca occupazione, osserva l’Adinolfi (Roma, nella età di mezzo I, 365), comechè ingiustissimo, pare esser stata la cagione per cui nella vita di Alessandro III, (Muratori, R. I. S., t. III, part. I, p. 459) vien presupposto il Colosseo in dominio dei Frangipani, dicendovisi che Alessandro, presso S. Maria Nuova, la torre Chartularia ed il Colosseo si fosse rifugiato alla sicura».
612. Loc. cit., p. 88.
613. De Gent. Frang.
614. Agnello Anast., Tom. II, p. 73 e 74.
615. Vita d’Inn. III, raccolta da Stefano Baluzio, Apud Murat., t. III, p. 566, n. 140.
616. Il Marangoni crede che una parte di questa torre fosse quella che ai suoi tempi vedevasi nella prima vigna, passato il Colosseo, per andare ai ss. Quattro, alla quale potevano giungere i sassi e le saette scoccate dall’Anfiteatro.
617. Petrus Annibaldi, sororius D. Papae, pontes omnes juxta Colisaeum et turrim ex opposito caepit construere, prohibentibus Jacobo Frajapane, et Relicta Najonis, Frajapanis impedientibus ut poterant, per Colisaeum et turrim Najonis, lapidibus et sagittis emissis: sed (Annibaldi) per dictas oppositiones ab aedificio non cessabat. — Cf. Baluzio, Vita d’Innocenzio III. — Murat., R. I, S., part. I, p. 459. — Olivieri, Sen. Rom., p. 206.
618. Giacomo Frangipane era partigiano di Giovanni Capocci. Nel 1228 Giovanni Frangipane diè in enfiteusi vitalizia cryptam positam sub Amphitheatro Colisei a Pietro Salincontra (Strum. in atti di Iacopo Scrivario). V. Adinolfi, loc. cit.
619. Panv., De Gente Frangep.; Rainald., Ann. an. 1244, n. 19.
620. Suarez, in Diatriba.
621. Marangoni, loc. cit., p. 78.
622. Il Gori (loc. cit.) vuole nell’anno 1311. Cf. Albertino Mussato, Hist. Aug. l. V. — Apud Muratori R. I. S. Tomo X, 454.
623. Loc. cit., p. 356 e segg.
624. Nel medio evo vedevasi nell’arena dell’Anfiteatro un solio termale, il quale fu, con ogni verosimiglianza, là collocato dai Frangipani o dagli Annibaldi per uso domestico più che per semplice ornamento. In seguito per donazione inter vivos fatta da Nicolò Valentini del Rione Monti (V. Archiv. di Stato di Roma, posizione «Arciconf. del Salv. Catast. del 1419, n. 19»), il suddetto solio appartenne all’ospedale di Sancta Sanctorum.
625. III, n. 2.
626. Rainaldo, Ann.
627. L’Adinolfi, (loc. cit.) vuole che sia ciò accaduto nel 1328.
628. Fumi, Codice diplomatico della città di Orvieto. Firenze 1884, pagg. V-VII.
629. Tom. CXLVIII.
630. «La stampa ha: che avevano raccomandato tutto con ordine di tavolini».
631. «Ed io racconteró quali giovani giocorno e quali morirono, si legge nella stampa».
632. Il Visconti opina che la torre di Nerone fosse quella sovrastante al monastero delle Domenicane in via Magnanapoli. Il Gori peró, nel tomo CLVIII, p. 35 del Giornale Arcadico, sostiene che per torre di Nerone era detta l’antica Torre Mesa, già esistente nel Giardino Colonna, e disegnata dallo Scamozzi prima che fosse distrutta nel secolo XVI.
633. «E le altre di minor sfera dell’altra, sta nella stampa, nella quale è omesso quel che segue distinto di carattere corsivo».
634. Questo nome non è nel manoscritto del Visconti.
635. «E lui n’era fieramente innamorato, ha la stampa».
636. «Cioè Domenico Astalli, di famiglia illustre romana, oggi estinta. Mezzo Stallo ha la stampa».
637. «La stampa ha: figlio di Giovanni Mario».
638. «COSÌ BIANCA È LA FEDE, si legge nella stampa, togliendo il concetto dalla persona, ond’è particolare, per recarlo alla cosa, di che perde tutto quell’acume che si cercava in questi motti e nelle allusioni di essi all’indole e ai pensieri di chi voleva più o meno chiusamente dimostrarli con essi».
639. «Ad Agapito Colonna la stampa fa portare una collana di cera al cappello. Oh! diamine! direbbe il Cesari, e come questo? L’errore del copista si conosce facilmente, fu nel testo: una colonna c’era, ecc. Mutata la colonna scritta forse da taluno collonna in collana il c’era divenne cera, il di parve necessario, e la collana di cera fu fatta».
640. «Qui pure il testo stampato ha collana».
641. «Nella stampa si legge a san Marcello de’ Stalli, chiesa che non ha riscontro alcuno con quelle esistenti o esistente già in Roma. Ben l’ha santa Mariella, come è nel testo a penna del sig. Visconti. La ricordò Fioravante Martinelli nel trattare de templis sanctorum obsoletis al capo XII della sua Roma ex ethnica sacra, in queste parole: sancta Maria, sive de strada, nunc domini Jesus. Quella piccola Chiesa fu in fatto compresa nel grande edificio della Chiesa del Gesù, e notissimo è quivi lo splendido palazzo Altieri». Gori, loc. cit., pag. 95 n. 1.
642. «E li calzoni a brache bianche, sta nella stampa».
643. «Franciotto Mareri personaggio di potente famiglia intorno alla quale si ha nel codice stesso manoscritto degli annali del Monaldeschi un bel consenso di memorie, venne mutato nella stampa in Franciotto di Mansini».
644. L’Adinolfi (loc. cit. p. 360 e segg.) scrive: «I personaggi che diedero gli spettacoli nel 1328 (?) sembra indossassero farsetto e brache dello stesso colore. Ma il colore delle vesti di uno era diverso da quello delle vesti dell’altro. Avevano una cintura dalla quale pendeva uno spiedo, ed in testa un cappello di ferro o cimiero con pennacchio.... Vi furono 18 morti e 9 feriti. Uccisero 11 tori. Nè tanta fu la strage umana che si vide nel Colosseo come si vorrebbe far credere. Molto sangue nondimeno si sparse, e questa fu la ragione per cui nell’età di mezzo si tralasciarono simili spettacoli».
645. Notizie inedite ecc. Rend. della R. Accad. dei Lincei, 1896.
646. V. Duchesne, L. Pont. tom. I. p. 482, not. 23.
647. De Sade, Mém. pour la vie de François Petrarche, Tom. III, l. 4, p. 35 e segg. — «Ecce Roma ipsa insolito tremore concussa est: tam graviter ut ab eadem Urbe condita supra duo annorum millia tale nihil acciderit. Cecidit aedificiorum veterum neglecta civibus, stupenda peregrinis moles. — Turris illa toto orbe unica, quae comitum dicebatur, ingentibus rimis laxata diffluit, et nunc velut trunca caput superbi verticis horrorem solo effusum despicit. Denique ut irae coelestis argumenta non desint, multorum species templorum, atque in primis Paulo Apostolo dicatae aedis bona pars humi collapsa, et Lateranensis ecclesiae deiectus apex, Jubilaei ardorem gelido horrore contristant».
648. Le mem. storiche dell’Anf. Flavio p. 96.
649. Roma antica, Part. I, p. 417.
650. V. Rainaldo, an. 1365 n. 9. tom. XXVI, p. 114.
651. Mém. sur les anciens monum. de Rome, Acad. des Inscript. Tom. XXVIII, p. 585.
652. Loc. cit. Not. ined. p. 4.
653. V. Albertinus Mussatus, Hist. Aug. ap. Murat. Rer. Ital. script. Tom. X, c. 454.
654. V. Cancellieri, Stor. dei solenni promessi p. 311, not. 2.ª
655. V. Marangoni, loc. cit. il quale assicura aver desunte queste notizie dall’Archivio di Sancta Sanctorum (Armad. I, mazzo III, n. 15).
656. V. ap. Moroni, Diz. ecc. voce Colosseo.
657. Adinolfi, Roma nell’età di mezzo Tom. I, p. 374 e sgg. — Roma 1881.
658. V. Archivio di Stato (Roma) — Posiz. Arciconf. del Salvat.
659. V. Archivio di Stato (Roma), Posiz. Arciconf. del Salvat. catasto del 1419, n. 59.
660. Ibid., cat. de’ beni del 1435, p. 59.
661. V. Marangoni, loc. cit.
662. Pergamena datata al 29 Aprile 1531.
663. Dai documenti dell’Archivio di Sancta Sanctorum, comunicati dal Sig. Ab. Colomanno Hamerani al ch. Marangoni.
664. Ad calcem deletum, distrutto fino a terra, e non distrutto PER FAR CALCE, come tradusse il Gori (Memorie storiche del Colosseo, p. 98). Altri, come H. Babucke (Geschichte des Kolosseums, p. 32), han voluto dare a queste parole lo stesso significato; ma avvertito l’errore, cosa han fatto? Hanno cambiato arbitrariamente il testo originale, e la frase «ad calcem deletum» è divenuta «ad calcem redactum!».
665. Vacca, Memorie di varie antichità trovate in diversi luoghi della Città di Roma, N. 72.
666. Ecco le parole del Vacca: «Mi ricordo aver sentito dire da certi frati di S. Maria Nova (ora S. Francesca Romana) che Papa Eugenio IV (a. d. 1431) aveva tirati due muri che racchiudevano il Coliseo nel loro monastero; e che non ad altro fine era stato concesso al detto monastero, se non per levare l’occasione del gran male che in quel luogo si faceva; e che dopo la morte di Eugenio, avendolo goduto per molti anni il monastero, finalmente i Romani fecero risentimento che così degna memoria non doveva restare occulta, e a dispetto de’ frati andarono a furor di popolo a gettar le mura che lo chiudevano, facendolo comune, come al presente si vede. Ma i detti frati dicono aver tutte le ragioni in carta pergamena; e mi dissero che se veniva un Papa della loro, si farebbero confermare il donativo, e vivono con questa speranza».
667. Adinolfi, loc. cit., p. 379.
668. Roma nell’età di mezzo, p. 376. Tom. I, Roma, Fratelli Bocca e C. 1881.
669. Nibby, loc. cit., p. 417.
670. Loc. cit. p. 236.
671. Loc. cit. p. 60, n. XLVIII. Il Lanciani infatti non fa osservazioni contrarie.
672. Part. II, c. 4.
673. Aver cioè Paolo II «dato licenza ad alcuni suoi architetti di poter demolire alquanti archi del Colosseo».
674. Loc. cit. p. 376.
675. «Dilectis filiis etc. Non potuimus non turbari audientes sive ab altero vestrum sive ab aliis nostris offitialibus concessum fuisse ut quidam Colisei pars que Cosa vulgariter noncupatur pro restauratione quorundam domorum deiiciatur. Nam demoliri Urbis monumenta nihil aliud est quam ipsius Urbis et totius orbis excellentiam diminuere. Itaque vobis harum serie iniungimus et sub indignationis nostre pena precipiendo mandamus, ut si quid huiusmodi sive a nobis sive a quibus aliis concessum extitit penitus revocetis nec quovis modo permittatis ut et minimus dicti Colisei lapis seu aliorum edificiorum antiquorum deiiciatur: super quibus detis talem ordinem ut huiusmodi mandatum inviolabiliter observetur, contenti tamen sumus ut ille cui forsan talis concessio facta extitit, de locis subterraneis a Coliseo distantibus lapides evellere possit. Datum Florentiae etc.». (Lib. brevium Martini V, Eugenii IV et aliorum. Archiv. Vatic. Arm. XXXIX, tom. VII, c. 341, n. 319. Cf. Lanciani, Storia degli Scavi di Roma, vol. I, p. 51).
676. Architetto del palazzo di S. Marco o di Venezia, forse in compagnia di Giacomo da Pietrasanta.
677. Notizie della Famiglia Boccapaduli, p. 132.
678. Col permesso di Urbano VIII.
679. Not. ined., loc. cit.
680. V. Adinolfi, loc. cit., p. 379.
681. Adinolfi, loc. cit. p. 371.
682. Probabilmente erano fanciulli che rappresentavano la scena al vero; giacchè nel dramma recitato nel 1531 si legge: «Spirato il Redentore s’apre il cielo con folgori e tuoni e risuscitamento di morti; s’apre il velo del tempio e gli Angeli vengono alla Croce e dicono in musica: Ecce Agnus Dei».
683. Arch. del Gonf. mazzo XII. Oggi nell’Arch. di Stato (Roma).
684. Questi era solito fare la parte di Cristo.
685. Loc. cit., p. 87.
686. Il Redentore vestiva tunica e mantello; la Vergine indossava quegli stessi indumenti, coi quali, anche ai tempi nostri, la sogliono i pittori raffigurare. Gli altri attori poi vestivano alla foggia antica, ed avevano abiti di costume orientale o romano, secondo la parte che rappresentavano.
687. Fra un atto e l’altro v’era sempre il canto di due cori.
688. L’autore tralascia il resto, forse perchè notissimo.
689. L’autografo dice: dinanti.
690. L’autografo ha: quale e non il quale.
691. L’autografo ha: Imperiale legge.
692. L’autografo ha: factionoso.
693. L’autografo ha: boni.
694. L’autografo ha: iudicamo.
695. L’autografo ha: advenire.
696. L’autografo ha: considerato.
697. L’autografo ha: vergogniosamente.
698. L’autografo ha: adonque.
699. L’autografo ha: factionosi.
700. L’autografo ha: dobiate.
701. L’autografo ha: alle legie imperiale.
702. Loc. cit. pag. 388.
703. Arch. del Gonf. A, foglio 138, anno 1519, 6 Febbraio. (Arch. di Stato, Roma).
704. Ex. lib. Decr. A. foglio 161.
705. V. Lanciani, Storia degli Scavi, vol. I, p. 214.
706. Ex lib. Decret. A, 182, 25 Marzo.
707. Ibid. A, 185.
708. Ibid. A, foglio 32.
709. V. il Rubricellone dell’Archivio, p. 70.
710. In quella circostanza si formò una specie di comitato, dal quale, per ottenere più facilmente la licenza, furono inviati al Papa i seguenti rappresentanti: «D. Antonius Puteus, d. Vicentius Pacetius, d. Antonius de Jacobatiis, d. Michael de Valeriis, d. Petrus Paulus de Attavantis, d. Gaspar de Scappucciis, d. Stephanus Medicus, d. Antonius Albertinus, d. Pirrus, d. Jordanus Buccabella, R. d. Bartholomaeus Cirillus, d. Franciscus Pallavicinus» (V. Lib. Decret., foglio 126).
711. A, foglio 126.
712. A, foglio 138.
713. Lib. Decret., A. f. 138.
714. Sotto lo stesso titolo di S. Maria della Pietà.
715. L’Anfiteatro Flavio, l. I, p. 49.
716. Anno 1435, p. 59.
717. Pag. 391.
718. Questo registro fu scritto da Niccolò Frangipane ai tempi di Bonifacio VIII. V. Crescimbene, Storia di S. Giovanni avanti porta Latina, p. 212.
719. V. Parte IV. Questione III.
720. B. A. C. a. 1895, n. 122. Gatti.
721. Histoire de Rome et des Papes au Moyen âge, l. IV, c. IV, p. 232.
722. F. Gori, Le memorie storiche, i giuochi e gli scavi dell’Anfiteatro Flavio ed i pretes, martiri Cristiani del Colosseo, C. II, p. 54 e segg. — P. Delehaye, Analecta Boll. T. XVIi 1897, p. 209 e segg.
723. Roma alla fine del mondo antico, p. 175.
724. Benedetto Mellini, Delle Antichità di Roma.
725. V. Armellini, Le Chiese di Roma, 2. ediz. p. 140-41.
726. Laterano e Via Maggiore, p. 120. Roma 1857.
727. Cf. Il Catasto del 1462. Le surriferite notizie sono state tratte dall’archivio di Sancta Sanctorum, dal citato catasto: e da uno strumento in dominum, estratto dai protocolli di Giorgio di Albino di Castiglione, notaio, datato ai 17 Marzo 1490, il quale è del tenore seguente:
«Recognitio facta per Guardianos Confalonis domorum de Coliseo.
«Indictione VIII. mens. martii die 17. 1490.
«Eisdem indictione mense et die quibus supra.
«In praesentia nostrorum notariorum etc. Discreti viri Mariani Scalibastri et mei Georgii Albini et cuiuslibet nostrorum in solidum. Cum hoc fuerit et sit, quod Venerabile hospitale Societatis Sanctissimi Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe, cum spatio 120 annorum vel circa tenuerit et possiderit pacifice et quiete, nemine contradicente, certas domos, et accasamenta positas et posita in Amphitheatro Colisei, quae fuerunt quondam nobilium de Anniballis de Coliseo, qui illas Guardianis dicti hospitalis vendiderunt ut constat pubblico instrumento; et nunc nobiles viri Ludovicus de Marganis et Altus de Nigris Guardiani dicti hospitalis Salvatoris teneant et possideant; et nobiles viri Joannes de Branca et Marcus quondam Pauli Columne Sebastiani Guardiani Societatis confalonis de Urbe dixerint et exposuerint eisdem Guardianis hospitalis Salvatoris per Sanctissimum Dominum nostrum Papam Innocentium fuisse et esse eis concessum, posse in dicto Coliseo facere representationes et devotiones Christi, et Sanctorum suorum; et quod ipsi Guardiani Confalonis egent dictis domibus et accasamentis et dicta parte Amphitheatri, ubi dictae domus apparent edificatae et constructae; et quod sine ipsis, ipsi Guardiani non possent dictas representationes facere, et pro aptitudine loci et conservatione rerum ad dicta festa necessaria. Conservatores requisiverint prefatos Guardianos Salvatoris, ut velint consentire, ut dictis domibus et accasamentis ut valeant et possint pro dictis representationibus et festis tantum, et non ad alium usum. Hinc est quod prefati Ludovicus de Marganis et Altus de Nigris Guardiani prefati hospitalis Salvatoris, sponte et ex certa eorum scientia, et non per errorem quoad suprascripta et infrascripta, dederunt et concesserunt eisdem Guardianis Confalonis, presentibus, recipientibus vice et nomine dicte Societatis Confalonis, et nobis Notariis, plenam licentiam et omnimodam facultatem, et potestatem, posse in dicto palatio dictas devotiones et representationes facere, et illud reparare ad dictum usum tantum, et non aliter, citra tamen prejudicium aliorum jurium et privilegiorum utriusque partis si qua (sic) habent, et cum licentia et auctoritate dictorum conservatorum alme urbis et Lelii de Fabris, Francisci Teuli, et Simeonis de Cecchinis; et convenerunt Guardiani Confalonis et ita promiserunt eisdem Guardianis Salvatoris, quod dato quod tractu temporis et quandocumque dicti Guardiani et Societas hospitalis Salvatoris vellent rehabere dictas domos et accasamenta et illis egerent pro eorum usu, quod tunc dicti Guardiani et Societas Confalonis teneantur illico dictum palatium seu domos dicto hospitali et illius Guardianis libere dimittere et relaxare, absque aliqua exceptione: quas domos et accasamenta costituerunt et recognoverunt sese tenere et possidere nomine dicti hospitalis et Guardianorum eiusdem, et liceat Guardianis dicti hospitalis et Societatis eiusdem hospitalis Salvatoris dictam Societatem Confalonis et illius Guardianos inde expellere, promittentes plenarie partes una alteri et altera alteri cum juramento, predicta omnia et singula inviolabiliter perpetuo observare, et rata et grata tenere et habere contra non facere, dicere vel venire, aliqua ratione, jure, modo, titulo, sive causa pro quibus omnibus et singulis observandis et plenarie adimplendis, dicte partes hinc inde singula singulis congrue referendo, obligarunt omnia et singula bona dictorum hospitalium et societatis (sic) et voluerunt pro prefatis posse cogi etc. et renuntiaverunt etc. et juraverunt etc.
«Actum in Palatio Conservatorum alme Urbis presentibus etc. iis testibus etc. nobilibus viris Joanne de Palonibus regionis Arenule et Dominico quondam Joannis de Maldosso Regionis Trivii ad premissa vocatis habitis et rogatis.
«Ex protocollo Instrumentorum Georgii Albini de Castiglione Notarii pubblici et Venerabilis hospitalis Sanctissime Imaginis Salvatoris».
728. Roma ex ethn. sac. C. 12, p. 361.
729. Loc. cit. p. 83.
730. Ibid.
731. Ap. Marang. loc. cit.
732. Laterano e via Maggiore, p. 116.
733. L’asserto dell’Adinolfi è basato sulla Bulla Unionis Ecclesiarum Ss. Quadraginta et S. Mariae Hospitali S. Jacobi prope Colisaeum, emanata dal Papa Eugenio IV, ai 18 gennaio del 1433, nella quale leggiamo: «.... hospitali S. Jacobi prope Coliseum etiam de Urbe ab eodem hospitali S. Angeli dependens et per illius Guardianos et confratres huiusmodi gubernari solitum etc.».
734. Ex eadem Bulla.
735. «Guardianis, custodibus et officialibus antepositis societatis Raccomandatorum imaginis Salvatoris ad Sancta Sanctorum ac pauperum hospitalis S. Angeli et hospitalis S. Jacobi et hospitalis Ss. Petri et Marcellini. (Da una Pergamena dell’Arch. S. Sanctorum).
736. Il lodato Mellini è dello stesso parere: «Contiguo alla chiesa di S. Giacomo (dice) v’era un ospedale per le donne, come viene scritto nel catalogo 2º della medesima compagnia sotto l’anno 1466 da Niccolò Signorili, benchè questo dica che l’ospedale fosse costrutto pro militibus. (Arch. Vat. Mss. dell’antichità di Roma arm. VI, n. 38).
737. Questa notizia l’attinse l’autore da una Licentia Magistrorum Stratorum Guardianis Societatis Ss. Salvatoris concessa.
738. Adinolfi, Lat. e Via Maggiore p. 112.
739. Pagan and Christian Rome, p. 161.
740. Analecta Bolland. Tom. XVI, p. 248 e segg.
741. Bull. A. C. Ser. IV, an. III, p. 157 e segg.
742. Storia di Roma e dei Papi nel medio evo, l. I, c. V, ediz. francese, p. 177.
743. Canina, Indicazione antiquaria di Roma Antica, p. 102.
744. V. Questione III, Parte IV.
745. Ibid.
746. Piale, Memorie Enciclopediche, 1817, p. 154.
747. Loc. cit. p. 159.
748. Tertul. Ad. Nat. I, 9; Apol. 40.
749. LXXI, 29.
750. Ant. Phil. 4, 11, 12, 15, 23.
751. V. 2.
752. Histoire des persecutions, tom. I, p. 355 e seg.
753. Loc. cit. p. 357.
754. Bull. A. C. loc. cit., p. 165.
755. V. De Rossi, «Bull. A. C.» serie II, an. IV, p. 147 e segg.
756. «Bull. A. Com.» Ann. XXIII, pp. 124-125.
757. Lanciani, Forma Urbis.
758. Analecta Bolland. Tom. XVI, p. 248 e seg.
759. Prima di parlare di quelle chiese che più direttamente manifestano la venerazione dei fedeli verso il Colosseo (venerazione che fu causa dell’aggruppamento delle stesse in quella zona), ho creduto conveniente occuparmi della chiesa dei Ss. Quadraginta Colisaei; sia perchè anch’essa in qualche modo fa parte di detto aggruppamento, sia perchè fu eretta per i Misenati, i quali, come è noto, erano al servizio dell’Anfiteatro.
760. V. Wilpert, S. Maria Antiqua, p. 14.
761. Loc. cit. p. 18.
762. Varie sono le opinioni degli archeologi circa la situazione precisa del Campus Agrippae. Il Nardini, ad es., fra gli antichi, ed i Compilatori del Corpus Inscriptionum fra i moderni, ritengono che il Campus Agrippae occupasse lo spazio compreso fra l’attuale Corso Umberto e le Thermae Agrippianae, da un lato, e la Via del Seminario e la Piazza S. Marco dall’altro. Il Lanciani e l’Huelsen lo collocano invece altrove, e precisamente ad Est della Via Flaminia, tra il suddetto Corso Umberto e la Via della Stamperia, in un senso, e le Vie Minghetti e del Pozzetto nell’altro.
Per giudicare quale delle due opinioni sia più probabile, il miglior partito è di esaminare i passi di quegli autori antichi che parlano del Campus Agrippae, e vedere se vi sia qualche monumento che possa gittar luce sulla questione.
Gli antichi scrittori che parlano del Campus Agrippae, sono: Dione Cassio (Lib. LV), Aulo Gellio (Noctes Atticae l. XIIII c. V), ed il Cronografo del 354 (Urlichs, Codex Top., p. 191, 25). Aulo Gellio ed il Cronografo nominano il Campus Agrippae; ma dalle loro parole null’altro può dedursi che la sua esistenza. Il primo scrive: «Defessus ego quondam ex diutina commentatione, laxandi levandique animi gratia, in Agrippae Campo deambulabam, atque ibi duos forte grammaticos conspicatus, etc.». Nel secondo si legge: «Aurelianus Imp. ann. V. m. IIII. d. XX congiarium dedit XD. — Hic muro urbem cinxit, templum Solis et castra in Campo Agrippae dedicavit, etc.». — Dal passo di Dione però, oltre all’esistenza, se ne deduce pur anche (e molto fondatamente) la situazione. Lo storico greco ci dice infatti che Augusto, dopo la morte di Agrippa, dedicò il di lui Campo, eccettuato il portico (il quale, da quanto si dice appresso, fu quello incominciato ad erigere nel Campo da Vipsania Pola, sorella di Agrippa), nonchè il Diribitorio, lasciato incompleto da Agrippa e terminato da Augusto prima della dedicazione, rendendo egli ogni cosa di pubblico diritto. In quella circostanza si diè un funebre munus gladiatorium, in Septis, sia (dice Dione) per rendere onore ad Agrippa, sia per l’avvenuto incendio di molti edifici attorno al foro.
Ora il sito del Porticus Septorum e dei Septa è da tutti riconosciuto ad Ovest del primo tratto della Via Flaminia chiamato Via Lata. Posto questo caposaldo, l’essersi dato il munus gladiatorium per onorare la memoria di Agrippa in Septis, anzichè nel Foro od altrove, e l’esser ciò avvenuto nel giorno della dedicazione del Campo dello stesso Agrippa, son due cose che ci spingono a ritenere che quelli si trovassero in questo Campo; e che si fosse scelto quel luogo per fare, quasi direi, prender possesso al Popolo Romano del Campo suddetto, fin dal giorno della sua dedicazione.
L’esame poi dei monumenti che Dione c’indica esistenti nel Campo d’Agrippa, quali sono il Diribitorium e il portico di Pola, c’induce anch’esso a ritenere il Campus Agrippae sito ad Ovest della Via Lata. Su ciò invito il lettore a leggere la dotta discussione fattane dal Nardini (Roma Antica l. IV, c. X).
Oltre a questo, nell’anno 1592, costruendosi il palazzo Serlupi-Crescenzi (Via del Seminario), fu ritrovato un cippo enorme di travertino, alto tre metri circa, sul quale era scritto:
ID . QVOD . INTRA
CIPPOS . AD . CAMP . VERSVS
SOLI . EST . CAESAR . AVGVST
REDENTVM . A . PRIVATO
PVBLICAVIT
(C. I. L. VI, 874)
Gli editori del Corpus opinano che questi cippi augustei di Via del Seminario appartengano al Campo di Agrippa; e giustamente, poichè, come appunto noi siamo certi (per la testimonianza di Dione) che Augusto donò al Popolo Romano il Campo di Agrippa, così non possiamo esser certi che il Campo detto dai Cataloghi Marzio, con denominazione generale della pianura fra il Pincio ed il Tevere («Bull. Com.» ann. XI, Sez. 2ª, p. 11), ed a cui il Lanciani opina s’alluda nei cippi, sia stato mai a privato redemptum da Augusto e donato al Popolo Romano. E non possiamo esserne certi, perchè nessun documento ci è pervenuto finora, e finchè esso non apparisca, dovremo ritenere con gli Editori del Corpus, che quei cippi si riferiscono al Campus Agrippae, e che ne costituivano il limite del lato Nord. Nè si obietti che quei cippi si trovano in piena regione VIIII, perchè noi non conosciamo i limiti delle due regioni con precisione tale, da non poter supporre che nella regione VII vi fosse una zona di terreno ad Ovest della Via Lata. Cosa anzi che possiamo con grande fondamento ritener vera per l’eponimo stesso della regione (Via Lata): via detta appunto Lata, perchè il suo margine occidentale era coperto dal Porticus Septorum in modo da formare una larga via, in parte coperta ed in parte scoperta. E questo portico, formando un tutto con i Septa, dovette con ogni ragione appartenere, insieme a quell’area contigua, alla regione VII (Via Lata), e non alla VIIII. Qui è inoltre necessario notare che nella divisione di Roma in quattordici regioni (la quale avvenne, per testimonianza di Dione dopo la dedicazione del Campus Agrippae, e probabilmente dopo la erezione del tempio d’Iside e Serapide), il nome di Campus Agrippae rimase alla parte non fabbricata del Campo stesso, ossia all’area contigua al Porticus Septorum; la quale area, per la ragione anzidetta, dovè nella divisione entrare nella regione VII.
A conferma di quanto si è detto fin qui, è bene osservare che il posto assegnato dal Lanciani e dall’Huelsen al Campus Agrippae, è inaccettabile per più ragioni. Primieramente quella località si trova del tutto separata dalla zona dove Agrippa sviluppò il suo grandioso piano edilizio: cosa riconosciuta dallo stesso Lanciani, il quale, per attenuare questa difficoltà, escogitò un qualche modo d’attacco tra le due aree, supponendo che il grandioso portico (di cui rimangono non pochi avanzi ad Est della Via Flaminia, nel sottosuolo dello sterrato di Piazza Colonna, e che da lui è ritenuto per il Porticus Vipsaniae) fosse stato eretto da Agrippa quasi a far séguito al Porticus Septorum, che sorgeva dalla banda opposta della Via Flaminia, incominciando dalla Via di S. Ignazio e terminando a Piazza Venezia; congiungendo così (il Lanciani) la zona dei grandiosi lavori agrippiniani col Campus Agrippae da lui supposto, per il vertice di un angolo!
Secondariamente poi perchè come asserisce lo stesso ch.º autore (V. «Bull. Com.» ann. XX, serie 4.ª p. 277, quell’area è priva affatto di ruderi monumentali dei tempi augustei). Ecco le sue parole: «La zona confinante col portico e l’acquedotto, cioè la zona fra S. Claudio e il Trivio è affatto priva di ruderi monumentali, nè, per quanto io sappia, tali ruderi sono stati visti o descritti nei tempi andati». — Eppure i residui della vastissima sala del Diribitorio, che, con ogni verosimiglianza (come osserva il Nardini, interpretando le espressioni di Dione Cassio), dovè sorgere nel Campo in questione vi dovrebbero essere! È difficile poter supporre che quell’edificio sia stato abraso fin dal piano dei fondamenti!
Perchè, finalmente, quest’area si trova in quella zona che è l’unico sito della limitatissima regione VII, in cui si possono collocare (come bene scrisse il Nibby) gli Orti Largiani: orti appartenuti probabilmente al celebre Caio Cecina Largo, console ordinario nell’anno 795 d. R., ed autore del Senatus Consultum Largianum sulla successione dei liberti. Ed appunto in quella località a me sembra che vi siano tracce degli orti suddetti. Quel muro, della lunghezza di m. 63, tornato in luce negli ultimi mesi del 1890 nella Via Poli (lungo il fianco della chiesa di S. Maria in Trivio, V. il «Bull. Com. ann. XX,» serie 4.ª, p. 278), come pure gli altri residui di muri a quello coordinati (Lanciani, Forma Urbis), rinvenuti fra Piazza Poli e la Via del Bufalo, non potrebbero essere i resti di un edificio edificato nel III secolo in quella lacinia degli antichi orti Largiani, ridotto poi, da Belisario, o tutto o in parte, a Xenodochio? Gli orti Largiani (osserva il Nibby) dovettero essere in istato di floridezza fin quasi al IV secolo; giacchè essi sono ricordati, a preferenza di tanti altri, nei cataloghi di quei tempi.
Un altro indizio di questi orti è per me la grande piscina alle falde del Quirinale, presso il così detto Lavatore del Papa.
Il portico poi che decorava il lato Est del largo della Via Flaminia (ove più tardi fu eretta la colonna coclide), e che dovè, al pari del largo che adornava, far parte, per ragione di concomitanza, della regione VIIII e non della VII (il limite delle quali, in quel tratto, era segnato dalla via che correva dietro al portico, e che lo separava dagli orti Largiani), io lo crederei il Porticus Argonautarum; perchè, oltre ad essere un vero porticus, la sua costruzione è molto simile a quella del Porticus Septorum, e quindi più propria dei tempi di Agrippa. — Non così possiam dire invece del tempio di Piazza di Pietra, e del suo recinto, perchè essi presentano tali caratteri, da non potersi (come pur anche ritenne il Nibby), portar più oltre i tempi di M. Aurelio Antonino. Tutto ciò poi che è rappresentato nel basamento di quell’edificio nulla ha che vedere con Nettuno; ed aggiungerò che, per la sua forma spiccata di tempio, non potè essere da un autore antico (quale fu Sparziano) chiamato Basilica.
Veduto come l’opinione più plausibile circa il posto occupato dal Campus Agrippae sia quella proposta dal Nardini ed accettata dai compilatori del Corpus, cerchiamo ora di rintracciare il sito dei Castra dedicati da Aureliano in Campo Agrippae. Io opino (e non credo di esser lungi dal vero) che Aureliano riducesse a caserma il Porticus Septorum. E ciò lo ritengo per due ragioni: 1.º perchè non si trova più memoria di quel portico dopo il regno di Severo Alessandro; 2.º perchè quantunque esso fosse celebre quanto gli altri portici e forse anche più, non fu notato negli elenchi dei Regionarî del IV secolo, nè nella regione VIIII nè nella VII: fatti, che manifestano una trasformazione venuta in quel portico al cadere del secolo III, rimanendo notato però negli elenchi, sotto il nuovo nome venutogli da quella, nella regione VII. Ammettere la riduzione di un portico della forma del Porticus Septorum, a caserma, non è cosa che possa recar maraviglia, se si rifletta che quella forma si prestava molto a tale riduzione, e che questa veniva suggerita anche dall’uso che costantemente si faceva di simili portici per l’attendamento provvisorio delle milizie, allorchè queste eran chiamate in città per qualche fatto straordinario. Così avvenne, ad es., nell’eccidio di Galba. Chi non sa che in quel frangente la legione Illirica trovavasi attendata nel Porticus Vipsania? Missus et Celsus Marius ad electos Illyrici exercitus, Vipsanii in Porticu tendentes (Tac. Hist. l. I, c. 31).
La chiesa pertanto «SS. Quadraginta de Calcarario» si trovava a breve distanza dai Castra Urbana di Aureliano.
Del resto, il fatto dell’esistenza di quattro chiese dedicate ai Quaranta Martiri di Sebaste, situate indiscutibilmente presso alloggiamenti militari, sarebbe bastato da sè solo a far congetturare che, in prossimità della chiesa dei SS. Quadraginta de Calcarario, stessero i Castra Urbana.
763. Bulla, Intenta igitur, 1433 — Pont. Eug. anno III.
764. Pag. 160 b.
765. Roma nell’età di mezzo, Tom. I, p. 320.
766. V. Cardella, Memorie Storiche dei Cardinali. Tom. III, p. 208 e 264.
767. Le cinque chiese dedicate in Roma ai Quaranta Martiri di Sebaste, tutte edificate presso cinque alloggiamenti di soldati, dimostrano quanto sia vera la testimonianza tradizionale dei Padri di Cappadocia (contemporanei al fatto con S. Basilio Magno alla testa), che ce li mostra soldati in senso proprio; e quanto male si apponga il ch.º Franchi dei Cavalieri, il quale, dubitando di quella testimonianza, e basandosi invece sul famoso testamento (ritenuto autentico dai moderni ipercritici) asserisce, che quei martiri non si possono dire soldati che in senso figurato. Il testamento fu scritto (secondo il documento) da Melazio a nome di tutti; ma basta leggerlo per dichiararlo apocrifo. Fra le altre bellezze, in esso parlano i morti! È proprio giunto il tempo predetto da S. Paolo: Erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus; et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. (Epist. II ad Timoth. 3-4).
768. V. Mabillon, Musaeum Ital. Tom. II, p. 190.
769. Sulla favola della Papessa Giovanna vedasi il dotto lavoro del Ch.º Prof. Tomassetti, La Storia della Papessa Giovanna — «Bull. Arch. Com.» — an. XXXV, p. 82 e segg.
770. Muri probabilmente delle Tiziane.
771. Pag. 19 nella descrizione del Fabrizi.
772. Le Chiese di Roma 2.ª Ediz. p. 521.
773. Urlichs, Codex Topographicus p. 153.
774. V. Muratori Scriptt. XXIV, col. 1113 (an. 1438).
775. V. Armell., Le Chiese di Roma, ediz. 2.ª p. 521.
776. Roma nell’età di Mezzo, Tom. I, p. 320.
777. Mabillon, loc. cit. p. 190.
778. «Bull. A. Com.» an. XXIII, p. 124.
779. Chiese, ecc., loc. cit., p. 139.
780. Archiv. secr. S.S. Reg. Urb. V, Tom. VIII, fol. 160.
781. Armell., loc. cit. p. 523.
782. Cancellieri, Possessi, p. 121.
783. Il passato topografico e storico dell’Istit. Massimo alle Terme, p. 43 — Roma 1898.
784. V. Bellori, Vita di D. Fontana, e lo stesso Fontana — Dell’Obelisco Vaticano l. II, p. 18.
785. Iter. Ital. p. 76, n. 29.
786. Di alcune fabb. fatte in Roma ed in Napoli, lib. II, Roma 1590, p. 18 — tav. 19.
787. Credenz. IV, vol. 104, f. 11.
788. Loc. cit. 22.
789. Arm. VI, Tom. 52, p. 65.
790. Questa notizia ce la porge il diarista Gigli. Cf. Moroni, Diz. di erud. voc. Colosseo.
791. Armadio XI, tom. 22, p. 222.
792. Il disegno di questo tempietto era stato già fatto dal cav. C. Fontana.
793. Nell’anno 1700.
794. R. Lanciani, Not. inedite dell’Anf. Flavio. Rend. della R. Acc. dei Lincei 1896. Serie V, vol. V.
795. Uno degli archi che guardano Ovest.
796. Diarii.
797. Dissert. apud. Winck. p. 399, vol. III.
798. Mercato, p. 163.
799. Notizie inedite, loc. cit.
800. Anno 1689-1700, foglio 756.
801. «Anno 1714, 10 Dicembre. Decreto sopra la deputazione del sig. D. Girolamo Colonna, in sopraintendente e custode delle chiavi del nuovo recinto fatto nel Colosseo. Credenz. 1, Tom. 39, p. 14. Ma susseguentemente a’ 10 di Gennaio del 1715 ritrovasi la relazione della non inclinante volontà del Pontefice Clemente XI di concedere al Popolo Romano le chiavi del suddetto nuovo recinto. Cred. 1. Tom. 39, pag. 14». V. Marangoni, loc. cit., pag. 105.
802. Marangoni, loc. cit. pag. 98.
803. Visse ai tempi di Benedetto XIII.
804. «Anno 1723, 10 Luglio. Memoriale presentato all’Eccellentissima Congregazione dall’Eremita del Colosseo, e rescritto grazioso facultativo di poter fare una muraglia di clausura dietro la cappella di detto eremitorio. Credenz. I. t. 45, p. 322». V. Marangoni, loc. cit. p. 105. — «Anno 1727. 12 Novembre. Istromento di concessione d’un arco chiuso contiguo e dietro alla suddetta chiesuola o cappelluccia, posta dentro al circuito del medesimo Colosseo, Pietro Doye eremita dello stesso Anfiteatro. Credenz. 4, tom. 101, p. 291». Ibid.
805. V. pag. 215.
806. Una copia di questa epigrafe trovasi affissa sul muro del grandioso contrafforte che si erge dal lato Nord.
807. Roma descritta ed illustr. tom. II, p. 2, Roma Stamp. Pagliarini.
808. Oltre a questo ricordo marmoreo, abbiamo una pittura fatta dal Veith nell’alto dell’ultima lunetta (a destra) del XXX riquadro del Museo Chiaramonti al Vaticano. La pittura «indica il colossale e magnifico sperone fatto innalzare dal Pontefice Pio VII per la conservazione della parte meridionale dell’Anfiteatro Flavio o Colosseo, sotto la direzione dell’architetto Valadier. Nel mezzo è figurata la Religione che sostiene la palma e la croce simboli del martirio, e dinanzi un pellegrino genuflesso». Cav. E. G. Massi: Descrizione compendiosa dei Musei...... nel palazzo Vaticano. Roma, 1887, p. 157, terza edizione.
809. Questo restauro fu fatto in quella parte del Colosseo che guarda Ovest, tra l’Arco di Costantino e la Via Claudia.
810. Roma. A cura della R. Società Romana di storia patria, 1910.
811. Cf. documento XXXII.
812. Poesie di autori Italiani del sec. XIX, Roma 1845.
813. Storia della rivoluzione di Roma 1848-1850, Livorno 1851.
814. Spada, Storia della rivoluzione di Roma, vol. III, p. 396.
815. Vol. II, p. 260.
816. Nella costruzione degli «speroni di Pio VII, Gregorio XVI e Pio IX furono messi in opera gli ultimi massi» dei caduti materiali o travertini. Cf. Notizie e inedite del Ch. Lanciani. Rendiconto della R. Accad. dei Lincei, 1896, serie V, Vol. quinto.
817. V. Gori, loc. cit., p. 112.
818. Atti della Pont. Acc. Rom. di Arch. Tom. XV, p. XXXI.
819. Quest’iscrizione trovasi a piè di quella di cui parlammo a p. 221.
820. Gori, loc. cit. p. 113.
821. Fra i due restauri di Leone XII e di Pio IX.
822. X n. 196.
823. Anno III, 1882, p. 49 e segg.
824. Cf. Lanciani Storia degli scavi, vol. II, p. 83. Anche nel 1639 furono fatte alcune ricerche «nel circuito del Colosseo». (Arch. Capit. Cred. VI. Tom. 52, p. 65).
825. Calp. Eclog. 7, v. 48 e segg. — Cf. Osservazioni sull’Arena e sul Podio dell’Anf. Flavio fatte dal Sig. Pietro Bianchi, di Lugano, Prof. di arch. ecc.... nella sessione dell’Accad. di Arch. li 17 Dicembre 1812.
826. In vita Commodi.
827. Osservazioni sull’Arena e sul Podio dell’Anfiteatro Flavio. Notizie degli scavi. — Roma 1813.
828. Riflessioni pacifiche ecc., Roma 1813.
829. Ammonizioni critico-antiquarie a varii scrittori del giorno. Roma 1813.
830. Roma Ant. Tomo I, app. I, p. 233. Roma 1819.
831. Loc. cit. p. 217.
832. Theatrum magnum undequaque rotundum.
833. Cf. Jordan: Forma 17 b.
834. La mia opinione su questo capitello la manifestai a pag. 35.
835. Cf. Petr. Satyric. cap. IX.
836. Per brevità tralasciamo quanto il Re dice nella sua dissertazione, sembrandoci sufficiente aver riferito le parole che egli applica alle figure 8, 9 e 10 della sua tavola illustrativa di alcune parti della sostruzione in opera quadrata.
837. Di materia solida e stabile.
838. Il pavimento dell’ipogeo in opus spicatum si trova a m. 6,08 dal piano attuale dell’arena.
839. Loc. cit.
840. Nuove osservazioni intorno all’Arena dell’Anf. Flavio e all’acqua che ora la ricopre. Roma 1814.
841. La stampa universale disapprovò queste nuove escavazioni, affermando che gli scavi antecedentemente fatti avean già messo al nudo ogni cosa.
842. Loc. cit. p. 114.
843. In una di queste buche si veggono tuttora residui di legno carbonizzato; delle travi, cioè, che facevan parte delle famose macchine anfiteatrali.
844. Settantasette di questi frammenti furono editi ed illustrati dal ch. Henzen, (V. c. I, l. VI, p. 856 e segg.).
845. Cronach. mens. serie II, Tom. I, p. 46.
846. Qualcuna di queste lastre è di un bel cipollino.
847. Cf. Meier, De Gladiat. Rom. quaest. selectae Bonnae 1881 p. 14 e segg.
848. In un masso di cipollino.
849. V. Suet., Calig. 32. Cic., Pro Roscio Amer. 6. Fabretti, R. De columna Traiana. Roma 1863, p. 151. Sabatier, Description Générale des Medaillons contorniates. Paris 1860, p. 46. In quest’opera il Sabatier pubblica la medaglia di un VRSE, e nella palma vuol riconoscere un flabellum. A me sembra una palma.
850. Cap. in Pert., VIII.
851. E. Q. Visconti, Monum. scelti Borghesiani, Tom. I, Tav. I e II, opina che il ciondolo rotondo sia qui una tessera gladiatoria. Ma queste non erano rotonde, sibbene quadrilatere. Il Prof. Correra (B. C. A. Com. di Roma, Anno XXIII, Serie 4, Fasc. 3) crede quel ciondolo una medaglia; ed aggiunge non poter essere una bulla, perchè trattasi di un atleta.
852. Loc. cit.
853. Correra, loc. cit. p. 201.
854. Gori, loc. cit.
855. F. Gori, loc. cit. p. 122.
856. Gori, ib. Fu anche in questo sterro diretto dal Rosa che si rimosse la croce dal centro del Colosseo e furono abbattute le edicole della Via-Crucis. Varî giornali stimatizzarono quel fatto; e nessuno arrise al progetto ridicolo del Gori, loc. cit. p. 5, il quale consisteva in voler sostituire alla croce la statua della Libertà.
857. Cf. B. della Commis. Arch. Com. serie 4, fase. p. 118 e seg. ann. 1895.
858. G. Gatti, Cf. il cit. Bull. Com. p. 118.
859. In Dom. 4.
860. Spectacula assidue magnifica et sumptuosa edidit non in amphitheatro modo, verum et in circo.... at in amphitheatro NAVALE quoque.
861. Lib. 67, c. 25.
862. Trad. del Nibby, Roma ant. pag. 401-402.
863. De Naumachia. — lib. Spect.
864. Marang. Delle memorie sacre e profane dell’Anfiteatro Flavio, p. 62.
865. Dedit et navale praelium in veteri naumachia: IBIDEM et gladiatores etc. (Suet. in Tito, cap. VII).
866. Indica perfino qual parte: quella, cioè, che riguarda le statue.
867. Memorie storiche del Colosseo, p. 141.
868. Loc. cit. p. 402.
869. Lib. I, cap. XXIX.
870. Epigramma XXVIII del lib. Spect.
871. Dopo il regno di Domiziano.
872. Pompae e Libitinensis.
873. Muniti d’inferriate.
874. Si trova dalla parte del Laterano. Nella Tav. V, le cloache sono segnate in colore bleu.
875. Un tratto di questa cloaca fu scoperto negli scavi del 1874. — È larga m. 0,63 ed alta m. 1,95. — Si dice che pel restauro di questa cloaca furono spese lire 200,000.
876. V. Lanciani, Ancient Rome p. 55.
877. Lanciani, Commentarî di Frontino p. 153.
878. Parte II, cap. VII.
879. V. Cassio p. 73, ove parlando degli archi neroniani scrive: § 10 — «A canto alla strada, continuavano, e ancora ben si distingue essere in piedi un solo, e in qualche distanza altri XIII dei quali nel piegar della strada essendone alcuni rovinati, e perciò interrotta la loro concatenazione, la riassumono VIII intersecata a sinistra la stessa via terminando il loro filo al portone esteriore del vestibolo di S. Stefano (Rotondo) distante dalla porta ed atrio del tempio 82 passi andanti. E qui conviene positivamente avvertire, come più volte si è da me osservato, che degli VIII archi gli ultimi IV più vicini al vestibolo o portone, avevano archi sopr’archi, o dir si voglia sesto col quale grado grado l’un dopo l’altro andavano dolcemente abbassandosi per retta linea verso un grosso pilastro isolato, lontano dal già detto portone e ultimo arco 90 simili passi. Egli è però sicuro (e sarebbe di gran vantaggio l’opposto, perchè gioverebbe al nostro intento senza ulteriori ispezioni) che il numerato spazio di distanza, o per nuove aggiunte di costruzioni, o per la mutazione della faccia del luogo cambiata in orto e vigneto con recinto di nuovi muri è così deformato, che non lascia segni sensibili d’inclinazione degli archi sino al castello, che stava e sta al lato settentrionale dell’isolato pilastro, dove non è da porsi in dubbio che avessero li descritti archi il lor termine; benchè nella metà del già detto recinto vi si vegga altro pilastro verso al quale forse continuavano gli archi la lor dirittura; ma per essere sformato e senza segni di appoggio o incastro d’archi, non mi permette farne certa assertiva, benchè io la stimi assai verosimile. Il pilastro isolato che sta eminente nel fine della piazza tra il circondario di S. Stefano e di S. Maria in Domnica, o modernamente Navicella, è di larghezza 14 palmi nel fianco settentrionale, nell’altezza eguaglia la torre che dicessimo delli Consoli, alla quale corrisponde lo speco che sulla cima di questo e di quello si scopre, a livello d’altro dei VII archi posteriormente piantati oltre alla torre sul limite degli orti o vigneti dei Ss. Gio. e Paolo, conceduti dal Pontefice Clemente XI alli PP. Missionari. Nella metà dello stesso pilastro appariscono ad oriente vernale, e a ponente gl’incastri degli archi rovinati. A settentrione, siccome sopra accennammo, v’è un sito riquadrato di larghezza uniforme al pilastro, nel quale senza dubbio era alzato il ricettacolo o fosse castello, in cui separatamente calavano le acque portate dagli archi provenienti dal vestibolo di S. Stefano, e si distribuivano con tubi in diverse parti del quadrivio di quella piazza (de’ quali tra poco) perchè vi sta il chiusino a volta con telaro di bianco marmo per sostenere la quadrata consimile pietra: indizio che nella chiavica interiore vi si custodissero li tubi e fistole o di piombo o di creta.......»
A p. 68 scrive: «Scorsi 43 anni, cioè nel 762 corrispondente al 9 dell’e. v. eletti consoli P. Dolabella e C. Junio Silano trovati fatti gli acquedotti di queste due acque da M. Agrippa oppur risarciti, per risoluzione del Senato condussero dall’antica porta Esquilina (o forse dal sito in cui si vede oggi la Taurina ossia di S. Lorenzo) al monte Celio, e di colà all’Aventino l’acqua Marcia e al Palatino; e per farne alli nominati colli la divisione, in distanza del castello (che tuttora si vede sul quadrivio della piazza della Navicella non più di 30 passi andanti) piantarono un arco composto di tivertini (sic) accanto al sito in cui fu poscia eretto lo spedale e chiesa di S. Tommaso apostolo, denominato per le molte forme o condotti che vi passavano, S. Tommaso in Formis......»
A p. 76 § 14 prosegue: «Più ancora si assicura l’esistenza di questo castello sin dal tempo di Nerone, che per formar l’ampio stagno o piscina al fianco orientale dell’aurea sua casa, seccato ed atterrato da Vespasiano per erigervi l’ammirabile Anfiteatro..... vi condusse un grosso rivo dell’acqua Claudia, della quale si vede tuttavia il gran condotto sotterraneo che scende sotto al chiusino per retta linea nella strada per cui si va al lato orientale dell’Anfiteatro, nella di cui vicinanza dove ha principio lo stradone che guida a S. Gio. Laterano apparisce la superficie della volta dello stesso condotto, che poco più oltre andava a sboccare nello stagno. Tal condotto fu pure ammirato dal nuovissimo autore delle memorie del medesimo Anfiteatro (Marangoni), ma non capito, perchè non salì sul quadrivio del Celio a vederne l’origine e il suo progresso».
880. Commentarî di Frontino, p. 158.
881. Secondo la quantità d’acqua che vi avranno fatto affluire.
882. Xiphil. e Dione — p. 542 ed. Basileae.
883. Osservazioni sull’arena e sul podio dell’Anfiteatro Flavio fatte dal sig. Pietro Bianchi di Lugano architetto..... illustrate e difese da Lorenzo Re romano..... nella sessione dell’Accademia di Archeologia li 17 Decembre 1812.
884. Loc. cit., p. 130, § 2.
885. Loc. cit. p. 141.
886. De Naumachia.
«Augusti laudes fuerant committere classes,
Et freta navali solicitari tuba;
Caesaris haec nostri pars est quota? vidit in undis
Et Thetis ignotas et Galatea feras.
Vidit in aequoreo ferventis pulvere currus,
Er domini Triton ipse putavit equos.
Dumque parat saevis ratibus fera praelia Nereus,
Abnuit in liquidis ire pedester aquis.
Quidquid et in Circo spectatur et in Amphitheatro,
Dives Caesarea praestitit unda tibi.
Fucinus et pigri taceantur stagna Neronis
Hanc norint unam saecula Naumachiam».
887. Fino all’altezza di m. 1,70 circa, quantità necessaria a sostenere le barche.
888. Il quale, chiudendo lo speco, potevasi mantenere sul pavimento dell’arena inondato, per quel tempo che si voleva.
889. De Naumachia.
890. Domitianus Imp... Amphitheatrum usque ad clypea.
891. Tom. II, p. 49.
892. In questo stesso Museo (Iº Riquadro n.º 2) si conserva «Apollo sedente, figura di bello stile, trovata al Colosseo nel 1805». Cf. Descriz. compendiosa dei Musei.... nel Palazzo Vaticano.... E. G. Masi, 1887.
893. «Il modo d’indossare la penula che lascia libera l’azione delle braccia e della persona, propria perciò de’ viaggiatori e degli araldi, vi fe’ riconoscere un’imagine di Mercurio. Per tale fu restaurata coll’adattarvi una testa rinvenuta nel Colosseo nell’anno 1803, aggiungendovi il braccio sinistro col caduceo». E. G. Masi, loc. cit. p. 111.
894. Queste leggi sono state estratte dalle Sentenze di Paolo.
895. Cf. le opere del prof. A. Profumo, e specialmente il suo recentissimo opuscolo L’incendio di Roma dell’anno 64 (Feltre, Tip. Panfilo Castaldi, 1909). — Tacito dichiara l’incendio «forte an dolo Principis incertum». Il ch. Profumo (loc. cit. pag. 20 e segg.) tratta magistralmente questa questione.
896. «Abolendo rumori subditit reos et quaesitissimus poenis affecit quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos (sic) appellabat». Tac. (Ann. 15, 38-44). Il lodato Profumo (loc. cit.) prova ad evidenza che «le ipotesi che alcuni critici sogliono proporre in sostituzione per l’auctor (di Cristiani, di Ebrei, ecc. ecc.), sono: dal lato documentario, campate in aria; — dal lato critico, nulle, poichè fuori delle sole due versioni (forte an dolo Principis) che l’evo ha conosciuto. Mi duole, soggiunge, che ricada in questa categoria la ipotesi subordinata dell’Hülsen; quella di una comparticipazione di Cristiani con gli uomini che attizzavano in qualche modo l’Incendio. Le nostre cinque fonti (Plinio, Stazio, Suetonio, Tacito e Dione) non ne fanno motto; gli apologisti Cristiani posteriori non debbono mai difendersi, fra le tante e tante, da una simile anche parziale accusa, che sarebbe riuscita nell’Evo, per concetto della sacra Roma, gravissima; nè ve n’è traccia neppur minima nei frammenti anticristiani a noi giunti: quel silenzio generale e costante, adunque, che caratterizza la non rispondenza dell’ipotesi col pensiero dell’evo, e pagano e cristiano. Resterebbe il famoso XV, 44, di Tacito su quel primo gran processo o gruppo di processi ai Cristiani, ch’è dallo storico collegato all’incendio. Esso è molto oscuro. Nel mio lavoro (Le fonti ecc.) ne ho proposta una soluzione: — assenza totale di processi ad incendiari, e pagani e cristiani; gran processo, o processi, d’indole politico-morale ai Giudaici «quos per flagitia invisos vulgos Christianos appellabat», poichè per questa attiva propaganda ebraica (Cfr., p. es., Flavio Gius., in Guerra Giud., I, pr. 2) ormai la questione Giudaica preoccupava l’animo romano per la sicurezza delle Provincie dell’Oriente; ed infatti, l’anno dopo, il 66, s’inizia la definitiva campagna militare, con la distruzione di Gerusalemme a supremo intento. Un processo a dei Giudaici malvisi in Roma dal volgo, detti Cristiani, era quanto di meglio si potesse escogitare in quei giorni, ad abolendo rumori sul dolus Principis».
897. Il Trastevere e la Porta Capena.
898. S. Giustino il Filos. Dial. con Trifone II. 17.
899. Origene, Contr. Cels. lib. VI, n. 27.
900. Suet. in Nerone, c. XVI.
901. Tac. Ann., XV, 44.
902. Tert., Apol. cap. I, in fine. Tertulliano chiama Nerone dedicatore damnationis nostrae.
903. Epist. prima.
904. Plin. secund. Epist. lib. X.
905. Cf. Sulpiz. Sev.
906. Sebbene talvolta sotto qualche Imperatore, o per il suo carattere naturalmente mite, od anche per noncuranza, quegli editti siano stati applicati meno frequentemente.
907. Ap. Lactant. Divinae institutiones l. V, c. XI.
908. L’Anf. Flavio rivendicato ai Martiri, p. 27.
909. Lattanzio visse un secolo prima del riordinamento della legislazione romana, fatto da Giustiniano.
910. Cf. Pothier. Le Pandette di Giustiniano riordinate, Vol. I, Venezia 1833, pag. 103, numero 2.
911. De fuga in persecutione c. IV, XII, XIII. — Ad uxorem l. I, c. 3.
912. Contra Celsum, l. VIII, ed. Cantabr. p. 406.
913. Epist. l. IV, ad Cornelium, § 4.
914. De Ss. Martyribus Bernice, Prosdoce, § 4. Cfr. il Processo Verbale del 17 Luglio 180, scoperto nel 1890. — Apologisti Cristiani. Casa editrice Dott. F. Vallardi, Milano 1907.
915. Apolog. cap. XXXIX.
916. Dig. l. XLVIII, tit. XIX, l. 31.
917. Dig. l. XLVIII. Tit. IX-XIX. Cf. Cic. Orat. pro Roscio 26.
918. Passio S. Pionii 21 acta sincera, Ruinart, n. 4, p. 136 et seqq.
919. Passio S. Perpetuae 19. Edit. Arm. Robinson, Cambridge 1891, pp. 89-90.
920. Ruinart, Acta sincera.
921. Bull. di Arch. sacra 1879, p. 21.
922. Acta § 6 apud Acta sanctor. Ianuar. tom. I, p. 569.
923. S. Paolo ad Rom. c. XVI, dal v. 3 al v. 15.
924. Lez. di Arch. Crist. p. 6.
925. De l’authenticité des Annales et des histoires de Tacite, Bordeaux 1890.
926. Apol. c. XXXVII.
927. Le sillogi epigrafiche di Tours, di Closterneubourg e di Göttwel ci hanno conservato un’iscrizione preziosa degli inizi del secolo V; la quale, mentre ci ricorda i grandiosi restauri fatti da Sisto III (432-440) nella basilica Liberiana, fa pur menzione di cinque martiri (V. Grisar, Roma alla fine del mondo antico pag. 303 nota 2ª) e dei cinque simboli del genere di morte da essi subìta. Il terzo di questi simboli è precisamente la damnatio ad bestias. Ecco il testo dell’iscrizione:
VIRGO MARIA TIBI SIXTVS (sic) NOVA TEMPLA DICAVI
DIGNA SALVTIFERO MVNERA VENTRE TVO
TE GENITRIX IGNARA VIRI TE DENIQVE FETA
VISCERIBVS SALVIS EDITA NOSTRA SALVS
ECCE TVI TESTES VTERI SIBI PREMIA PORTANT
SVB PEDIBVS IACET PASSIO CVIQUE SVA
FERRVM FLAMMA FERE (sic) FLVVIVS SAEVVMQVE VENENVM
TOT TAMEN HAS MORTES VNA CORONA MANET
«Di tale prezioso carme rimase superstite soltanto il primo verso fino al sec. XVII; e questa reliquia pure venne cancellata in seguito agli inconsulti restauri eseguiti a spese del card. Pinelli». P. Sisto Scaglia, Mosaici antichi della bas. di S. Maria Maggiore in Roma. Roma, F. Pustet, Editore, 1910.
928. Notiones Archaeolog. Christ. Cap. II, p. 176, Romae 1908.
929. Corpus antiq. rom. absolutissimum p. 440.
930. Cf. G. B. Lugari, loc. cit. p. 9.
931. The ruins and excavations of ancient Rome p. 283.
932. Loc. cit. p. 10.
933. Proc. Della Guerra Gotica l. I, c. XXII, XXIII.
934. Qui il Lugari (loc. cit. p. 11 dell’estratto o p. 113 delle Dissert. della Pont. Accad. Rom. di Arch. serie II, Tom. VII) in una lunga nota dimostra che l’anfiteatro Castrense era capace di contenere il numero sufficiente di belve per gli spettacoli ordinarî; ed indica il sito ove poterono esservi le abitazioni per i militi del vivario e per i serventi.
935. Lanciani, The ruins and excavations of ancient Rome, p. 388.
936. Ficoroni, Le vestigia di Roma antica, p. 121.
937. Nardini, Roma antica, tom. II pag. 17 ediz. de Romanis.
938. Lucius Faunus, De antiq. urb. Romae, lib. I, p. 13 — Pomp. Let. De antiq. urb. Romae, lib. VII, pagg. 234, 235 — Marliani, Urb. Rom. Topogr. lib. VII, p. 134.
939. Id., loc. cit., Pomp. Letus, loc. cit., Marliani, loc. cit.
940. Bufalini, La pianta di Roma, tav. A, 2 ediz. 1879.
941. Nota di ruderi e monumenti antichi per la pianta del Nolli, edita dal De Rossi, p. 19.
942. Suet. in Calig. cap. IX.
943. V. Nardini, Rom. ant. l. IV, c. II, p. 15; Nibby, Roma, parte I ant. p. 397.
944. Suet., in Tib. c. LXXII.
945. Id., in Claud. c. XXI.
946.
PRO S. M. ANTONII. GORDIANI. PII
FELICIS. AVG. ET TRANQVILLINAE. SABI
NAE AVG. VENATORES IMMVNES. CVM CV
STODE VIVARI. PONT. VERVS. MIL. COH.
VI. PRAE. CAMPANIVS. VERAX. MIL. COH. VI
PR. FVSCIVS. CRESCENTIO. ORD. CVSTOS
VIVARI. COHH PRAETT. ET. VRBB.
DIANA. AVG. D. S. EX. V. P.
DEDICATA XII KAL. NOV.
IMP. D. N. GORDIANO. AVG. ET. POMPEIANO. CS.
Corpus, I L. VI, 130.
947.
948. Suet., in Claud. c. XXI.
949. Id., in Claud. loc. cit.
950. Dio. LIX, cap. X.
951. Dio. p. 709, Ed. Leunel.
952. V. Verona illustr. Milano 1826, p. 49.
953. Variar. l. 4.42.
954. loc. cit. lib I, cap. IV.
955. Di qui si vede con quanta saggezza il ch.º H. Grisar (Roma alla fine del mondo antico p. 174) abbia scritto: «È certamente fuor di questione che l’ANFITEATRO FU SPETTATORE DI MOLTI MARTIRII».
956. Cf. P. Delhaye, Anacleta Bolland. tom. XVI pagg. 209 e segg. ann. 1897.
957. Il Grisar (loc. cit.) dice a questo rispetto: «Testimonianze sufficientemente sicure comprovano che quest’edificio (il Colosseo) fu spettatore della passione di S. Ignazio antiocheno, ma se si tratta di enumerare altri determinati campioni della fede che a lui dovrebbersi unire nella storia delle persecuzioni, allora il giudizio dello storico soggiace a molte difficoltà, la principale delle quali è che gli Atti ove parlasi di tali martirii romani, non sono relazioni genuine del tempo delle persecuzioni, ma pie leggende messe assieme nel quinto e sesto secolo, se non più tardi, le quali di solito contengono anacronismi ed inverosimiglianze..... Talora però nei prefati documenti il martirio avvenuto IN QUESTO LUOGO è ricordato CON TALI CIRCOSTANZE DA DIMOSTRARE che quel dettaglio fu tramandato IN FORMA SICURA».
958. V. Parte III, cap. 1º.
959. Cfr. p. 98.
960. Fea, Miscell., Tom. I; Bartolini, Sugli Atti di S. Agnese, p. 110; M. Armellini, Il Cimitero dì S. Agnese, p. 10.
961. Bellori, Vestigia Vet. Rom. Tab. XXVIII.
962. Roma Subterr. l. III, c. XXII, p. 602.
963. Cf. Mazzucchelli, Scritt. Ital. Tom. II, part. II, p. 703. — Tiraboschi, Storia della letteratura italiana. Tom. VIII, l. 3, p. 289. Ed. Rom. — Comolli, Bibl. architettonica, vol. II, p. I, clas. I, pp. 58-59-60-61.
964. Apud Petrum de Cortona e schedis Ptolomei, Muratori, Tom. IV, p. 1878, n. 4.
965. Reinesio, Col. XX, p. 249.
966. Bonada, Col. X, n. 36.
967. Fleetwood, p. 351.
968. Lam, De E. A. p. 203.
969. Mamachi, Tom. I, pp. 415-421-422.
970. Bianchini, Hist. Eccl. Tom. II, saec. I.
971. Mabillon, Musaeum Ital. Tav. I, n. 54-213-418.
972. Marangoni, Mem. sacre e profane dell’Anf. Flav., ed. 2, p. 271.
973. Venuti, Accurata e succinta descriz. delle antich. di Roma, part. I, c. I, p. 51.
974. Orsi, Storia Eccles. ediz. rom. 1835, Tom. I, p. 22.
975. Apud Mai Script. Vet. Nov. Coll. Tom. V, p. 380.
976. Mazzolari, Sacre Basiliche, p. 300.
977. Magnan, Le Ville de Rome, Tom. IV, col. 16.
978. Terribilini, Mss. Cas. XX, XI, Tom. VIII, p. 371.
979. Loc. cit.
980. Visconti, Sposizione d’alcune antiche iscrizioni crist. Atti dell’Acc. Rom. di Arch. 1823, Tom. II, p. 629.
981. Nibby, Rom. ant. e mod. part. I, Tom. I, p. 101.
982. Canina, L’Architettura Romana, part. III, p. 148.
983. Note al Venuti sull’op. cit., p. 59.
984. O’ Reilly, I Martiri del Colosseo, p. 41.
985. Giampaoli, Rel. storica del nuovo prosp. di S. Pudenziana, p. 21.
986. Fabio Gori, loc. cit. p. 11.
987. Eccettuato il Giampaoli, il quale nella sua opera: Memorie delle catene di S. Pietro, p. 25 mutò di parere, e si unì a quelli che dichiararono falsa la lapide.
988. De Rossi, Musaici cristiani, fasc. XXIII (Musaico della nicchia della Confessione Vaticana).
989. Tomasetti, Breve itin. di Roma, p. 86.
990. Promis., Gli Architetti e l’Architettura presso i romani, Mem. storiche, Serie III, Tom. 27. p. 146.
991. Armellini, La Chiesa di Roma, ediz. 2, p. 161.
992. Analecta Bolland. Tom. XVI. p. 216.
993. O. Marucchi, Elements d’Archeologie, Tom. III, p. 285. Id. La Forum Romaine 1903, pag. 259.
994. Histoire de Rome etc., Vol. I, p. 182.
995. Storia universale della Chiesa, ed. XI, Torino 1904, vol. II, p. 790.
996. Historia critica, Ecclesiae Cattolicae, vol. I, p. 635.
997. P. Scaglia, Notiones Archaeol. vol. I, pars-prior. p. 418.
998. Nel sotterraneo di questa (Chiesa), e precisamente nella crociera a mano dritta, v’è l’iscrizione cristiana, dalla quale può rilevarsi che Gaudentius, un cristiano, fu l’architetto dell’Anfiteatro Flavio e che fu martirizzato. Tomasetti, loc. cit.
999. Lo stesso si dica del Martigny e del Cabrol. V. i loro rispettivi Dizionarî, v. Colisée e Amph. Flav.
1000. Inscript. Christ. Tom. I, p. 26.
1001. Comolli, Bibl. vol. II, p. I, class. I, p. 51.
1002. Vedi P. I, c. III, di questo lavoro.
1003. Cf. Bull. Serie III, an. I, p. 135.
1004. M. Armellini, Scoperta della cripta S. Emerenziana, ecc. p. 109.
Qui furono le signore: Portia Gabrielli, Maddalena Tassi Varesi, Caterina, Giulia et Lavinia suoi figli il Venerdì Santo l’anno 1635. Cavando Evangelista Bucci. Vi sono anche altri nomi e date degli anni 1634 e 1670.
1005. De Rossi, Bull. di A. S. Serie III, an. I, p. 136.
1006. Id., loc. cit.
1007. Un falsificatore può determinarsi a far incidere una lapide, 1º per esser lodato quale scopritore fortunato di un’iscrizione interessante; 2º per far trionfare una sua opinione; 3º per lucro, e in tutti i casi, coll’animo pravo d’ingannare i posteri. Ma noi, come vedremo, non troviamo neppur uno di questi motivi per dichiarare la nostra lapide falsa.
1008. Maffei, Arti criticae lapidariae libr. III. c. II, p. 159 e segg.
1009. Così ad es.: la collezione di lapidi cimiteriali del sotterraneo della Chiesa dei SS. XII Apostoli.
1010. Bull. serie III. an. I, p. 95.
1011. «Poichè l’arte aveva creato variazioni (dipinti in Priscilla, titoli in marmo nel coem. maius ostrianum); troviamo che fin dal più antico periodo delle Catacombe romane si possono distinguere un tipo di scrittura priscilliana ed uno ostriana». Cf. Kaufmann Manuale d’A. C. p. 172.
1012. Epitaph. S. Severae p. 77.
1013. Il comm. O. Marucchi (V. Le Forum Romaine, p. 259. Ediz. dell’anno 1903), dopo aver detto che l’iscrizione di Gaudenzio è una grossière contraffazione moderna; che il suo stile strano, è assai differente dallo stile antico, che la forma stessa dei caratteri tradisce la sua origine; e dopo aver espresso il desiderio che l’Accademia di S. Luca si decida a porre almeno un’indicazione per prevenire i visitatori di questa falsificazione, aggiunge (in nota) che ha saputo dal Bacci esservi nel rovescio un’iscrizione cristiana antica, che dice: Augurina in pace.
Rispetto il parere del ch.º Professore e amico, ma, a mio giudizio, l’Accademia di S. Luca ha fatto molto bene a lasciare la lapide nel sito in cui si trova da tre secoli; ed anche a non mettervi indicazione di sorta, almeno fino a che non si sappia con ogni certezza la falsità della stessa. La notizia che il Bacci ha dato al ch.o Marucchi, dell’essere cioè questa lapide opistografa, non è nuova, perchè l’Aringhi, il Fletwood, il Marini, il Visconti, ecc., ce l’avevano già detto; la formola poi, non è Augurina in pace, ma: AVRELIA AVGVRINA HIC EST. L’iscrizione è incisa nel mezzo del lungo e stretto marmo; è intiera, e si estende da una estremità all’altra del marmo o tavola marmorea, in questa guisa:
AVRELIA ❦ AVGVRINA ❦ HIC EST
La frase HIC EST, senza l’aggiunto POSITA (il quale, d’altronde si sottintende) è classica, e rivela quanto sia antica.
Taluno potrebbe dubitare della cristianità di questa lapide, appunto perchè classica. Se si rifletta però alla provenienza, e al fatto che l’iscrizione è incisa su di una lastra marmorea di assoluta forma cimiteriale cristiana, ogni dubbio svanisce. L’Aringhi (loc. cit.) congettura che quell’Aurelia Augurina cui si riferisce l’epigrafe, possa essere l’uxor di Gaudenzio, perchè, dice, uxores olim cum viris eodem sepulchro illatas fuisse novimus etc. — Potrebbe essere. I nomi sono antichissimi: un T. Aurelius Fulvus, per es., fu console ordinario imperando Domiziano (a. 85 d. C.); Augurinus è dei tempi della repubblica. I loculi bisomi poi, ed esempî analoghi d’iscrizioni opistografe, relative ai due coniugi, non è cosa nuova agli archeologi.
1014. Cf. M. Armellini, Lez. di Arch. Sacra, pp. 270-271; De Rossi, Bull. Arch. crist., serie III, an. VI, pp. 70-71-73.
1015. P. Scaglia, Epig. Vol. II, c. II, p. 52.
1016. De Rossi, loc. cit.
1017. Lupi, loc. cit.
1018. Id., loc. cit., p. 17.
1019. Bull., serie III, an. I, p. 95.
1020. Bull., serie II, an. VI, p. 58.
1021. Id., serie III, an. I, p. 137.
1022. Id., loc. cit., p. 135.
1023. Si adduce anche la difficoltà degli apici o punti, come qualcuno li chiama. Ma non è, come vedremo, obiezione insormontabile.
1024. Storia di Roma, ed. Desclée, etc. Roma alla fine del mondo antico p. 174. Roma 1908.
1025. Relativamente alla paleografia, gli scrittori che han giudicato la lapide dagli esemplari che generalmente si trovano sui libri, non hanno del tutto torto. L’hanno fatta irriconoscibile! Ognuno abbondò in sensu suo. Perfino han posto sulla vocale I i punti rotondi. Cf. P. I, c. III di questo studio.
1026. E la copia fatta dal Grimaldi sarà esatta?
1027. Non è dunque certo che avvenne allora.
1028. Dunque quelle due lapidi fanno eccezione alla regola. Dunque si dànno eccezioni!
1029. Non è dunque del tutto certo.
1030. E fecero male; ma peggio ancora fanno quelli che mettono sugli I i punti ROTONDI. Qui sta l’errore!
1031. E ciò è verissimo, nè noi diremo essere accenti.
1032. Come il Mommsen (c. I, l. X, 6524) credè potersi liberare dall’imbarazzo in cui lo pose il Garrucci relativamente all’iscrizione Furfonense, di cui tra breve parleremo.
1033. Zaccaria, Ist. lap. p. 388, edit. rom.
1034. Pag. 82, N. Z.
1035. Epit. S. Severae, p. 129.
1036. Marmor Pisan.
1037. Ma questa di Pisa, citata dal Zaccaria (Istit. lap. p. 338, ed. Rom.), non ha i punti (Bormann C. I, L. XI, 1441).
1038. C. I, L. X, 6524.
1039. Sylloge Inscript. Lat. p. 290. Aug. Taurin. MDCCCLXXV.
1040. Loc. cit.
1041. Vol. I, tav. XII.
1042. Oltre a ciò il falsificatore del sec. XVII avrebbe usato punti tondi, mai triangolari. Del resto esistono parecchie iscrizioni dei tempi di Urbano VIII; eppure sull’I non v’è punto di sorta.
1043. Lo stesso Cabrol (Dictionnaire D’Archéologie chrétienne, voce Amphithéatre, col. 1653, Paris, 1904), l’ha riprodotta in caratteri comuni e senza apici.
1044. Anche ammesso che il musaicista al rifare l’iscrizione «Ego sum via, veritas et vita» avesse aggiunto arbitrariamente i punti sugl’I, non per questo l’iscrizione sarebbe falsa, ma una riproduzione genuina e verace dell’iscrizione primitiva. A tutti nota è l’iscrizione damasiana che dice: HIC HABITASSE PRIVS, etc. I due primi esametri di questo carme si leggono nel sepolcro apostolico dell’Appia, e sono una riproduzione fatta nel secolo XII. Ora se le sillogi, e specialmente il codice di Einsiedeln, non ci avessero conservato quel carme, la critica moderna avrebbe ritenuti quei due esametri per una falsificazione di quel secolo. Eppure è una riproduzione genuina!
1045. Loc. cit. p. 146.
1046. Ripostigli, p. 198.
1047. Ann. Inst. XII, p. 241.
1048. Intorno ad alcuni monumenti antichi esistenti al IV miglio dell’Appia. Roma 1882, pagina 63.
1049. De Rossi, Bull. Archeol. Anno I, pp. 23 e 50.
1050. M. Armellini, Lez. ecc. 101. «Col 426, egli dice, la sepoltura cessò nei sotterranei e incominciò nei portici e intorno le basiliche ma fuori del tempio, onde S. Gregorio Magno, come narra nel l. IV dei dialoghi, ricorda che i portici del Vaticano si trasformarono in cimiteri.... Lo splendore delle nostre necropoli ebbe un crollo spaventevole quando dopo caduta nel 410, di memoria imperitura, la regina del mondo in mano di Alarico».
1051. O al più nel secondo decennio.
1052. Cf. P. Scaglia, l. c., p. 52. Questo stesso ch. scrittore a p. 10, dice: De forma litterarum nihil dicendum, nisi quod eadem est atque in ethnicis epitaphiis, sed MULTO DETERIOR propter lapicidarum imperitiam.
1053. Fabbretti, Inscript., c. V, p. 363.
1054. Maffei, Art. crit. lap. l. III, c. II, p. 175.
1055. Morcelli, De stil. Inscript., l. II, part. 3, c. IX, p. 462, vol. 2.
1056. Cf. Garrucci, Sill. Inscript., p. 52, 75, 86, 88, 91, 92. — Pizzamiglio, Storia della Moneta Rom.
1057. Garrucci, loc. cit., pp. 185-192, 215.
1058. Cf. Bruzza, Bull. dell’Ist. Arch., an. 1870.
1059. Dissert. VIII, p. 164.
1060. Inscript. Christ., Tom. I, p. 114, p. V.
1061. Scaligero, Cf. Red. var. lect., c. XIX, not. ad lib. V, Varr. de ling. lat.
1062. Cf. Specimen., p. 56.
1063. Cf. Cenot. Pis., dis. IV, quest. 2.
1064. Cf. Epit. S. Severae, p. 183.
1065. Pag. 138.
1066. Cf. Instituzioni, l. II, c. XI; p. 320.
1067. Cf. Fabretti, Inscript., p. 110, vol. V, p. 541, n. 278. Bull. A. C. Tom. III, pagina 151 ecc.
1068. P. G. Marchi, Monumenti delle arti crist. primit., p. 116. Roma 1844.
1069. Gruter, p. 553, n. 2.
1070. De Rossi, Bull. Arch. crist. an. III, p. 12.
1071. Marangoni, App. agli atti di S. Vittorino, p. 168.
1072. Grut., loc. cit.
1073. De Stil. Inscript., l. III, p. III, c. VIII.
1074. Pag. 49.
1075. Arv. p. 37.
1076. Orig. I, XX.
1077. Graffiti di Pompei, p. 47.
1078. Grut., 1019, 4.
1079. Murat., 918, 2.
1080. Loc. cit., lib. III, c. II, p. 172.
1081. Cf. Civiltà Catt., Serie IX, Vol. XII, p. 718, § 2. V. anche il P. Scaglia, Not. archeol. crist. Vol. II, pars prima. Epigrafia, pp. 8-9, il quale, dopo avere riportato un po’ di errori più comuni nelle epigrafi, aggiunge: integrum possem librum replere idiotismis et erroribus omnimodis....
1082. Hist. nat., l. XXXV, c. IX, in fine.
1083. Storia della Lett. Ital. Tom. I, p. 8, ed. Napol.
1084. Cap. XVII, p. 37.
1085. Loc. cit.
1086. Liv. lib. I, 28.
1087. Garrucci, loc. cit., p. 166.
1088. Varr. l. VI, de l. l.
1089. Fabbretti, Inscript.
1090. Nibby, Analisi ecc. Tom. III, p. 141.
1091. Zaccaria, Instit. p. 187; Bull. dell’Ist. 1865, p. 84.
1092. Bull. dell’Ist., 1860, p. 258.
1093. Id., 1868, p. 228.
1094. Inscript. Christ., Tom. I, p. 112.
1095. Ammessa la genuinità della lapide, si dovrà pur ammettere, come vedremo, che Gaudenzio fu l’architetto del Colosseo.
1096. Supponendo che fosse già cristiano.
1097. Tale infatti fu l’idea primitiva, come dice Marziale:
Hanc unam norint saecula naumachiam.
1098. Memorie storiche del Colosseo, p. 23, ed. 2.ª
1099. Note al Venuti, Roma Ant. Venuti-Piale, Descriz. topogr. di Roma, 1824, tom. I, p. 51.
1100. Dio., l. LXVII.
1101. Anche tralasciando l’indizio estrinsico della forma della lapide, che è cimiteriale; anche prescindendo dalla testimonianza degli scrittori, coevi al rinvenimento di essa, i quali dicono che fu tratta fuori dal cimitero di S. Agnese; le parole Kristus, etc., dichiarano apertamente la cristianità di Gaudenzio.
1102. Xiph. e Dione, Traianus, p. 553, Ed. Basileae apud Joannem Oporinum.
1103. Dopo quello del Panvinio e dell’Iansoni, un catalogo molto ragionato e stimato fu pubblicato dal Contelori, ed un altro, ancora più accurato, dal Corsini.
1104. Loc. cit.
1105. V. Parte I, c. III di questo lavoro.
1106. Vitr., Praef. I. VII.
1107. Plinio, l. VII, c. XXXVII. Vitr., l. c.
1108. Lib. VI, c. XXXVII.
1109. Lib. XXXVI, c. XIII. Laberinto italico. Monumento sepolcrale di Porsenna re di Chiusi. V. Less. ragionato. Lübker.
1110. Suida. Plinio l. XXXVI, II.
1111. Xiph., in Adr.
1112. Vitr., l. c.
1113. Spart., in Adrian.
1114. Lib. VIII.
1115. Lib. IX, epist. XXXIX.
1116. Plinio XXXIII, c. XV.
1117. Epigr. LVI, l. VII.
1118. Loc. cit.
1119. Ad esempio S. E. il Card. Lugari e il suo fratello Cav. Bernardo, ambedue membri ordinari dell’Accademia Romana di Archeologia e notissimi per loro dotte pubblicazioni archeologiche.
1120. V. Forcellini, voce Theatrum: de quocumque loco ad edenda spectacula apto.
1121. Che i liberti servissero agli imperatori, anche come architetti è certissimo, e si deduce da parecchie lapidi sepolcrali: Cf. c. I. l. VI, 8722, 8724.
1122. Venuti-Piale, Descriz. top. di Roma. Tom. I, p. 51. Roma 1824.
1123. Il De Rossi, già si avvide che i martirologî omettono martiri rivelatici dalle iscrizioni (V. Bull. Arch. Crist. An. 1876, p. 59; 1877, pp. 109-113; 1878, pp. 12-94-95; an. 1883, pp. 151-152-155; 1886, pp. 26-28, ecc.).
1124. Cf. Migne, P. L. vol. 124, p. 31.
1125. Quel Passio e quell’S sono certamente del tempo in cui visse il trascrittore.
1126. De lingua latina, l. IV.
1127. Cf. Jordan., Topog. Varr. l. l., V, 49, 50, pp. 601-602. Oppius mons princeps Esquilis, cis lucum Fagutalem.... Oppius mons terticeps, cis lucum.... Oppius mons quarticeps, cis lucum.... in figulinis est. Cespius mons quarticeps cis lucum Poetelium, Esquilis est.
1128. Il primo le Coniectanea, gli altri due le annotazioni ed emendazioni.
1129. V. Nibby, Roma Antica, Tom. I, p. 21.
1130. I boschi sacri dell’antica Roma. Estratto dal «Bullettino della Com. arch. comunale», fasc. II, an. 1905, p. 14.
1131. Nel documento seguito dai dotti passati, fino alla metà del secolo scorso, effettivamente non manca, ed oh quanto è più conforme alla topografia locale!
1132. Loc. cit., l. IV.
1133. Varron. loc. cit.
1134. Del suolo fisico di Roma, ecc. Cosenza, Tip. di Giuseppe Migliaccio, 1869.
1135. Così negli Argei secondo Varrone.
1136. La mia opinione circa le «velocia munera» la manifestai alla Parte II, cap. I, di questo lavoro.
1137. Antich. di Roma, vol. I, l. III, p. 94.
1138. È certo però che al settimo miglio della Via Salaria vi fu una chiesa dedicata all’Arcangelo Michele; le parole dell’Epitome libri de locis Sanctorum Martyrum, sono chiare: «Per eandem quoque viam venitur ad ecclesiam S. Michaelis septimo milliario ab urbe;» ma è pur certo che varie furono in Roma le chiese dedicate a questo Arcangelo, come: S. Arcangelo ad Elephantum, in Palliano, inter nubes, in Augusta, in Laterano, in vico Patricio, in Via Appia, ecc. (Cf. Nuov. Bull. di Arch. christ. 1910, pag. 84 e segg. «Studio sulla nuova silloge di Cambridge di O. Marucchi»).
Il Martirologio Geronimiano (codice di Berna) colloca la Chiesa di S. Michele non al VII ma al VI miglio.
1139. O in Ortheo. Cf. La Pianta di Roma dell’Anonimo Einsidlense. Dissert. letta dal Prof. C. Huelsen, 21 Aprile 1906, nella Pont. Accad. Romana di Archeologia. — Estratto pagina 28.
1140. Tutti sappiamo che una chiesa dedicata a questa Santa era sotto l’Esquilino. Il ch.o Huelsen, loc. cit., dice che questa chiesa è sconosciuta!
1141. Lib. Pont. Edit. Duchesne, Tom. II, p. 24. Il Grimaldi legge «in Aventino», ed opina sia lo stesso che il monastero di S. Maria in Aventino.
1142. Ediz. Duchesne, Tom. I, p. 262.
1143. Lib. Pont. p. 268, n. 36.
1144. Loc. cit. Tom. II, p. 41 n. 63.
1145. V. G. Starra-Tedde, I boschi sacri, loc. cit.
1146. Cf. il period. «Buonarroti» Tom. V, p. 68.
1147. C. Fontana: L’Anfiteatro Flavio descritto e delineato. Aia 1725.
1148. Marangoni: Delle memorie sacre e profane dell’Anfiteatro Flavio, ecc. Roma 1745, seconda ediz. 1847.
1149. Roma ant. Tom. I, pag. 529 e segg.
1150. Tocco Efisio: Dell’Anf. Flav.... e dei gladiat. Apud Buonarroti, luglio 1869, marzo-aprile 1870.
1151. F. Gori: Le mem. stor. etc. dell’Anf. Fl. Roma 1874.
1152. Iusti Lipsi: De anphitheatro etc.
1153. Degli Anfiteatri.... Verona 1727.
1154. Memoire sur les anciens monuments de Rome: apud Mém. Acad. Inscript. et belles lettres: XXVIII, pag. 486. Voyage en Italie: pag. 346 sg.
1155. L’Anf. Campano illust.... col paragone di tutti gli anfiteatri d’Italia. Napoli 1842.
1156. Edif. di Roma ant. 1851, vol. III, p. 23 seg. vol. IV. Tav. 164-177. Cf. etiam: Archit. Ant. III, s. III. t. 119.
1157. Arvali pag. 225 sg. (Henzen: Arv. CVI).
1158. Osserv. sull’arena e sul podio dell’Anf. Flav. Roma 1813 — Nuove oss. ecc. e dell’acqua che lo ricopre. 1814 — Notiz. degli scavi Roma 1813 — Ammonizioni critico-ant. 1813 — Diss. sulle rovine di Roma, ap. Winckelmann — Storia delle arti, III, 393 seg. — Note al circo di Caracalla del Bianconi.
1159. Delle linee dei sedili apud Efemm. Litt. Roma 1823.
1160. Iscrizioni esistenti sui sedili dei teatri e degli anfiteatri antichi. Ann. Inst. 1856.
1161. Ann. Inst. 1859.
1162. Iscriz. dell’Anf. Flavio, Bull. com. di Roma, 1880 pag. 211. e seg. — Notizie ined. sull’Anf. Flavio, R. Acc. dei Lincei, serie quinta, vol. V, ecc.
1163. Delle tessere.... ed. Labers, Milano 1827.
1164. Archit. numism. Londra 1859.
1165. L’Anfiteatro Flavio rivendicato ai Martiri. Atti della Pont. Acc. Rom. di Archeol. serie II, Tom. VII, 1899. Questo discorso fu probabilmente motivato dalla dissertazione, comparsa anonima, del Delehaye (L’Amphitéâtre Flavien, Bruxelles 1897), nella quale questi sostiene che nessuna fonte attesta essere stato il Colosseo un luogo di martirio pei cristiani.
1166. Antonio Sebastiani.
1167. Nell’archivio capitolino (Cred. 4, tom. 101, pag. 291) v’è un documento che dice: «Anno 1727, 12 Novembre. Istrumento di concessione, per poter affittare l’erbe che nascono dentro al Colosseo».
1168. Flora of the Coloseum of Rome. London, Groombridge and Sons.
1169. F. Gori, loc. cit. pag. 113.
1170. Ann. Inst. 1856.
1171. Bull. della Comm. arch. comun. di Roma 1880.
1172. Inscript. Urb. Romae Latinae. Partis quartae fasciculus posterior. — Additamenta, collegit et edidit Christianus, Huelsen, Berolini, apud Georgium Reimerum, pag. 3199 e segg. MCMII.
1173. Lanciani, loc. cit., p. 244-45.
1174. Dividiamo i frammenti con una linea ed omettiamo i supplementi che si leggono nello stesso Corpus, perchè, o questi sono facili, come ad es.: pl ACIDI — ed ognuno può farli da sè: o sono di difficile interpretazione; e allora è meglio che ognuno faccia i supplementi che creda.
1175. Loc. cit., p. 217.
1176. Huelsen, c. I, l. VI, pars 4 add., p. 3224.
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici.
Le correzioni indicate a pag. 385 (Errata-Corrige) sono state riportate nel testo.
Per trascrivere la lettera "V" sormontata da un accento si è usata la notazione "V´".
Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.